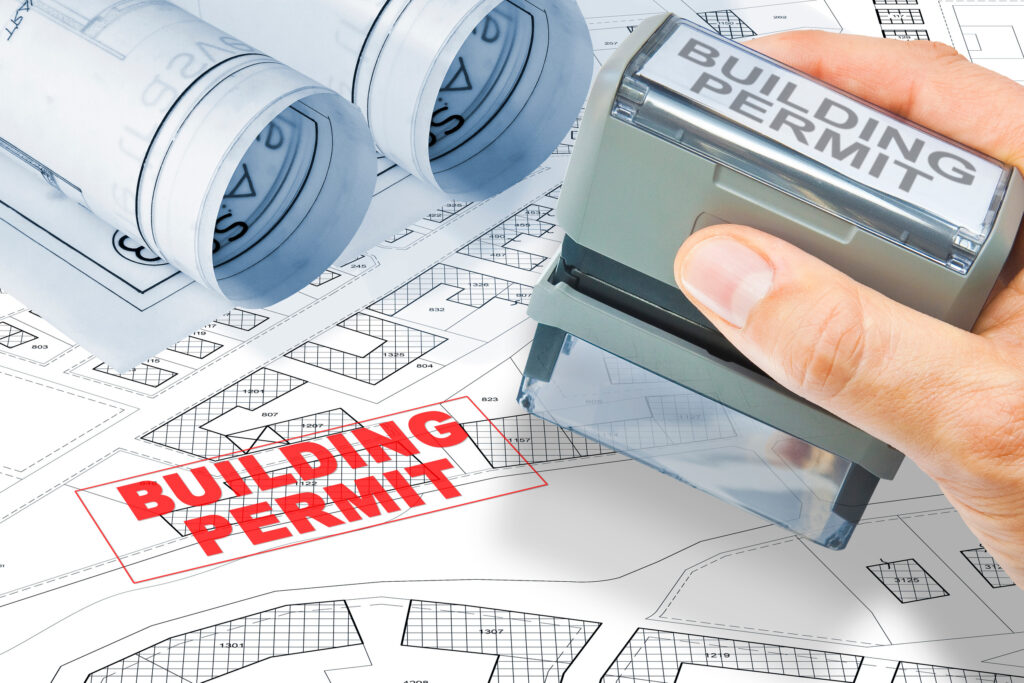Eredità digitale: il decalogo del Notariato Online il decalogo aggiornato del Notariato per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della gestione dei beni digitali
Eredità digitale: online il decalogo del Notariato
Con l’evoluzione tecnologica e la crescente digitalizzazione della vita quotidiana, il concetto di eredità si amplia oltre i beni materiali, includendo asset digitali come account online, criptovalute, contenuti social e archivi cloud. Tuttavia, la normativa in materia di successione digitale rimane incerta e frammentata, rendendo essenziale una pianificazione preventiva.
Per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di gestire il proprio patrimonio digitale, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un decalogo aggiornato, disponibile su www.notariato.it. Questo vademecum sostituisce i documenti diffusi nel 2012 e integra le recenti novità normative.
Cos’è l’eredità digitale?
L’eredità digitale comprende due principali categorie di risorse:
- Offline: file personali, documenti digitali, software acquistati, domini web;
- Online: account di posta elettronica, social network, e-commerce, home banking, wallet di criptovalute.
Pianificare la successione digitale è cruciale, poiché molte piattaforme operano fuori dall’Italia e dall’Unione Europea, rendendo complessa la gestione post mortem in assenza di precise disposizioni.
Cosa non rientra nell’eredità digitale?
Alcuni asset non possono essere trasmessi agli eredi, tra cui:
- Contenuti concessi in licenza (es. account streaming);
- Beni digitali illeciti o piratati;
- Identità digitale e firme elettroniche;
- Password: la loro trasmissione non implica automaticamente la cessione dei diritti sulle risorse collegate.
Strumenti per la gestione dell’eredità digitale
Per garantire un passaggio ordinato dei beni digitali, si possono adottare diverse strategie:
- Mandato post mortem: permette di affidare a una persona di fiducia le credenziali di accesso con istruzioni specifiche su gestione o cancellazione dei dati;
- Testamento digitale: metodo più sicuro per disporre dei propri asset digitali, con valore legale per risorse di rilievo economico e personale;
- Designazione di un contatto erede: alcune piattaforme consentono di nominare un referente che gestisca l’account in caso di decesso.
Decalogo Notariato per l’eredità digitale
- Assenza di una normativa specifica: pianificare l’eredità digitale è fondamentale per evitare complicazioni.
- Le password non fanno parte dell’eredità: devono essere custodite e aggiornate regolarmente.
- Utilizzo del mandato post mortem: si possono affidare credenziali a una persona di fiducia con istruzioni precise.
- Affidare una password non equivale a trasmettere la proprietà dei beni digitali.
- Alcuni beni digitali non sono trasmissibili: contenuti in licenza, firme elettroniche, identità digitale.
- Le criptovalute sono beni digitali con valore economico e vanno trattate come asset patrimoniali.
- I conti online sono equiparabili ai conti bancari tradizionali, gli eredi possono reclamarne il contenuto.
- Possibili controversie internazionali: le piattaforme online hanno spesso sede all’estero, creando ostacoli legali.
- Verificare le policy delle piattaforme: alcune consentono la nomina di un erede digitale, altre prevedono la cancellazione automatica dell’account.
- Consultare un notaio di fiducia per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.