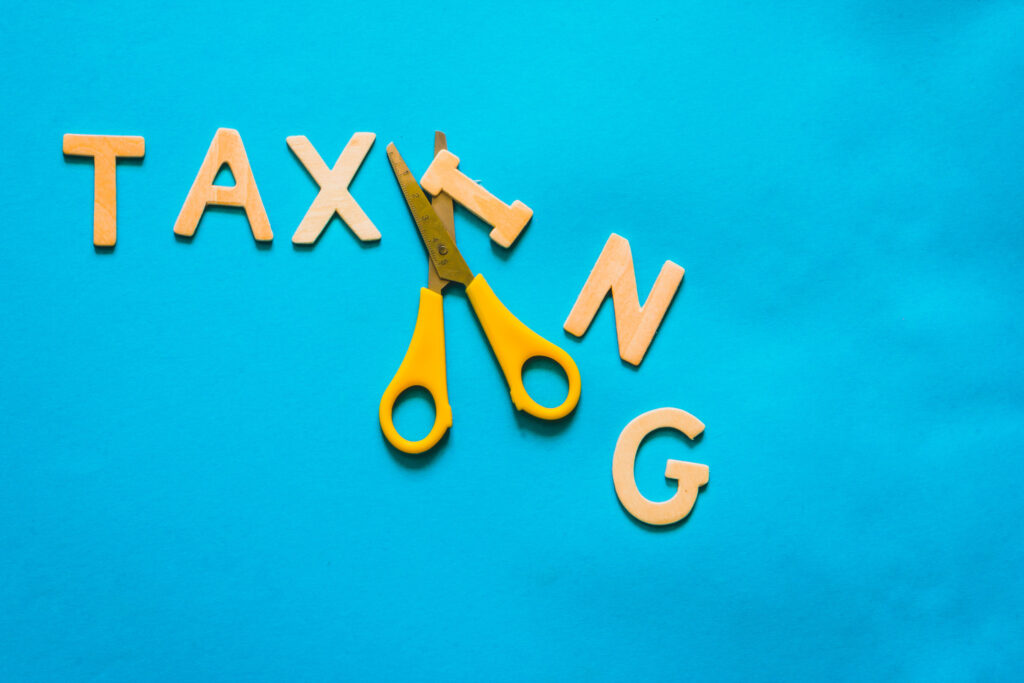Cuneo fiscale: le novità della manovra 2025 Cuneo fiscale: le novità più importanti della manovra di bilancio 2025 che impattano in vari modi sul costo del lavoro
Legge di Bilancio 2025: le novità sul cuneo fiscale
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche al cuneo fiscale, riducendo la distanza tra il costo del lavoro e il reddito netto percepito dai lavoratori. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 nei primi commi dell’articolo 1 in parte conferma e in parte innova alcune misure già sperimentate nel 2024, con effetti significativi sulla tassazione e sui benefici fiscali.
Revisione delle aliquote IRPEF
Dal 1° gennaio 2025, le aliquote IRPEF, in base alla previsione contenuta nel comma 2, art. 1 della legge di bilancio, sono riorganizzate in tre scaglioni di reddito:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.
Questa struttura conferma, con modifiche minime, quanto già previsto nel 2024. Le nuove aliquote mirano a semplificare il sistema fiscale e ridurre l’impatto per i redditi medio-bassi.
Aumento della detrazione minima
La detrazione minima prevista dall’art. 13 del TUIR sale da 1.880 euro a 1.955 euro. Questo incremento, sperimentato nel 2024, diventa quindi strutturale nel 2025. Nonostante l’aumento, il trattamento integrativo, pari a un massimo di 1.200 euro, continua ad essere riconosciuto per redditi fino a 28.000 euro, in specifiche condizioni.
La nuova “No tax area” si attesta a 8.500 euro. Il trattamento integrativo compensa le situazioni in cui le detrazioni superano l’imposta lorda dovuta, garantendo un’adeguata tutela per i redditi bassi.
Cuneo fiscale: novità su bonus e detrazioni
Al posto dell’esonero contributivo sperimentato nel 2024, in favore dei titolari di reddito derivante dello svolgimento del lavoro dipendente, vengono introdotte due nuove misure:
– Bonus per redditi fino a 20.000 euro, calcolato in percentuale sul reddito di lavoro dipendente:
- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro.
– Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro:
- 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro;
- importo decrescente per redditi tra 32.000 e 40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconoscerà automaticamente queste agevolazioni in busta paga e verificherà la correttezza delle somme e la spettanza delle stesse in sede di conguaglio. Qualora gli importi delle agevolazioni non dovessero spettare i sostituti d’imposta procederanno al recupero, che per somme superiori a 60,00 euro, dovrà avvenire in 10 rate.
Trattamento integrativo speciale e detassazione mance
Il trattamento integrativo speciale previsto dal comma 395 della legge di bilancio 2025 viene confermato per i lavoratori del settore turistico se titolari di reddito non superiore a 40.000 euro in relazione al periodo di imposta 2024.
Per chi lavora in alberghi e ristoranti, il bonus è pari al 15% delle retribuzioni lorde percepite per lavoro straordinario, notturno o festivo nel periodo tra gennaio e settembre 2025. Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito.
La legge, tramite il comma 520, amplia le agevolazioni sulle mance per i lavoratori del comparto turistico e della ristorazione. Le mance, anche elettroniche, saranno tassate con un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 30% del reddito annuo e solo per lavoratori con redditi sotto i 75.000 euro.
Tracciabilità dei rimborsi spese
La legge al comma 81, attraverso la modifica dell’art. 51 TUIR, introduce nuovi obblighi di tracciabilità per i rimborsi spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Tali rimborsi non concorreranno alla formazione del reddito solo se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici o carte elettroniche. Questa norma si applicherà esclusivamente ai rimborsi analitici, escludendo quelli forfettari e chilometrici.
Leggi anche: Legge bilancio 2025: tutte le misure