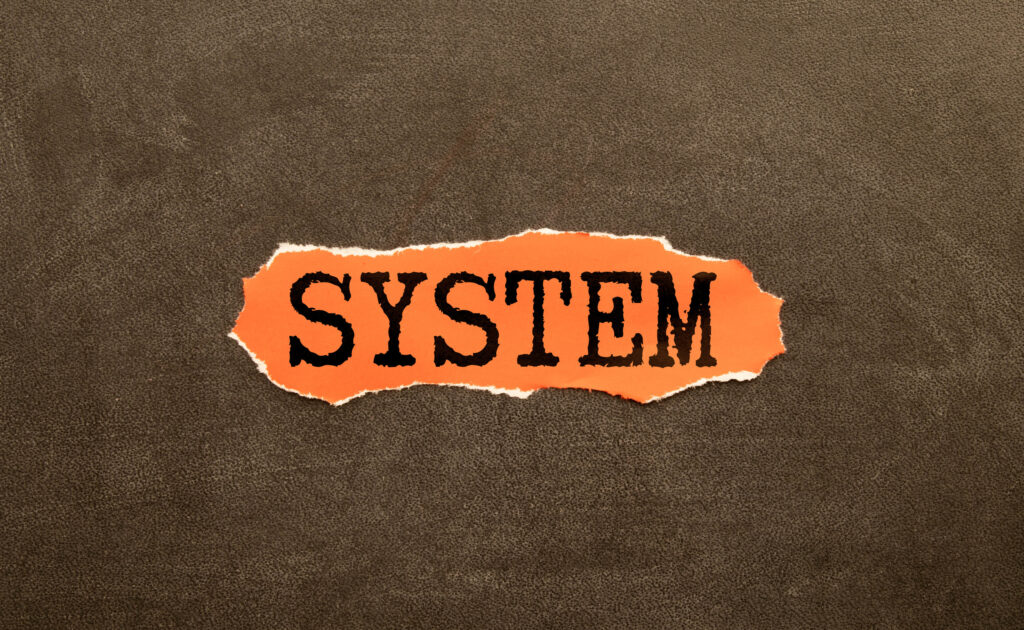Atti paritetici Atti paritetici della PA: definizione, normativa, caratteristiche, giurisprudenza e differenze con i provvedimenti amministrativi
Cosa sono gli atti paritetici
Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione sono atti giuridici che non esprimono un potere autoritativo, ma si pongono su un piano di parità tra l’amministrazione e i destinatari. A differenza dei provvedimenti amministrativi, che impongono unilateralmente obblighi e vincoli, gli atti paritetici si basano su una relazione di tipo negoziale o dichiarativo.
Normativa di riferimento
Gli atti paritetici non trovano una regolamentazione specifica in un’unica norma, ma si inseriscono nel più ampio contesto del diritto amministrativo, regolato da:
- Legge n. 241/1990 – Principi generali dell’azione amministrativa;
- Codice Civile, per quanto riguarda gli atti negoziali della P.A.;
- Giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito il confine tra atti autoritativi e atti paritetici.
Caratteristiche
Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione si distinguono per le seguenti caratteristiche:
- Mancanza di autoritatività: non impongono obblighi o vincoli unilaterali ai destinatari;
- Posizione di parità tra amministrazione e soggetti privati;
- Possibilità di impugnazione solo se l’atto produce effetti lesivi per il destinatario;
- Ricorso a strumenti di diritto civile, come i contratti.
Giurisprudenza di rilievo
Di seguito alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato in materia:
Consiglio di Stato n.1388/1996: nell’ambito delle sanatorie edilizie, si distingue tra la natura regolamentare degli atti che stabiliscono i criteri generali per calcolare l’oblazione e i contributi, e la natura paritetica degli atti con cui il Sindaco, applicando tali criteri, determina l’importo dovuto. Solo le contestazioni relative ai criteri generali sono impugnabili come atti regolamentari, mentre tutte le altre controversie riguardanti l’ammontare delle somme dovute rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in relazione a diritti soggettivi, poiché l’Amministrazione agisce come un soggetto privato, limitandosi ad applicare parametri normativi predefiniti.
Consiglio di stato n. 12/2018: la determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione da parte della Pubblica Amministrazione non rappresentano un atto autoritativo, ma l’esercizio di un diritto di credito del Comune legato al rilascio oneroso del permesso di costruire. Questo rapporto obbligatorio, di natura paritetica, è soggetto alla prescrizione decennale. Di conseguenza, non si applicano le norme sull’autotutela amministrativa né le disposizioni relative agli atti autoritativi.
Atti paritetici e provvedimenti: differenze
| Caratteristica | Atti paritetici | Provvedimenti amministrativi |
| Autoritatività | No | Sì |
| Posizione tra le parti | Paritaria | Squilibrata (P.A. superiore) |
| Effetti giuridici | Dichiarativi o negoziali | Impositivi e unilaterali |
| Impugnabilità | Solo se lesivi | Sempre possibile |
Conclusioni
Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione rappresentano quindi strumenti di gestione amministrativa che si differenziano dai provvedimenti autoritativi per la loro natura non impositiva e la posizione di parità tra le parti. Pur non essendo vincolanti in senso unilaterale, giocano un ruolo fondamentale nella regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e privati, garantendo trasparenza e certezza del diritto.
Leggi anche: Atti e provvedimenti amministrativi