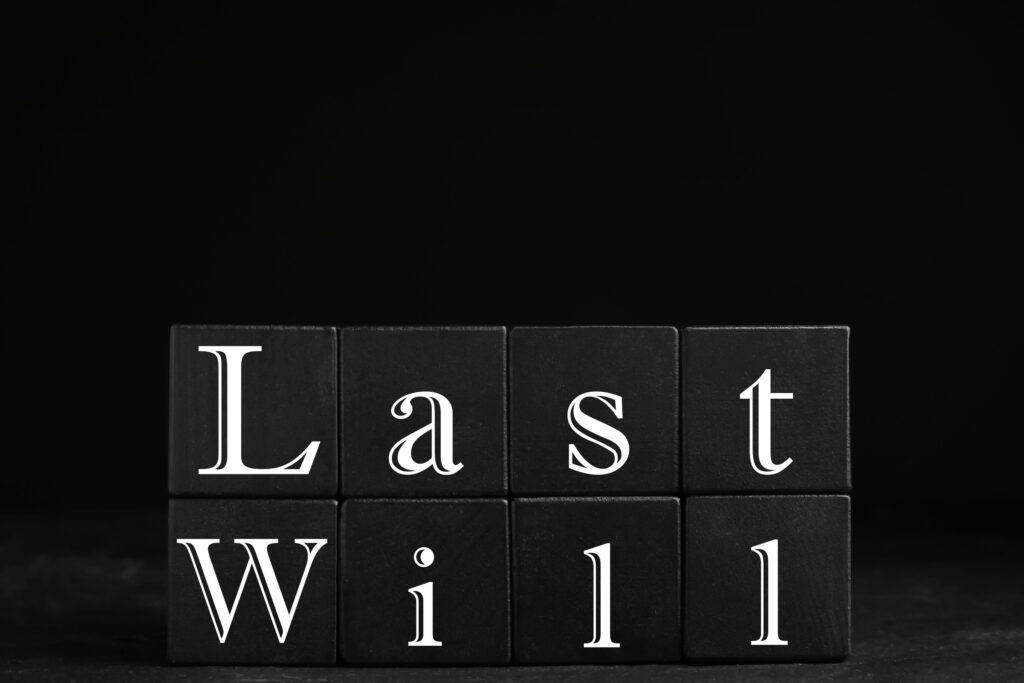Testamento valido anche con monosillabi La Cassazione chiarisce che il testamento è valido anche se ci sono gravi limitazioni motorie ma sussiste la capacità di intendere e di volere
Validità del testamento
Testamento valido anche con monosillabi: la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9534/2025, ha confermato la validità di un testamento pubblico redatto in presenza di un testatore affetto da gravi limitazioni motorie, che si era espresso unicamente attraverso monosillabi e movimenti del capo.
La vicenda
Nel caso esaminato, i fratelli del de cuius avevano contestato il testamento pubblico con cui erano stati istituiti erede universale e legatari i convenuti chiedendo che fosse dichiarata l’invalidità delle disposizioni di ultima volontà per incapacità naturale o per inosservanza delle formalità di redazione del testamento stesso. In corso di causa gli attori proponevano querela di falso, deducendo che il notaio aveva ricevuto le volontà del de cuius in assenza di testi ed aveva falsamente attestato che il testatore non era in grado di firmare l’atto.
Il Tribunale ha respinto tutte le domande con sentenza integralmente confermata in appello. Il giudice distrettuale infatti aveva evidenziato che l’incapacità del de cuius era prevalentemente motoria e non incideva sulla capacità di intendere e di volere. Il testatore era apparso, inoltre, in possesso della facoltà mentali nel corso del giudizio di interdizione, conclusosi con pronuncia di inabilitazione, e all’esame diretto da parte del CTU e dei medici curanti.
La questione approdava innanzi alla Cassazione, la quale tuttavia confermava la correttezza della sentenza impugnata.
La decisione
La S.C. ha chiarito che l’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., “determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi”.
Nella specie, il de cuius era affetto da deficit motorio e dell’espressione verbale, ma capace di intendere e di volere, rispondendo in maniera pertinente alle domande che gli venivano rivolte, mostrando di comprenderne il contenuto e di articolare risposte congruenti.
La circostanza che si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, dunque per i giudici, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le sue condizioni di salute, “caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso così esternato fosse stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi”.