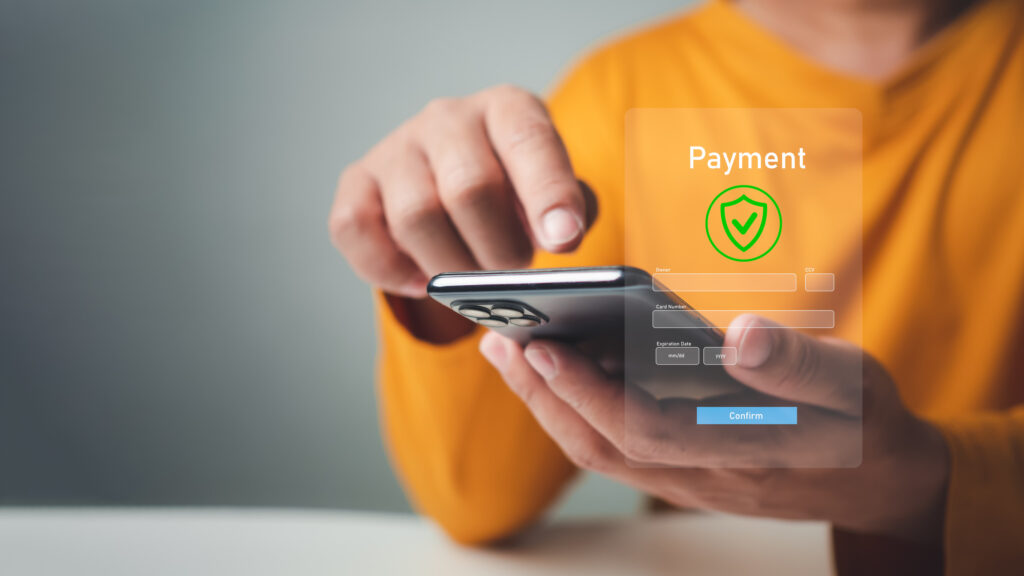Dl infrastrutture 2025
Il Dl infrastrutture 2025 n. 73, convertito dalla legge n. 105/2025 (Testo coordinato pubblicato sulla GU del 19/07/2025) è legge. Il decreto reca misure finalizzate a “garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.”
Il testo si composto da 17 articoli dal contenuto variegato. Vediamo le misure più importanti.
Opere pubbliche e contratti
Modificata e integrata la normativa sulla ripresa dell’attività per la creazione del Ponte di Messina.
Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, il decreto ha istituito un Collegio consultivo tecnico con il compito di prevenire e risolvere rapidamente le dispute tecniche. L’obiettivo è di evitare rallentamenti durante la fase di esecuzione dei lavori.
La Società Stretto di Messina, responsabile della progettazione e realizzazione del ponte che collegherà la Sicilia e il continente, è inserita di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
Introdotto ex novo l’art. 46 bis nel Codice della protezione civile, contenuto nel decreto legislativo n. 1/2018 per disciplinare le procedure di affidamento dei contratti pubblici in occasione delle emergenze.
Modificate infine diverse norme del Codice dei contratti pubblici n. 36/2023.
Trasporti e strade
L’articolo 4 del dl infrastrutture 2025 prevede, in caso di ritardo, un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora (o frazione) che eccede una franchigia di 90 minuti. Questo indennizzo è a carico sia del committente che del caricatore, che ne sono responsabili in solido. L’importo, inoltre, sarà aggiornato ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
L’art. 5 interviene sulla disciplina della Motorizzazione civile con il fine di migliorane la sicurezza gestionale e informatica.
Dal 2027 al 2041 vengono autorizzate diverse spese per le attività necessarie all’affidamento del contratto Intercity. Spese autorizzate anche per la Gestione governativa della ferrovia Circumetnea.
Diventa facoltativa la scelta di fissare livelli massimi delle tariffe da parte delle compagnie aeree nei confronti di certi passeggeri, per evitare il rialzo dei prezzi.
Previsti interventi di riparazione delle reti stradali di interesse nazionale di competenza dell’ANAS presenti nelle zone alluvionate e terremotate dell’Emilia, delle Marche e della Toscana.
Dl infrastrutture 2025: novità autovelox
Previsto il censimento degli autovelox in uso. Il comma 3 bis dell’articolo 5 si propone di individuare il numero degli autovelox effettivamente in uso, individuare quelli non conformi e comprendere quale impatto hanno sulla sicurezza dei cittadini le nuove regole che riguardano l’omologazione di questi strumenti.
Concessioni demaniali e mare
Disposto l’aggiornamento dei canoni per le concessioni balneari mediante l’indice dei prezzi della produzione industriale in assenza “della produzione e diffusione dell’indice da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”
La Commissione tecnico-consultiva competente opererà presso l’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque.
Si autorizzano in favore della società RAM le spese necessarie per l’economia del mare, per il trasporto marittimo e fluviale e per l’assunzione di nuovo personale.
Concessioni autostradali
L’Articolo 11 modifica la legge sulle concessioni autostradali (L. 193/2024) per:
- chiarire il valore di subentro;
- obbligare all’adeguamento;
- rinviare al sistema tariffario ART;
- permettere lavori transitori;
- armonizzare le procedure.
Dl infrastrutture 2025: energie rinnovabili
L’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 190/2024 (TU FER) modifica la normativa sulle aree per impianti a energie rinnovabili (FER), in particolare quelle di accelerazione, per allinearsi alle direttive europee.
Misure per lo sport
L’amministratore delegato della società infrastrutture Milano Cortina rivestirà il ruolo di commissario straordinario per l’esecuzione di alcuni interventi necessari allo svolgimento di Giochi Olimpici 2026.
Per il 2025 è previsto lo stanziamento di 5, 25 milioni di euro per la Federazione Sportiva nazionale – ACI.
Leggi anche gli altri articoli di diritto amministrativo