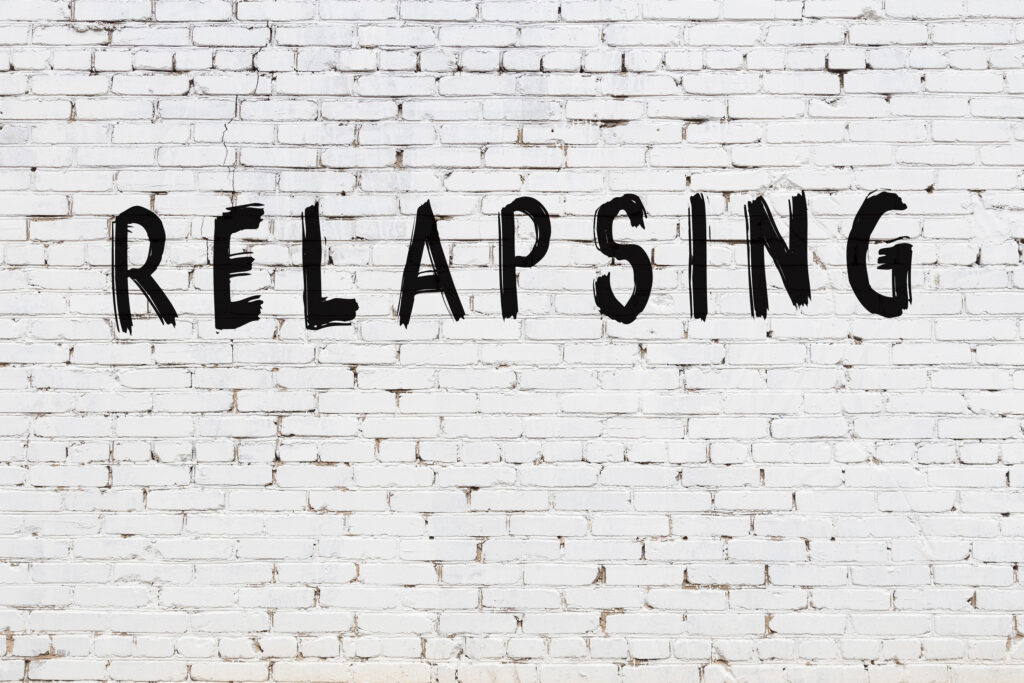Recidiva semplice: la Consulta limita aumento automatico pena Stop all’aumento automatico della pena per recidiva semplice. La Consulta dichiara incostituzionale l’art. 63 co. 3 c.p. in caso di concorso con attenuanti
Recidiva: l’intervento della Consulta
Con la sentenza n. 74 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 63, comma 3, del codice penale, nella parte in cui consente l’aumento obbligatorio di un terzo della pena in presenza di recidiva semplice e di un’altra circostanza aggravante autonoma o a effetto speciale.
Automatismo irragionevole
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, in un procedimento per minaccia aggravata commessa con armi, dove all’imputato era stata contestata anche la recidiva semplice ai sensi dell’art. 99, primo comma, c.p. In base alla norma censurata, la pena – già aumentata per l’aggravante a effetto speciale – avrebbe dovuto essere automaticamente incrementata di un terzo per effetto della recidiva.
La Consulta ha invece affermato che tale automatismo viola il principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’articolo 3 della Costituzione, evidenziando come l’aumento obbligatorio della pena, previsto per la recidiva semplice, risulti più gravoso rispetto alla disciplina più favorevole applicabile nei casi di recidiva aggravata o qualificata, che consente al giudice di aumentare la pena solo fino alla metà e in via facoltativa.
Le motivazioni della Corte costituzionale
Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della politica criminale e nella determinazione delle pene, la Corte ha ribadito che le norme sanzionatorie devono comunque essere sottoposte al controllo di legittimità costituzionale, specialmente quando incidono sulla libertà personale.
Secondo la Corte, la disciplina censurata determinava un trattamento sanzionatorio sproporzionato e non coerente con il disvalore effettivo della condotta. In particolare, si veniva a creare una irragionevole disparità: mentre in presenza di recidiva aggravata il giudice può decidere se aumentare la pena, nel caso di recidiva semplice tale aumento era obbligatorio, anche se la condotta non era più grave.