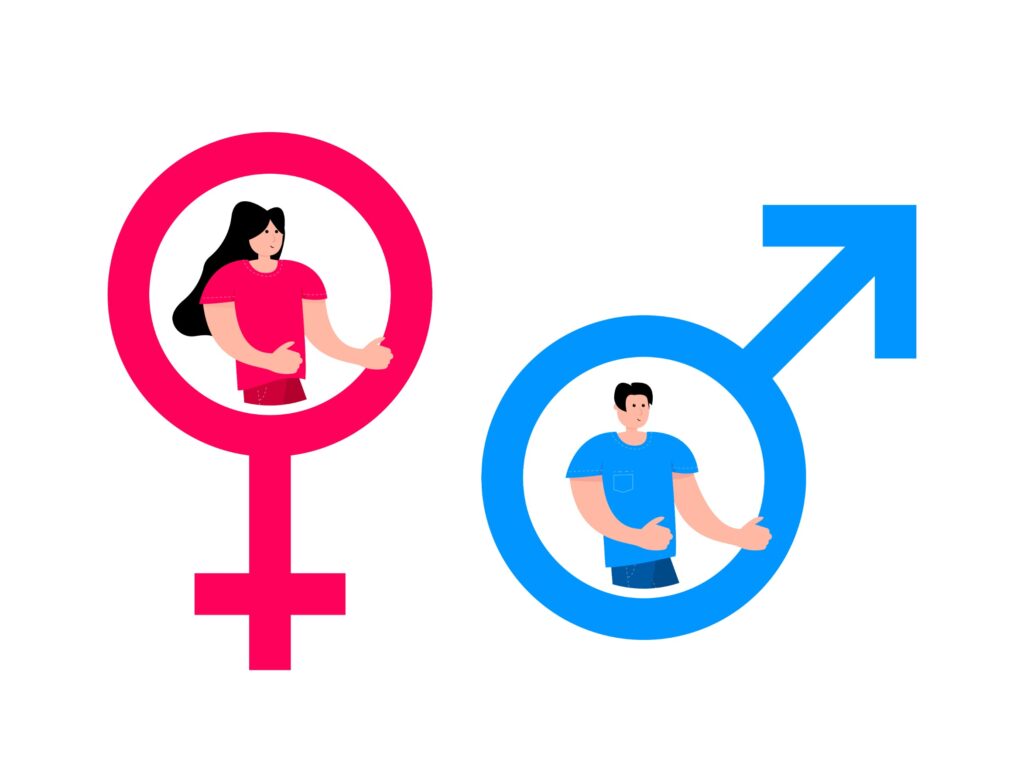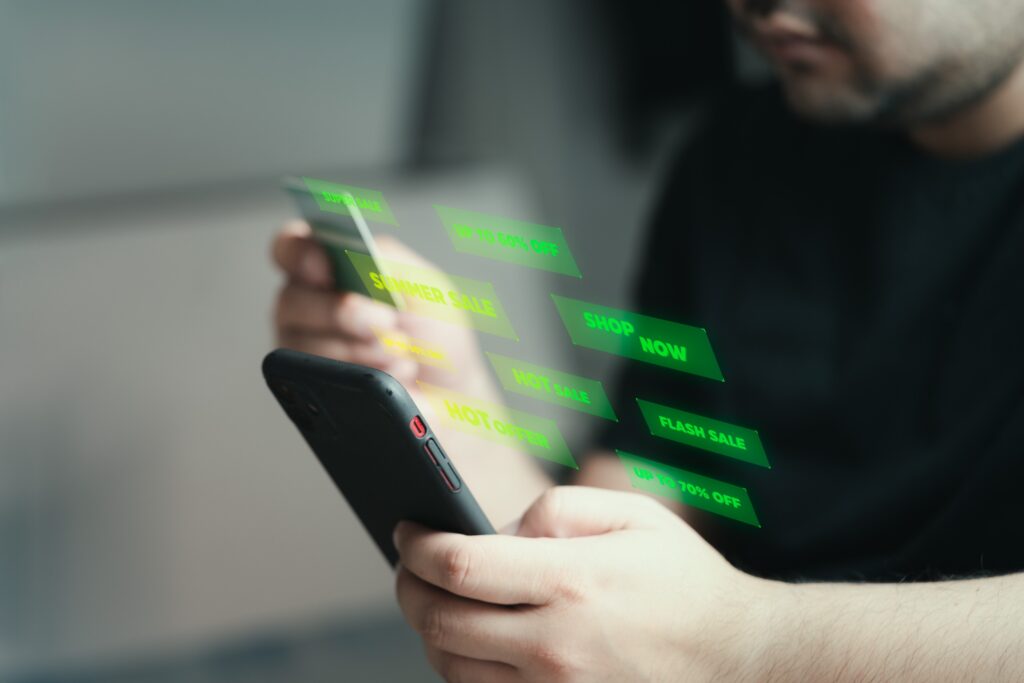Cambio di sesso: il matrimonio non va annullato Cambio sesso: negato l'annullamento del matrimonio per errore essenziale sull'identità del coniuge, è solo un adeguamento alla personalità
Cambio di sesso e annullamento del matrimonio
Il cambio di sesso non causa l’annullamento del matrimonio. Nel soggetto che presenta una disforia di genere questo cambiamento non muta l’identità. Esso si limita ad adeguare i caratteri esterni a quelli percepiti e sentiti come propri dalla persona. Se il marito non è a conoscenza della rettificazione di sesso da uomo a donna, questa mancata conoscenza non si può ricondurre a un errore essenziale sull’identità della persona, se l’uomo non ha mai approfondito le cause dell’incapacità a procreare della moglie. Questa la decisione del Tribunale di Livorno nella sentenza del 12 luglio scorso.
Cambio sesso da uomo a donna: marito chiede annullamento
Un uomo si rivolge al Tribunale di Livorno per chiedere l’annullamento del matrimonio. L’attore narra di aver contratto matrimonio civile con la convenuta e che da detta unione non sono nati i figli. Questo perché, in base a quanto riferito dalla moglie, la stessa avrebbe subito l’asportazione dell’utero a causa di una malattia. L’attore racconta poi che dopo la richiesta di adozione di un minore la coppia è entrata in crisi tanto che si sono separati.
Nel giugno del 2022, però, mentre il marito procedeva a un’ispezione ipotecaria e catastale degli immobili intestati alla moglie, scopriva che la stessa in passato era un uomo. I riferiti problemi di infertilità sono quindi da ricondurre a questa circostanza.
Errore sull’identità del coniuge art. 122 c.c.
L’uomo sarebbe quindi incorso in quell’errore essenziale sull’identità della persona che ai sensi dell’articolo 122 del codice civile rende annullabile il matrimonio. Se infatti l’attore avesse saputo fin dall’inizio che la moglie in passato era stato un uomo e che le difficoltà a procreare erano riconducibili al cambio di sesso, sicuramente non si sarebbe sposato.
Costituitasi in giudizio la moglie chiede il rigetto della domanda attorea, stante l’impossibilità di ricondurre il loro caso all’errore invocato dal marito di cui all’articolo 122 del codice civile. La donna afferma infatti che l’attore era al corrente, prima di contrarre matrimonio, del procedimento di rettificazione di sesso a cui si era sottoposta.
Errore sull’identità della persona se il marito sposa una donna che prima era uomo?
Il Tribunale, conclusa l’istruttoria ritiene che la domanda dell’attore debba essere rigettata. Nel caso di specie è emerso che l’attore in realtà non era stato informato dell’avvenuta rettificazione di sesso della moglie. Vero però che tale mancata conoscenza non è riconducibili giuridicamente all’errore previsto dall’articolo 122 del codice civile. L’uomo infatti, da parte sua, non ha mai approfondito le vere cause dell’incapacità a procreare della convenuta. L’errore eccepito dal marito non ricade né sull’identità della persona né sulle sue qualità personali.
“Non vi è stato errore sulla identità della persona in quanto il (…) a tutti gli effetti, si è unito in matrimonio con la persona che intendeva e riteneva di sposare (….), che all’epoca già risultava donna, tanto anagraficamente quanto sotto l’aspetto dei caratteri sessuali (…) l’identità (di genere) della (moglie) si è sempre identificata con quella femminile e non con quella maschile, tanto che, la stessa (…) in modo particolarmente significativo” in una conversazione telefonica … “per più di una volta, nel rispondere alle domande incalzanti del (marito) relative al fatto se fosse o se fosse stata in passato un uomo, ha ribadito “io non sono un uomo”, “io non ero un uomo”.
Il cambio di sesso infatti non modifica l’identità sessuale della persona, ma adegua i caratteri somatici e le risultanze anagrafiche alla identità reale dell’individuo.
Il marito quindi non è caduto in alcun errore essenziale sulle qualità personali del coniuge, per cui la richiesta di annullamento del matrimonio va rigettata.
Leggi anche: Cambio di sesso, tutele unione civile estese fino al matrimonio