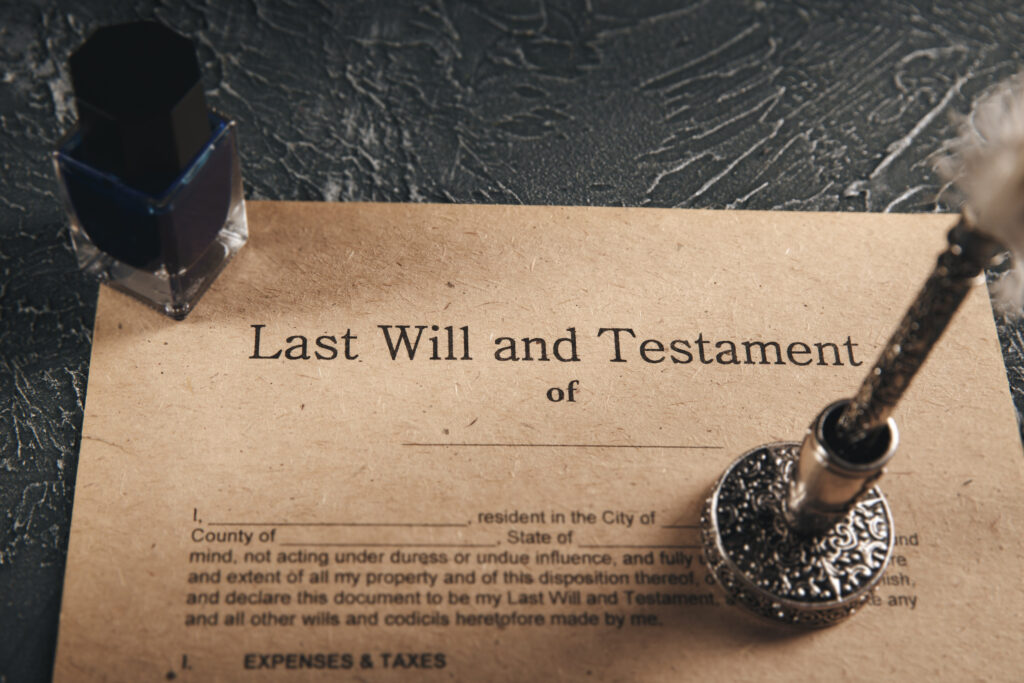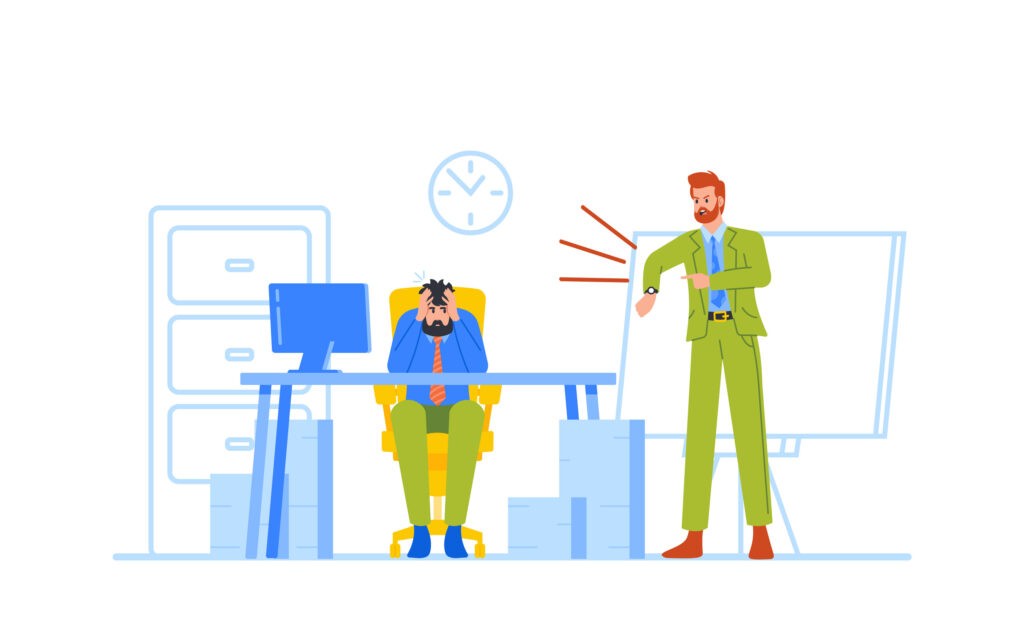Incapacità di testare Incapacità di testare: cos’è, in quali casi è presente, effetti e cosa prevede l’art. 591 del codice civile
Cos’è l’incapacità di testare?
L’incapacità di testare è una condizione giuridica che impedisce a una persona di disporre del proprio patrimonio tramite testamento. Il Codice Civile, all’articolo 591, disciplina i casi in cui un soggetto non può redigere un testamento valido, garantendo la tutela degli interessi degli eredi e della volontà testamentaria.
L’incapacità di testare si verifica quando un soggetto non è in grado, per legge o per condizioni personali, di esprimere una volontà testamentaria valida. Il testamento redatto da un soggetto incapace può essere pertanto impugnato da chiunque vi abbia interesse, nel termine di prescrizione di 5 anni che dicono dal momento in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Casi di incapacità di testare previsti dall’art. 591 c.c.
L’art. 591 c.c individua tre categorie principali di soggetti incapaci di testare:
1. Minori di età
I minori di 18 anni non possono fare testamento, anche se emancipati. La ratio della norma è che i minori non abbiano la maturità sufficiente per disporre consapevolmente del proprio patrimonio.
2. Interdetti per infermità di mente
Le persone dichiarate interdette giudizialmente a causa di una grave patologia mentale non possono testare. L’interdizione viene pronunciata dal tribunale e comporta la totale incapacità legale di agire.
3. Incapaci di intendere e di volere al momento del testamento
Anche se una persona non è formalmente interdetta, il testamento può essere impugnato se il testatore, al momento della redazione, si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere dovuto, ad esempio, a:
- malattie psichiatriche;
- intossicazione da farmaci o sostanze stupefacenti;
- grave infermità fisica che comprometta la lucidità mentale.
Effetti della dichiarazione di incapacità di testare
Se viene accertata l’incapacità del testatore, il testamento può essere dichiarato nullo su richiesta di chiunque vi abbia interesse (eredi legittimi o altri aventi diritto). La nullità comporta:
- l’invalidità delle disposizioni testamentarie;
- il ritorno all’eredità secondo le regole della successione legittima;
- l’esclusione degli eredi nominati nel testamento invalido.
Giurisprudenza sull’incapacità di testare
Cassazione n. 9534/2025: Il fatto che una persona si esprima a monosillabi o con gesti del capo non invalida il testamento, a patto che queste siano le uniche modalità di comunicazione possibili a causa di un deficit motorio che non compromette la sua capacità di intendere e di volere, né la possibilità di esprimere in modo comprensibile le sue intenzioni. Non si può negare la validità di un consenso manifestato in questo modo, né contestare l’autenticità e la completezza dell’espressione di volontà, soprattutto se il giudice ha riscontrato queste condizioni in concreto e la sua motivazione è priva di vizi.
Corte Appello Milano n. 2731/2024: Anche senza una documentazione medica chiara e lineare che attesti le condizioni mentali del testatore, per annullare un testamento ai sensi dell’articolo 591, comma 3, del codice civile, l’incapacità del defunto può essere desunta dal contenuto del testamento stesso e, in particolare, dalle modalità con cui è stato redatto
Cassazione n. 42124/2021: Quando si tratta di dimostrare l’incapacità di un testatore al momento della stesura del testamento, l’articolo 591, comma 2, n. 3, del codice civile stabilisce che tale incapacità deve essere provata proprio in quel momento specifico. Tuttavia, questa norma non significa che le prove debbano limitarsi esclusivamente a quel frangente. Al contrario, il giudice può considerare le condizioni mentali del testatore sia prima che dopo la redazione del testamento, utilizzando queste informazioni come base per una presunzione. In definitiva, l’incapacità può essere dimostrata attraverso qualsiasi mezzo di prova disponibile.
Leggi anche gli altri articoli che si occupano del testamento