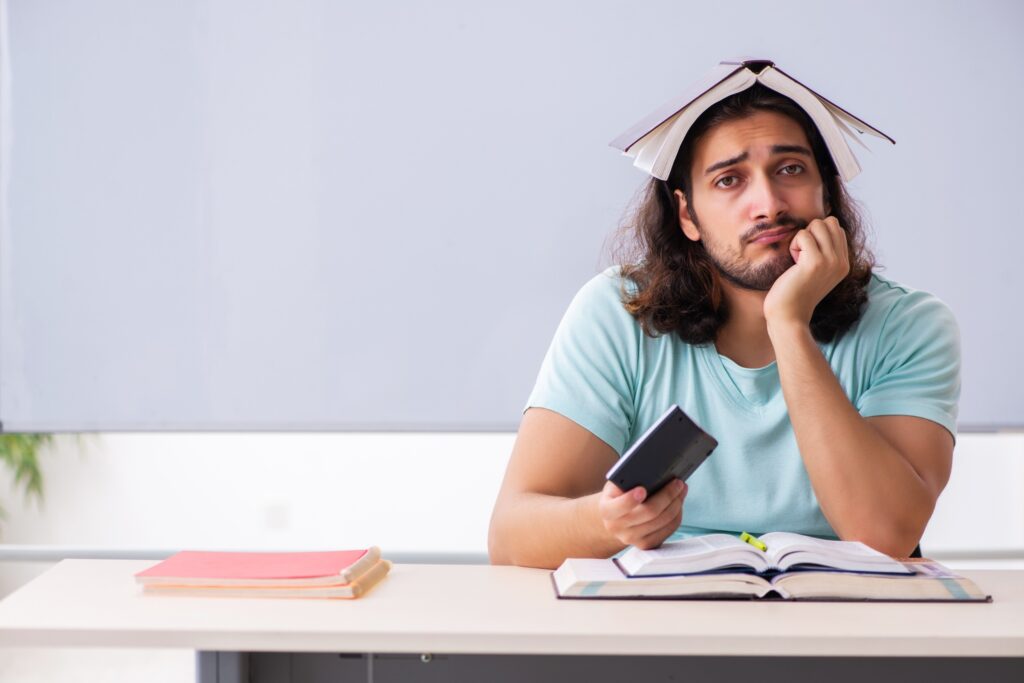Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis, Maurizio Della Ventura e Federica Florio
La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1979, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. – Cass., Sez. Un., 7 marzo 2024, n. 6229.
La vicenda è quella di due ex coniugi, uno dei quali si è visto riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, L. 898/1970, mentre l’altro aveva conseguito somme a titolo di indennità di fine rapporto (a cui si riferisce l’art. 12bis della legge citata) e di incentivo all’esodo. Più nello specifico, il giudizio di primo grado fra le due parti si era concluso nel senso del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, il cui importo è stato però determinato tenendo conto del solo trattamento di fine rapporto. La pronuncia veniva confermata in appello, con un discostamento da un precedente di legittimità favorevole a riferire il menzionato art. 12bis anche all’incentivo all’esodo (Cass. 12 luglio 2016, n. 14171). Si è quindi ricorso in Cassazione, con successiva rimessione alle Sezioni Unite.
È opportuno, preliminarmente, prendere le mosse dall’analisi del dato normativo. L’art. 12bis, L. 898/1970 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e se titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della medesima, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, anche se maturata dopo la sentenza. Tale indennità è pari al 40% dell’indennità riferibile agli anni di coincidenza fra rapporto di lavoro e matrimonio.
L’incentivo all’esodo, invece, è la prestazione cui è tenuto il datore di lavoro a fronte della disponibilità del lavoratore ad addivenire allo scioglimento anticipato del rapporto di prestazione d’opera, oggetto di accordo negoziale.
Si evidenzia l’esistenza di un contrasto, relativo alla natura dell’incentivo all’esodo e, in conseguenza, della riferibilità ad esso dell’art. 12bis (testualmente riferito solo all’indennità di fine rapporto).
Per un primo orientamento, infatti, la menzionata norma sarebbe riferita a ogni indennità di natura retributiva, comunque ricollegabile all’apporto fattuale indiretto del coniuge percettore dell’assegno divorzile, e derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro svolto in costanza di matrimonio. Le somme erogate a tale titolo costituirebbero reddito da lavoro dipendente, in quanto finalizzate a sollecitare e remunerare una vera e propria controprestazione, consistente nel consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata. A sostegno di tale soluzione si evidenzia altresì la parificazione, da parte del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 17 e 19, D.P.R. 917/1986), delle discipline del trattamento di fine rapporto e dell’incentivo (Cass. 12 luglio 2016, n. 14171).
Per un secondo orientamento, invece, l’art. 12bis farebbe riferimento all’indennità menzionata ed unicamente ad essa. Sarebbe riferito, più nello specifico, all’indennità – comunque denominata – che maturi alla cessazione del rapporto di lavoro e che sia determinata in proporzione alla durata dello stesso e all’entità della retribuzione corrisposta (Cass. 17 aprile 1997, n. 3294).
L’indennità di fine rapporto non è più determinata in base all’ultima retribuzione del prestatore, ma sui compensi tempo per tempo erogatigli e periodicamente rivalutati: in sintesi, si tratta di un compenso ancorato allo sviluppo economico della carriera, e gli è comunemente riconosciuta la natura di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8 gennaio 2016, n. 164 e Cass. 14 maggio 2013, n. 11479). Tenendo presente ciò, si rende ben evidente la ratio dell’art. 12bis, L. 898/1970, che ha le stesse finalità – assistenziale e perequativo-compensativa – dell’assegno divorzile: in base al principio di solidarietà, si riconosce un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tener conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287). Si deve, cioè, far sì di appianare la condizione di squilibrio riconducibile al sacrificio di aspettative professionali e reddituali, conseguente all’assunzione di un ruolo all’interno della famiglia. La ratio solidaristica e assistenziale dell’art. 12bis viene evidenziata, peraltro, anche nei relativi lavori parlamentari, ed altresì dalla Consulta (Corte cost. 24 gennaio 1991, n. 24). Si attua una partecipazione, posticipata, che realizza non solo una funzione assistenziale, ma anche una compensativa, ovvero è rapportata al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. 30 dicembre 2005, n. 28278).
L’automatismo percentuale di cui all’art. 12bis, rilevano le Sezioni Unite in commento, si giustifica solo in base alla condivisione della medesima ratio dell’assegno divorzile. D’altronde, ciò a cui si partecipa in base all’art. 12bis è una porzione reddituale maturata nel corso del rapporto e accantonata periodicamente, che diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto: si tratta, quindi, di un incremento conseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che si è sacrificato. È quindi assai significativo, in tal senso, il riferimento agli anni in cui il rapporto è coinciso con il matrimonio (art. 12bis, comma 2).
Tale digressione è necessaria giacché, evidenziata la ratio dell’art. 12bis, si pone il problema del se esso si riferisca unicamente all’indennità di fine rapporto, o abbia oggetto più ampio. Invero, non si ha perfetta coincidenza con l’art. 2120 c.c. (che riguarda il trattamento di fine rapporto), e da ciò viene evinto un campo di applicazione dell’art. 12bis che è più ampio. La parziale coincidenza lessicale, osserva però la Suprema Corte, deve far propendere per l’interpretazione per cui l’art. 12bis non si riferisce a tutte le prestazioni a cui il lavoratore ha diritto in dipendenza della cessazione del contratto, ma solo a quelle che condividono la logica del trattamento di fine rapporto. L’art. 12bis, cioè, si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e sono determinate proporzionalmente alla sua durata e all’entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309). È, questo, il criterio discretivo fra ciò che il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile può e non può esigere ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1970.
Ciò posto, è evidentemente estranea all’indicata nozione di indennità di fine rapporto anche l’indennità di incentivo all’esodo. Tale indennità, infatti, non opera quale retribuzione differita, sicché è da escludere la necessità di farne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sottoforma di assegno divorzile (Cass.17 aprile 1997, n. 3294). Tale indennità non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, e quindi non ricorre l’esigenza di assicurare (in chiave assistenziale e perequativo-compensativa) una ripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio: si è, piuttosto, innanzi a un’attribuzione patrimoniale che discende da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniuge lavoratore prestato consenso all’anticipato scioglimento del rapporto di lavoro.
Non vengono ritenuti dirimenti, inoltre, gli argomenti basati sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a cui si è accennato (Cass. 12 luglio 2067, n. 14171): la Suprema Corte, infatti, ritiene che il regime fiscale dell’indennità non interferisca con la qualificazione civilistica della stessa.
Le Sezioni Unite, per ciò, concludono nel senso della non spettanza al coniuge divorziato della quota del 40% dell’indennità in questione, nei termini riportati in massima.
*Contributo in tema di “Assegno divorzile”, a cura di Umberto De Rasis, Maurizio Della Ventura e Federica Florio, estratto da Obiettivo Magistrato n. 76 / Luglio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica