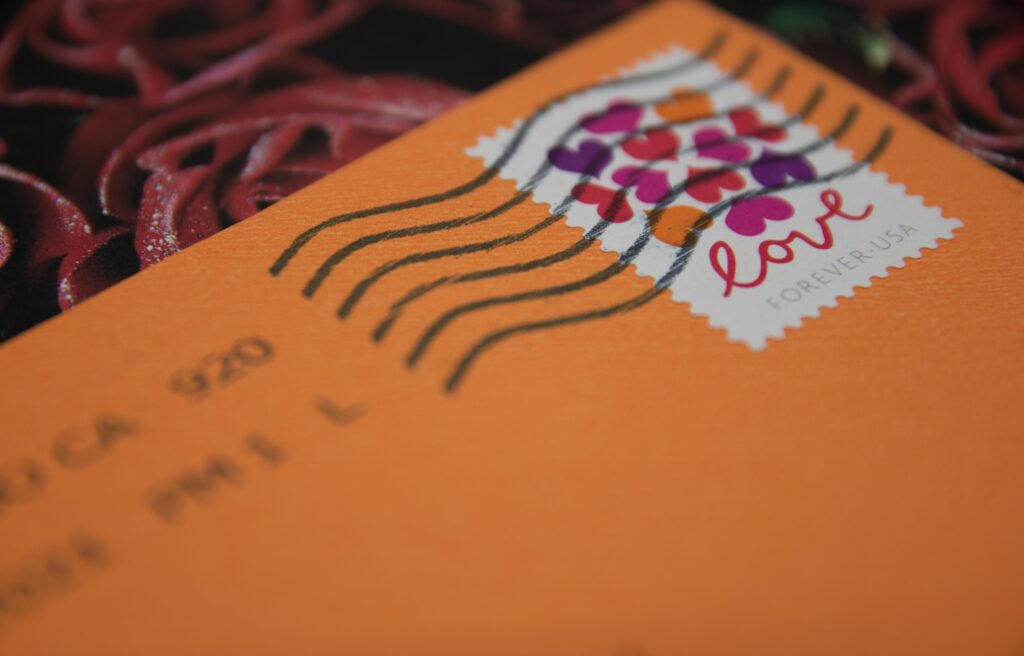Iva e accise dal 1° ottobre al tribunale UE Il Tribunale dell'Unione europea diventa competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in sei materie specifiche tra cui Iva e accise
Tribunale UE nuove competenze
Iva e accise sono tra le materie che il tribunale dell’Unione europea sarà competente a conoscere dal prossimo ottobre. L’attuazione di tale trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al tribunale si inserisce nel solco della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea e riguarderà le questioni pregiudiziali sollevate a partire dal 1º ottobre 2024.
Una modifica sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicata il 12 agosto 2024 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che entrerà in vigore il 1º settembre.
La modifica sarà applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2024.
Sei materie specifiche
Tale trasferimento riguarda sei materie specifiche: il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
La modifica dello statuto prevede peraltro un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni a partire dal 1º settembre 2024.
Obiettivi della riforma
La riforma mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore pregiudiziale e a consentirle di continuare a svolgere, in tempi ragionevoli, il compito assegnatole: garantire il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.
Nel 2001 gli autori del trattato di Nizza avevano previsto la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di talune domande di pronuncia pregiudiziale, senza che, da allora, lo statuto venisse adattato a tal fine. Tuttavia, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento strutturale e significativo del contenzioso. Tale evoluzione è stata accompagnata da un aumento della complessità e della delicatezza delle cause riguardanti, in particolare, questioni di natura costituzionale o collegate ai diritti fondamentali.
La riforma consentirà alla Corte di giustizia di concentrarsi sui suoi compiti di tutela e rafforzamento dell’unità e coerenza del diritto dell’Unione.
Da parte sua, il Tribunale è in grado di assorbire tale carico di lavoro supplementare e tratterà le questioni pregiudiziali che gli saranno trasmesse in modo da offrire ai giudici nazionali e agli interessati le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia.
Le tre parti della riforma
La riforma si articola sostanzialmente in tre parti, le cui grandi linee sono:
Trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale
La prima parte della riforma riguarda il trasferimento della competenza a pronunciarsi in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, il quale è dotato di due giudici per Stato membro. Per motivi di certezza del diritto, il trasferimento riguarda solo sei materie chiaramente circoscritte, sufficientemente distinguibili da altre materie e che hanno consentito lo sviluppo di una consistente giurisprudenza della Corte di giustizia.
Sviluppi applicabili a tutte le cause pregiudiziali
Una seconda parte della riforma comporta due evoluzioni previste dal regolamento di modifica dello statuto, che si applicheranno a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, indipendentemente dalla materia interessata e dalla questione del loro eventuale trasferimento al Tribunale.
In primo luogo, come già avviene per tutti gli Stati membri e per la Commissione, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale saranno d’ora in poi notificate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea affinché essi possano determinare se abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendano, di conseguenza, esercitare il loro diritto di depositare memorie od osservazioni scritte.
In secondo luogo, per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, si prevede che, in tutte le cause pregiudiziali, le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato di cui all’articolo 23 dello statuto siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che detto interessato non si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni.
Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni
La terza parte della riforma mira a preservare l’efficacia del procedimento di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale, visto l’elevato numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia. Per consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano importanti questioni di diritto, la procedura di Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione è estesa ad altre decisioni emesse dal Tribunale. La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia riguarda le impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo o organismo dell’Unione, e poi da parte del Tribunale. Attualmente tale procedura riguarda le decisioni emesse da quattro commissioni di ricorso, menzionate nell’articolo 58 bis dello statuto, e successivamente contestate dinanzi al Tribunale. Con la modifica dello statuto che entrerà in vigore il 1º settembre, sei nuove commissioni di ricorso indipendenti si aggiungono alle quattro attuali, portando il loro numero totale a dieci.
Le estensioni della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni si applicheranno a decorrere dal 1º settembre 2024.