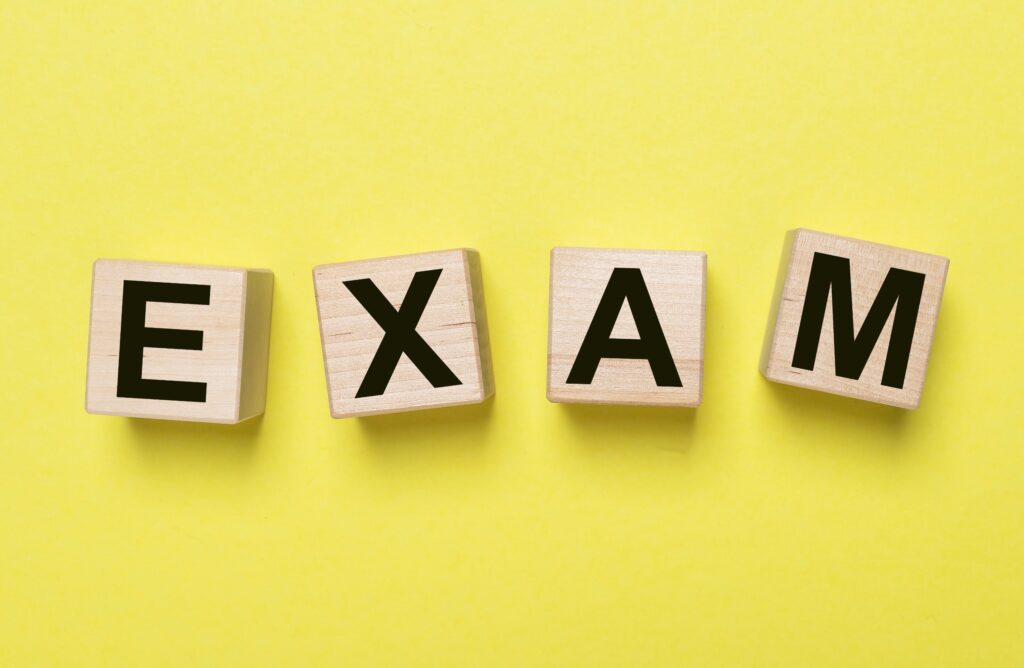Danno biologico Cos’è il danno biologico e in quale modo si provvede al suo risarcimento. Le tabelle dei tribunali e la disciplina prevista dal Codice delle assicurazioni
Cos’è il danno biologico
Per danno biologico si intende il danno non patrimoniale che deriva dalla lesione dell’integrità fisica o psichica che comprometta, anche in modo lieve, il modo di svolgimento delle attività quotidiane del soggetto che l’ha subito ed incida sugli aspetti relazionali della sua vita.
L’importanza del tema del danno biologico deriva dalla frequente ricorrenza delle richieste di risarcimento da esso derivanti, che ricorrono specialmente quando le controversie riguardano danni da sinistri stradali o in cause giudiziali da responsabilità medica.
Lesioni micropermanenti o di lieve entità
La disciplina del risarcimento del danno biologico non è stata sempre univoca, e tuttora occorre fare una serie di distinzioni, a seconda dell’evento da cui origini il danno e dell’entità delle lesioni subite.
A questo riguardo, la principale distinzione da fare in tema di danno biologico è tra lesioni di lieve entità, o micropermanenti, e lesioni di non lieve entità, o macropermanenti.
Altrettanto rilevante è la distinzione tra lesioni durature (o – per l’appunto – permanenti), quindi destinate ad incidere, in qualche modo, per il resto della vita del danneggiato, e lesioni temporanee, i cui effetti invalidanti terminano dopo un determinato lasso di tempo.
Le tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico
Gli uffici di diversi tribunali italiani hanno provveduto a stilare delle apposite tabelle sull’invalidità, con valori di entità del danno che vanno da 1 a 100 e in cui ad ogni diverso valore corrisponde un determinato importo da riconoscere quale risarcimento, rapportato anche all’età del danneggiato (e quindi alla sua aspettativa di vita).
Tradizionalmente, le tabelle più utilizzate dai giudici italiani, in questo senso, sono quelle del Tribunale di Milano.
Danno da circolazione stradale: art. 139 codice assicurazioni
Più specificamente, in materia di danni da circolazione stradale, l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che, per il risarcimento del danno biologico permanente, venga liquidato, per i postumi pari o inferiori al 9 per cento, un importo crescente, in ragione più che proporzionale, per ogni punto percentuale.
Come si vede, quindi, il limite dei 9 punti percentuali rappresenta il discrimine tra lesioni di lieve entità (micropermanenti) e lesioni di non lieve entità (macropermanenti).
Per le prime, la quantificazione viene periodicamente effettuata con apposito decreto ministeriale, rivalutato ai valori Istat sul costo della vita; per la quantificazione del risarcimento dovuto per le lesioni di non lieve entità, invece, si applicano solitamente le tabelle predisposte dai Tribunali, non essendo mai stato emanato il regolamento prescritto dall’art. 138 del Codice (d.lgs. 209 del 2005).
Il risarcimento del danno da invalidità temporanea
Si è fatto cenno, poc’anzi, al decreto ministeriale con cui vengono individuati gli importi per il risarcimento del danno biologico permanente.
Tale decreto provvede anche alla quantificazione, periodicamente rimodulata, del danno biologico per ogni giorno di invalidità temporanea. Quest’ultima, espressamente contemplata dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (comma 1, lett. b) può essere totale o parziale, a seconda che impedisca del tutto, o solo in parte, l’esplicazione delle normali attività quotidiane e della vita di relazione del soggetto danneggiato (in gergo giuridico, si utilizzano, al riguardo, gli acronimi ITT – invalidità temporanea totale, e ITP – invalidità temporanea parziale).
Danno biologico e responsabilità medica
Infine, va rilevato che le tabelle danno biologico predisposte dai tribunali (in primis, quelli di Milano e Roma) vengono comunemente applicate anche in tema di responsabilità sanitaria, cioè quando si tratta di risarcire lesioni derivanti da colpa medica.
Per il danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali è previsto, invece, un indennizzo sulla base delle tabelle Inail, che dispongono il risarcimento in forma di rendita per invalidità permanenti a partire dai 16 punti percentuali.