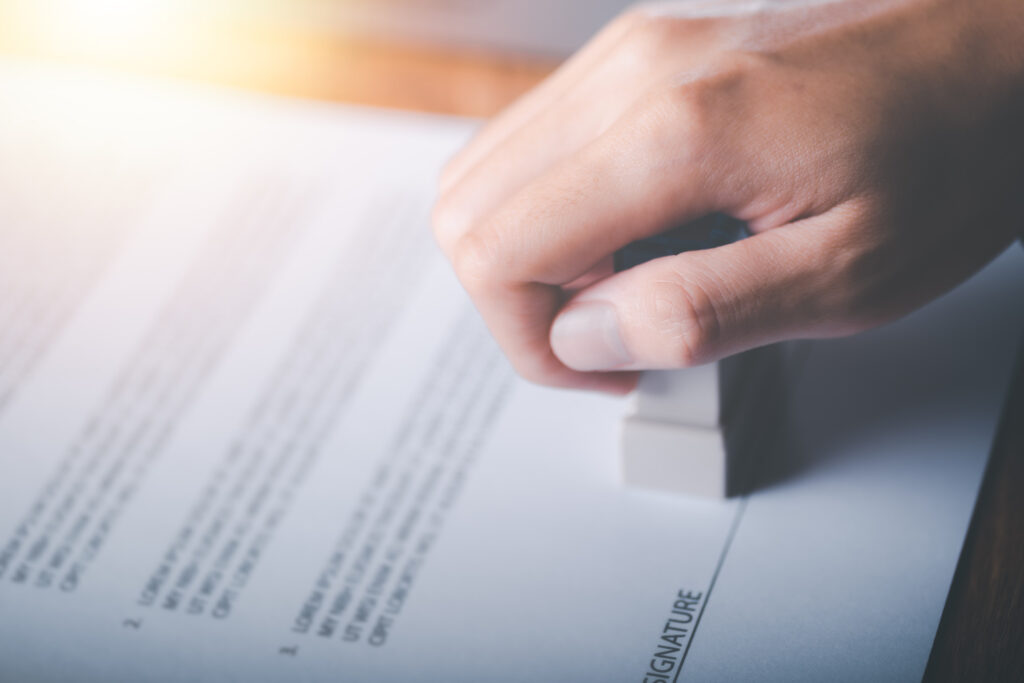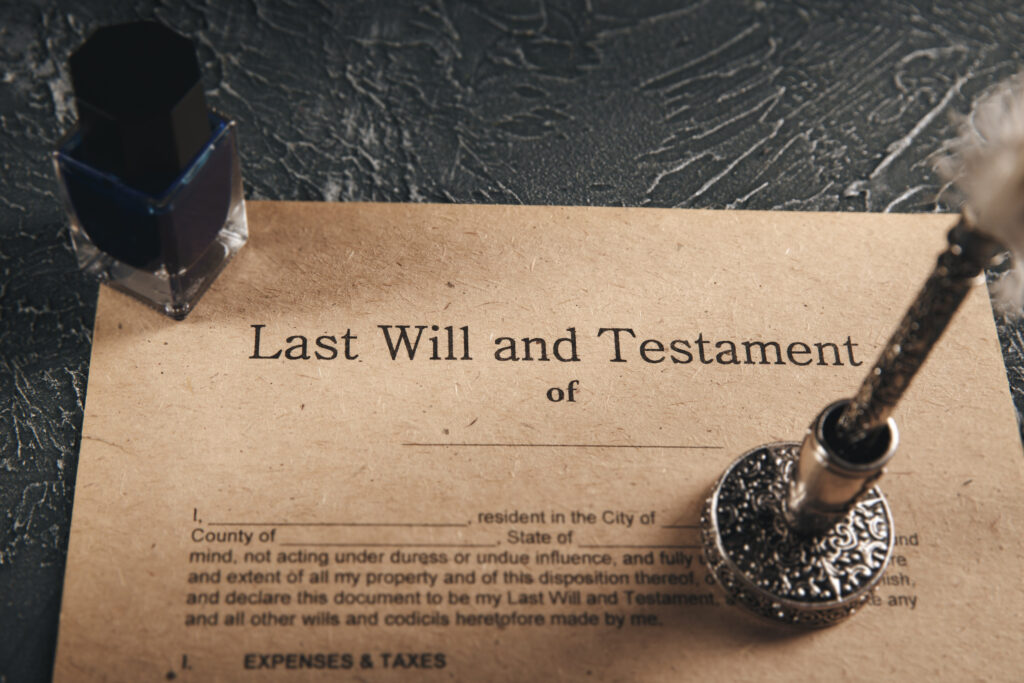Norme giuridiche: tipologie in base all’efficacia
Le norme imperative o cogenti fanno parte del nostro ordinamento giuridico, un sistema complesso, composto da un insieme di regole che disciplinano la vita sociale. Non tutte le norme, però, hanno la stessa forza o lo stesso grado di obbligatorietà.
In base alla loro efficacia, infatti, le norme giuridiche possono essere distinte in:
- norme assolute (o cogenti o imperative);
- norme relative (o derogabili).
Comprendere questa distinzione è fondamentale per capire come funziona il nostro sistema legale e quali margini di manovra hanno i cittadini nel regolare i propri rapporti.
Norme imperative o cogenti o assolute o inderogabili
Le norme cogenti, dette anche imperative o assolute, sono quelle disposizioni a cui non è possibile sottrarsi. La loro forza vincolante è tale che la volontà dei privati non può in alcun modo modificarle o disapplicarle. Esse esprimono principi fondamentali e valori essenziali per l’ordinamento, la cui violazione comporterebbe un danno per la collettività o per diritti irrinunciabili.
Norme imperative o cogenti: diritto penale
Un esempio lampante è rappresentato dalle norme di diritto penale, che impongono precetti quali “non uccidere”, “non rubare”, “non truffare”. È impensabile che due individui possano accordarsi per rendere legale un omicidio o un furto; la legge vieta tali azioni in modo categorico, e la loro violazione comporta sanzioni penali.
Norma imperative o cogenti di diritto civile
Ma le norme imperative non si limitano al diritto penale. Anche nel diritto civile ne troviamo molte. Si pensi alle norme che regolano la validità di un contratto. L’articolo 1418 c.c., tanto per fare un esempio, prevede la nullità del contratto quando questo viola una norma inderogabile.
Un altro esempio molto chiaro è rappresentato dalla norma che vieta l’applicazione di tassi usurari nei prestiti. Anche se le parti fossero d’accordo, un interesse superiore al limite legale renderebbe la clausola nulla. Questo perché la norma contro l’usura è imperativa e tutela un interesse pubblico.
Riassumendo, le norme imperative contengono un comando che si deve rispettare obbligatoriamente, senza che i privati vi possano derogare. In caso di mancatosi può incorrere in una sanzione penale o nella nullità dell’atto compiuto.
Norme relative o derogabili
Le norme relative o derogabili si suddividono in due sotto categorie: le norme dispositive e le norme suppletive.
Norme dispositive
Le norme dispositive disciplinano una certa fattispecie, ma permettono alle parti di accordarsi per l’applicazione di una disciplina diversa. Un esempio classico è la norma del Codice Civile che prevede il pagamento degli interessi in un contratto di mutuo. Questa norma è dispositiva perché le parti possono stabilire di comune accordo che il mutuo sia gratuito e che, di conseguenza, non siano dovuti interessi. La norma è presente nell’ordinamento, ma la sua applicazione può essere “disattivata” dalla volontà concorde delle parti.
Norme suppletive
Le norme suppletive invece, sono quelle che si applicano solo qualora le parti non abbiamo disposto nulla in relazione a una certa circostanza. In altre parole, mentre le norme dispositive devono essere espressamente derogate dalle parti, le norme suppletive intervengono solo per “supplire” (cioè “sostituire” o “integrare”) una lacuna lasciata dall’accordo tra i privati.
Un esempio chiarificatore è quello relativo al luogo di esecuzione di una prestazione. Se le parti non hanno specificato nel contratto dove deve essere eseguita la prestazione, o se il luogo non può desumersi dalla natura della prestazione o dagli usi, allora si applicano le norme stabilite dalla legge. Il codice, quindi, dà prevalenza alla volontà delle parti; solo in sua assenza interviene la norma suppletiva per evitare che la situazione rimanga priva di regolamentazione.
Leggi gli ultimi articoli pubblicati