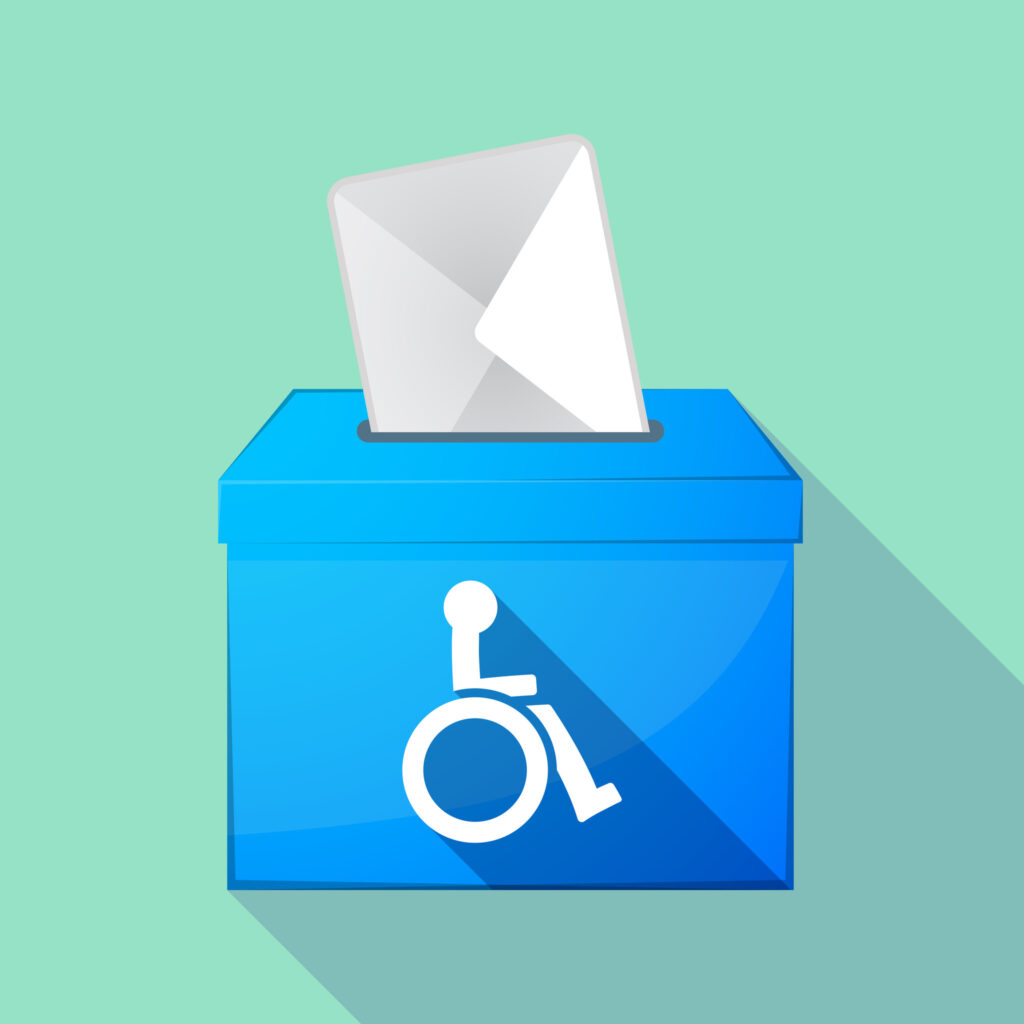Adozione internazionale e persone singole È costituzionalmente legittima la disciplina di cui agli artt. 29bis, comma 1, e 30, comma 1, L. 184/2983 che esclude le persone singole dalla procedura di adozione internazionale?
Quesito con risposta a cura di Caterina D’Alessandro, Giulia Fanelli e Mariella Pascazio
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29bis, comma 1, L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6 della medesima legge, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere così al tribunale per i minorenni, del distretto in cui hanno la residenza, che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione (Corte cost. 21 marzo 2025, n. 33 – Adozione internazionale e persone singole).
Dinanzi alla censura di legittimità costituzionale mossa dal Tribunale fiorentino e riguardante sia l’art. 29bis, comma 1, sia l’art. 30, comma 1, L. 184/2983, la Corte costituzionale ha deciso di investire la sua attenzione solo sulla prima delle due disposizioni.
L’evoluzione storica della normativa che ha riguardato l’adottabilità dei minori e che affonda le sue radici nel periodo successivo alla prima guerra mondiale evidenzia come il legislatore abbia nel tempo sempre più precluso la possibilità di adozione da parte di persone singole. A dispetto di questo approccio legislativo, la Consulta ha ritenuto di dover richiamare e valorizzare le disposizioni previste dall’ordinamento che permettono alle persone singole di adottare dei minori. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 184/1983, si consente l’inserimento del minore in un nucleo monoparentale, e quindi l’adozione da parte di un genitore singolo, se durante l’affidamento preadottivo uno dei due coniugi muore o diventa incapace. Il medesimo effetto lo si rinviene, ex art. 25, comma 5, L. 184/1983, anche nell’ipotesi in cui nell’affidamento preadottivo intervenga la separazione tra i coniugi affidatari. Altresì, ai sensi dell’art. 44, comma 3, L. 184/1983 si consente l’adozione in casi particolari da parte di persone singole. In tutte le ipotesi citate l’obiettivo del legislatore è quello di garantire la continuità del rapporto affettivo, obiettivo che, ad avviso della Consulta, si rinviene tutt’oggi anche nelle ipotesi di adozione da parte di coppie coniugate in seguito a un prolungato periodo di affidamento, e che può sussistere anche nell’ipotesi di adottabilità da parte di una singola.
In seguito ad una ricognizione della disciplina attuale, la Consulta ha evidenziato come l’aspirazione alla genitorialità, quindi la scelta di adottare o meno un minore, sia un’estrinsecazione della libertà di autodeterminazione di ciascun individuo di cui all’art. 8 Cedu e agli artt. 2, 3, 31 Cost. (Corte EDU 27 maggio 2021, Marchi c. Italia; Corte EDU 16 gennaio 2018, Nedescu c. Romania; Corte cost. 162/2014; Corte. cost. 332/2000) e che tale libertà non è suscettibile di ingiustificate limitazioni. Non possono, infatti, sussistere irragionevoli compressioni della scelta della genitorialità sia quando una persona può accedere all’adozione di minori in quanto soddisfa i requisiti previsti dalla legge sia quando non vi può accedere perché persona singola.
Sulla scorta di questa premessa la Corte ha pertanto ritenuto che l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale sia lesiva degli artt. 2 e 117, comma 1, Cost. e questo in relazione all’art. 8 Cedu. Infatti, la normativa censurata lede la persona singola che abbia aspirazioni genitoriali e contestualmente non trova legittimazione in esigenze che sociali che fondino una ragionevole esclusione di queste persone dall’accesso all’adozione di minore straniero. A sostegno dell’irragionevolezza del divieto sussistono altre due argomentazioni. Da un lato, infatti, si evidenzia come a seguito della riforma del 2013 esista un unico stato di figlio ex art. 315 c.c. e non vi sia più nemmeno la distinzione tra figlio nato in costanza o meno di matrimonio. Dall’altro lato, invece, non vi è alcuna fondata ragione di ritenere che l’esclusione aprioristica delle persone singole dall’accesso alla genitorialità garantisca maggiormente al minore un ambiente stabile e armonioso (Corte cost. 16 maggio 1994, n. 183). Infatti, l’interesse del minore è comunque preservato dal giudizio di idoneità dell’adottante da parte dell’autorità giudiziaria, la quale guarderà alla rete familiare di riferimento.
Infine, la Corte ha sottolineato come il divieto alla persona singola di accedere alla genitorialità mediante l’adozione internazionale si riverbera negativamente, oltre che sul diritto all’autodeterminazione della persona singola, sul diritto del minore ad essere accolto in un ambiente stabile e armonioso.