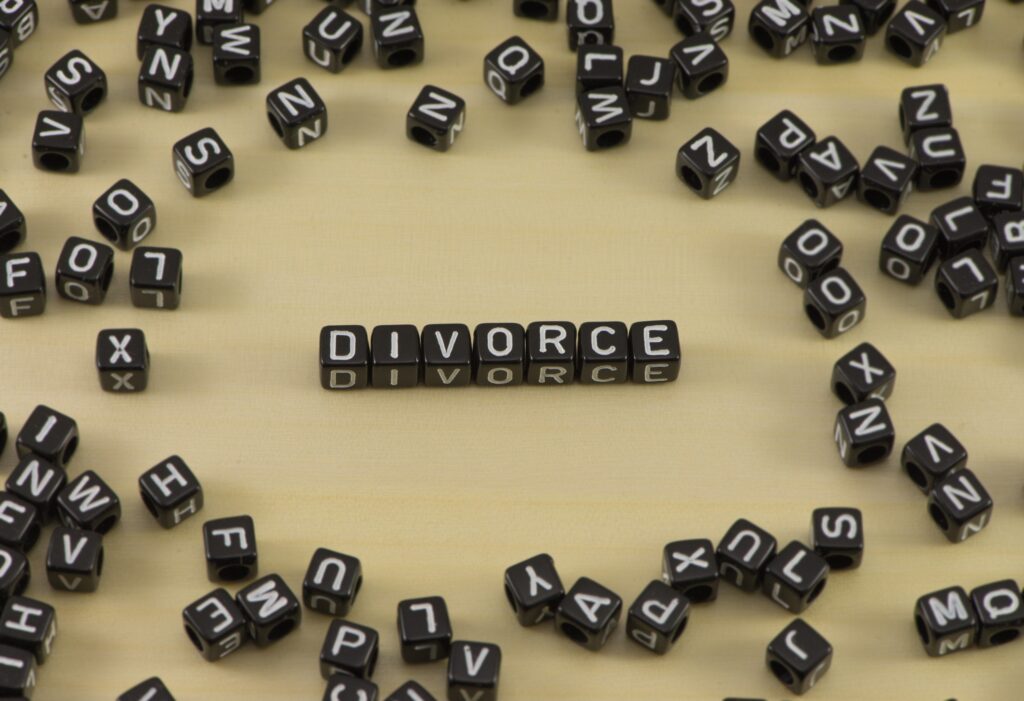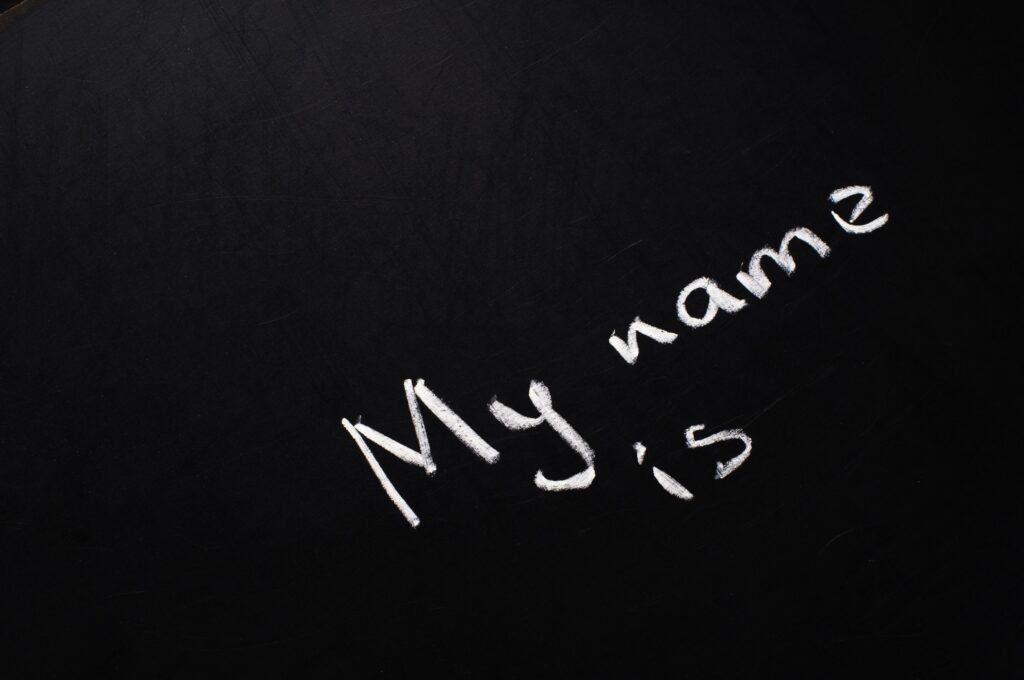Reddito di emergenza: la guida Il Reddito di emergenza (REM) concesso in piena pandemia ha rappresentato un sostegno economico importante per le famiglie in maggiore difficoltà
Reddito di emergenza: cos’è
Il Reddito di emergenza (REM), ad oggi non più in vigore, ha rappresentato un’importante forma di sostegno economico in epoca Covid per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia. Il REM è stato introdotto dal decreto legge n. 34/2020. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto poi la possibilità di poter richiedere una mensilità ulteriore di REM. Il successivo decreto n. 137/2020 ha previsto infine la possibilità di ottenere due quote ulteriori di REM per le mensilità di novembre e dicembre 2020.
Quest’ultima tranche di reddito di emergenza è stata riconosciuta:
- d’ufficio ai nuclei familiari che avevano già beneficiato della misura in base al decreto legge n. 104/2020;
- su domanda di parte per quei nuclei familiari che non avevano mai ottenuto il REM o che lo avevano ottenuto solo in virtù del primo decreto legge n. 34/2020.
La misura del beneficio prevista dai decreti n. 134/2020 e n. 137/2020 è stata riconosciuta in favore di quei nuclei familiari titolari di un reddito inferiore all’ammontare del beneficio.
Requisiti soggettivi ed economici dei beneficiari
Il reddito di emergenza è stato riconosciuto a quei nuclei familiari che, nel momento di presentazione della domanda, presentavano i seguenti requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali:
- residenza in Italia verificata in relazione al soggetto richiedente;
- reddito familiare nei mesi di aprile, maggio e settembre 2020 inferiore all’importo del beneficio potenziale riconosciuto;
- patrimonio immobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a 10.000 euro, soglia che saliva di 5000 euro in presenza di un componente aggiuntivo rispetto al primo (fino a un massimo di 20.000 euro) o in presenza di un componente familiare affetto da disabilità grave o non autosufficiente;
- ISEE documentato da DSU valida inferiore a 15.000 euro.
I primi tre requisiti potevano essere autocertificati all’interno della domanda, la veridicità di quanto dichiarato comportava la revoca del REM o la restituzione di quanto già percepito. Il requisito dell’ISEE era invece oggetto di verifica da parte dell’INPS nella DSU.
REM: modalità di presentazione della domanda
La domanda per la prima tranche di REM, prevista dal decreto legge n. 34/2020, poteva essere presentata entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 31 luglio 2020. La domanda per la mensilità prevista dal decreto legge 104/2020 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. La domanda per il REM prevista dal decreto legge n. 137/2020 poteva essere presentata infine dal 10 al 30 novembre 2020.
Le modalità di presentazione della domanda erano le seguenti:
- in modalità telematica dal sito ufficiale dell’INPS, dopo essersi autenticati con il Pin, lo SPID almeno di livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica,
- avvalendosi dei servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
Importo del Reddito di emergenza
Per il calcolo del reddito di emergenza mensile si doveva moltiplicare l’importo di 400 euro per il valore della scala di equivalenza. La scala di equivalenza presentava i seguenti valori di riferimento:
- 1 per il primo componente del nucleo familiare, con un incremento:
- di 0,4 per ogni altro componente oltre il primo purché maggiore di anni 18;
- di 0,2 per ogni componente minore di età, fino a un massimo di 2, o di 2,1 in presenza di componenti familiari gravemente disabili o non autosufficienti.
L’importo massimo in ogni caso non poteva superare gli 800,00 euro mensili, che potevano salire a 840 euro, solo se nel nucleo familiare erano presenti disabili gravi o non autosufficienti.
Facciamo un esempio per comprendere meglio il funzionamento. In presenza di un nucleo familiare composto da due adulti e da un minore la scala di equivalenza è pari a 1,6, risultato che si ottiene sommando al primo componente familiare di valore 1, il secondo componente maggiorenne di valore 0,4 e il terzo componente familiare minorenne di valore 0,2. Moltiplicando l’importo base di 400 euro per il valore della scala di equivalenza di 1,6 l’importo del REM era pari a 640 euro.
Durata del reddito di emergenza
Il reddito di emergenza, come anticipato, ha rappresentato una misura straordinaria prevista durante il periodo della pandemia in favore delle famiglie in difficoltà. Il decreto n. 34/2020 e il decreto n. 137/2020 hanno previsto l’erogazione di due mensilità. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto invece il riconoscimento di tre mensilità.
Aiuti incompatibili con il REM
Il R.E.M. era incompatibile con altre forme di aiuti previsti in epoca COVID, come l’indennità per i lavoratori che erano stati danneggiati dalla dall’emergenza epidemiologica. Pertanto, se all’interno del nucleo familiare, un soggetto era già percettore della suddetta indennità, il reddito di emergenza non poteva essere concesso.
La misura inoltre era incompatibile con la titolarità di una pensione diretta o indiretta, con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore alla soglia massima del reddito familiare e infine con la titolarità del reddito o della pensione di cittadinanza.