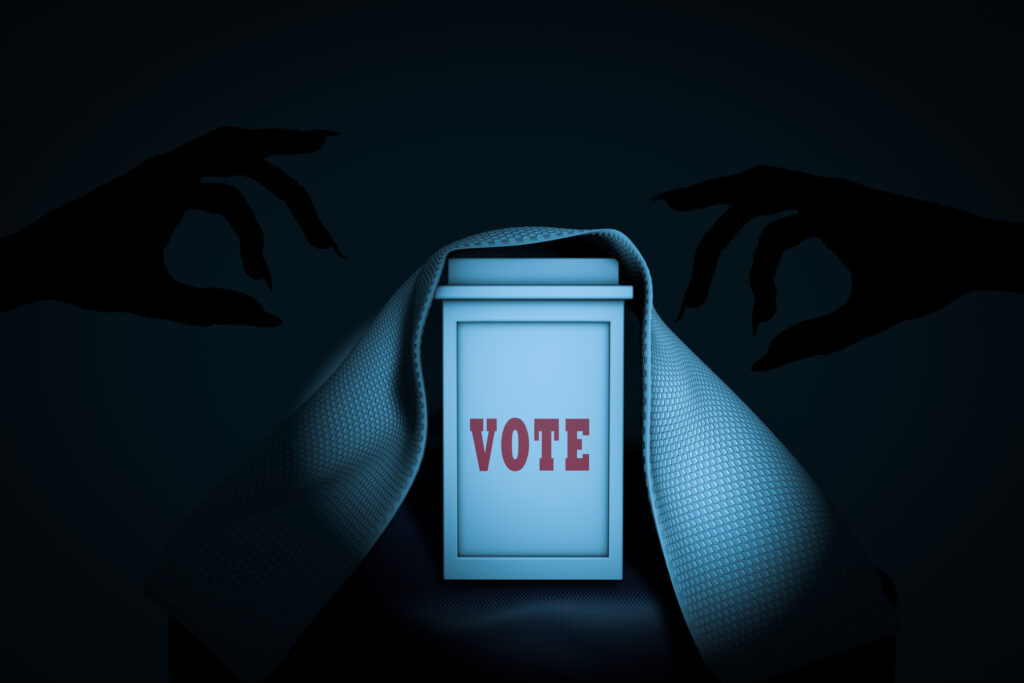La compravendita La compravendita: definizione, tipologie, caratteristiche, effetti, forma, obblighi del venditore e del compratore e pagamento
Cos’è la compravendita
La compravendita è un contratto disciplinato dal codice civile italiano, precisamente dagli articoli 1470-1547. La finalità di questo contratto consiste nel trasferire la proprietà di un bene o di un altro diritto da un venditore a un compratore, in cambio di un prezzo. Questo contratto ha origini molto antiche, che risalgono all’epoca romana, e oggi rappresenta uno degli istituti giuridici più importanti e frequenti.
Tipologie di compravendita
Il contratto di compravendita può variare notevolmente a seconda dell’oggetto e delle condizioni concordate.
- Compravendita immobiliare: ha per oggetto i beni immobili come terreni, case o appartamenti. La legge richiede che questo tipo di contratto sia redatto per iscritto, spesso come atto pubblico o scrittura privata autenticata, e che venga registrato nei registri immobiliari per essere opponibile a terzi.
- Compravendita mobiliare: si riferisce alla vendita di beni mobili, tra cui veicoli, elettrodomestici, mobili o qualsiasi altro bene non immobile. Generalmente, questa forma di compravendita non richiede formalità specifiche e si perfeziona con il semplice accordo tra le parti. Per i beni mobili registrati (come le automobili), è comunque necessaria la forma scritta ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
- Compravendita con riserva di proprietà: questa tipologia è comune nelle vendite a rate. Il compratore entra subito in possesso del bene. La proprietà effettiva del bene però rimane al venditore fino a quando il compratore non paghi l’intero prezzo, in caso di contrario, il venditore può riprendersi il bene.
- Compravendita con patto di riscatto: il venditore può riacquistare il bene venduto entro un determinato termine stabilito, restituendo al compratore il prezzo pagato e rimborsando gli le spese sostenute. Questa clausola è tipicamente utilizzata quando il venditore ha l’interesse a poter rientrare in possesso del bene in futuro.
Contratto di compravendita: caratteristiche
La compravendita è a titolo oneroso, entrambe le parti infatti traggono un vantaggio economico: il venditore riceve il prezzo, e il compratore ottiene la proprietà del bene.
Il contratto è consensuale, il che significa che si perfeziona con il semplice accordo tra le parti, senza che sia necessaria la consegna fisica della cosa. Il trasferimento della proprietà, quindi, avviene per effetto del solo consenso (principio consensualistico).
Un’altra caratteristica fondamentale è il vincolo sinallagmatico, dove le prestazioni delle parti (il trasferimento del bene e il pagamento del prezzo) sono strettamente legate l’una all’altra. Questo legame rende applicabili istituti come la risoluzione del contratto, nel caso in cui una delle parti non adempia alla propria obbligazione.
La compravendita: effetti
Di norma, la compravendita ha effetti reali: la proprietà del bene passa dal venditore al compratore nel momento stesso in cui il contratto viene concluso. Tuttavia, esistono casi in cui l’effetto traslativo della proprietà è differito a un momento successivo, dando vita alle vendite a effetti obbligatori. In queste situazioni, infatti, il contratto genera inizialmente solo un’obbligazione per il venditore di fare acquistare la proprietà al compratore. Vediamo qualche esempio di vendite a effetti obbligatori.
- Vendita di cose generiche: la proprietà si trasferisce quando il bene, determinato solo nel genere (ad esempio, 100 quintali di grano), in seguito viene specificato o individuato.
- Vendita di cosa futura: l’effetto traslativo si ha quando la cosa viene a esistere (ad esempio, un immobile ancora da costruire o i frutti di un terreno non ancora raccolti).
- Vendita di cosa altrui: il venditore si assume l’impegno di procurarsi la proprietà del bene da un terzo per trasferirla poi al compratore.
Forma del contratto di compravendita
Per quanto riguarda la forma, la compravendita è generalmente libera e può avvenire anche oralmente. Tuttavia, in alcuni casi, come la vendita di beni immobili, è necessaria la forma scritta a pena di nullità. Questi atti devono essere redatti come atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari.
Obblighi del venditore e del compratore
Il contratto di compravendita impone precisi obblighi a entrambe le parti.
Obblighi del compratore: il dovere principale del compratore è quello di pagare il prezzo stabilito e di sostenere le spese del contratto, a meno che non sia stato diversamente pattuito.
Obblighi del venditore: il venditore invece ha tre obblighi principali:
-
- consegnare la cosa: ossia trasferire fisicamente il bene al compratore:
- garantire dall’evizione ossia proteggere l’acquirente nel caso in cui un terzo rivendichi la proprietà o un altro diritto reale sul bene venduto. Se il compratore perde il bene a causa di una rivendicazione di terzi, il venditore deve risarcire il danno.
- Garantire per i vizi: assicurare il compratore che il bene è privo di difetti tali da renderlo inidoneo all’uso o da diminuirne significativamente il valore. Per i beni di consumo, la normativa più recente introduce anche la garanzia di conformità, che assicura che il bene risponda alle caratteristiche stabilite nel contratto.
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire con diverse modalità (bonifico, assegno, contanti) e in tempi diversi, che possono essere anticipati, immediati o posticipati, a seconda degli accordi. Il contratto può anche includere clausole particolari che danno luogo a tipi speciali di vendita, come quelli trattati sopra.
Leggi anche gli articoli collegati a questo argomento