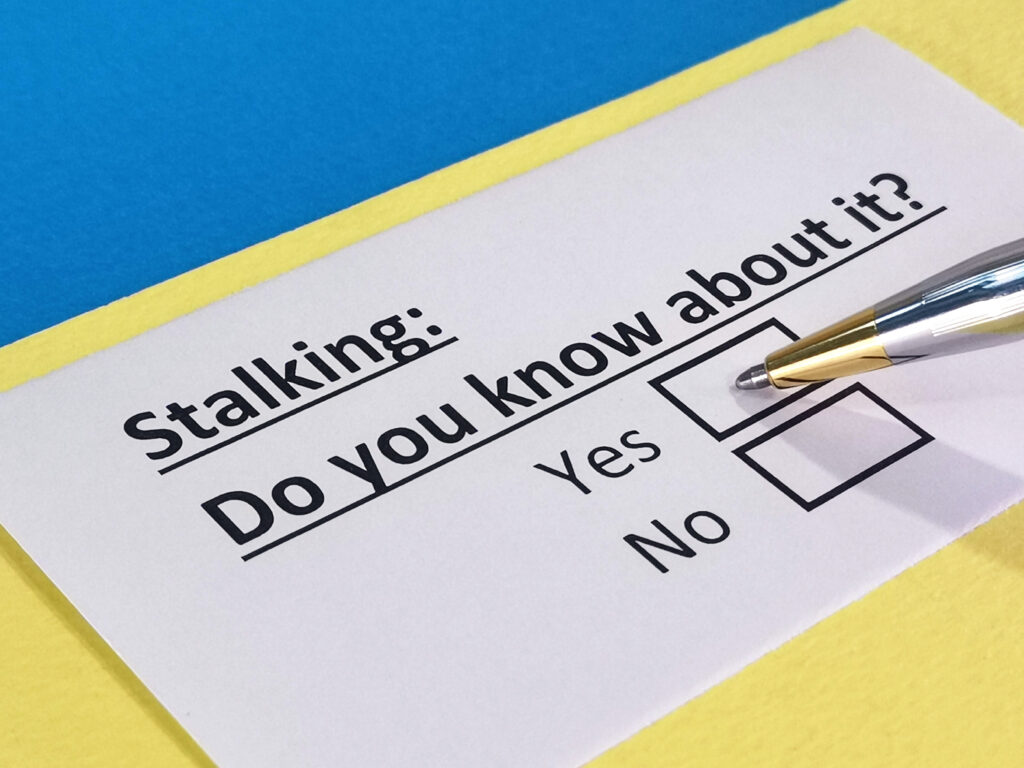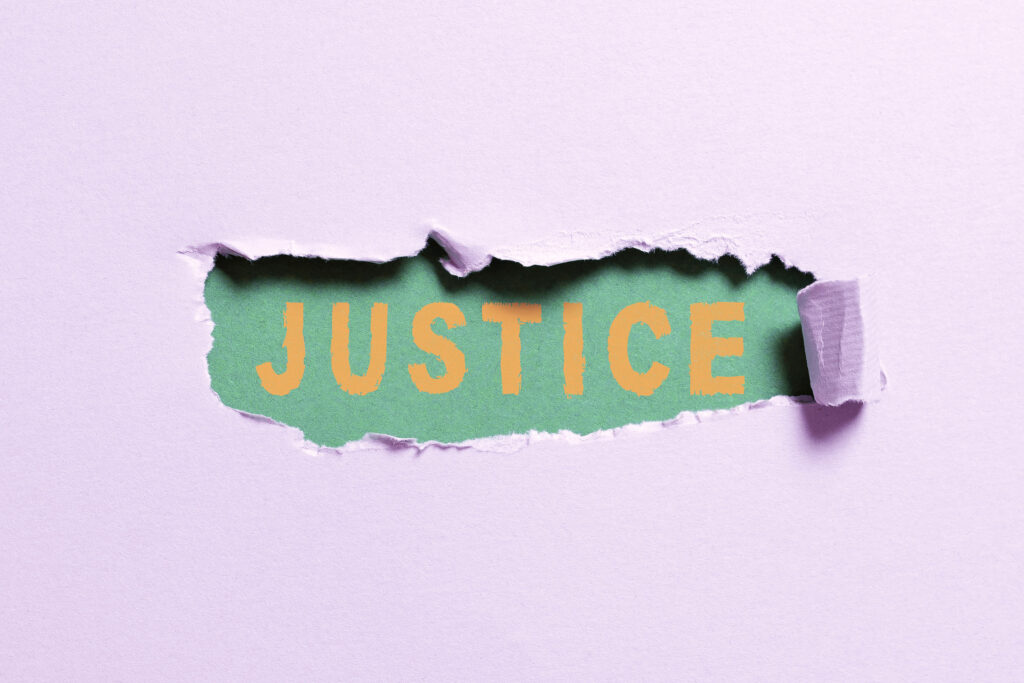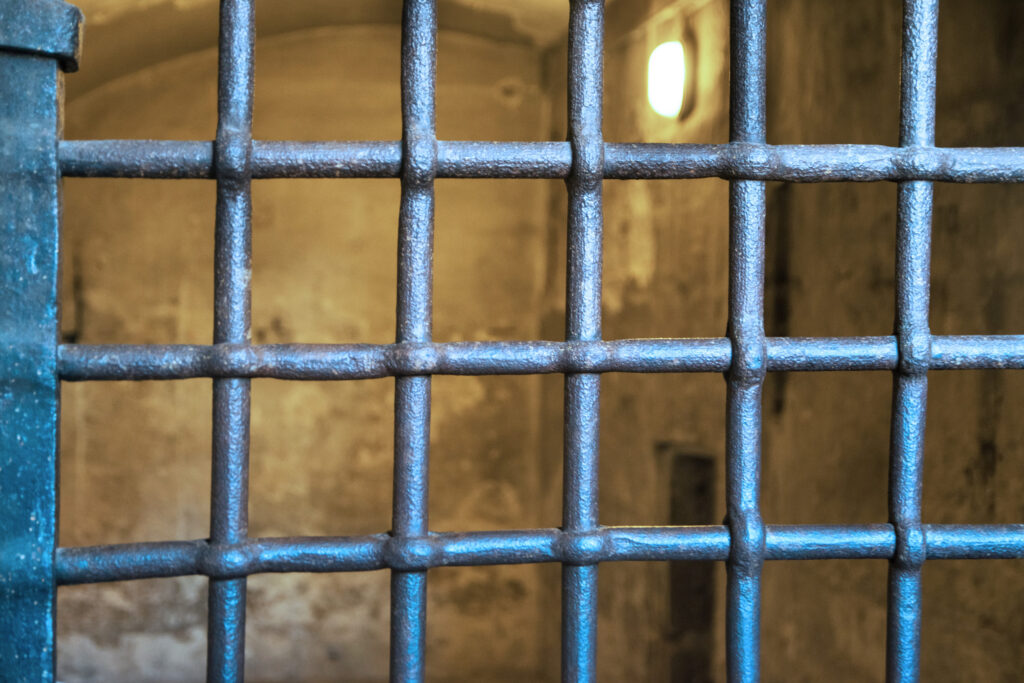Stalking: se il reato connesso diventa a querela, cambia la procedibilità La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che manteneva d’ufficio gli atti persecutori connessi a un danneggiamento divenuto procedibile a querela
Stalking e riforma Cartabia: torna la procedibilità a querela
Con la sentenza n. 123/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma contenuta nel decreto “correttivo” della riforma Cartabia, nella parte in cui impediva che la modifica del regime di procedibilità del reato di danneggiamento si riflettesse su quello degli atti persecutori a esso connessi.
Danneggiamento e stalking con remissione della querela
Il caso oggetto del giudizio prende avvio da un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Verona, nel quale un imputato era accusato di atti persecutori (minacce e insulti reiterati) e, in aggiunta, del danneggiamento dell’auto della persona offesa – nello specifico, la rottura dei tergicristalli.
In origine, il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede era procedibile d’ufficio, rendendo tale anche il reato connesso di stalking. Tuttavia, la persona offesa aveva presentato e poi rimesso la querela, ma il giudice non poteva dichiarare l’estinzione del reato a causa della norma sopravvenuta che manteneva gli atti persecutori procedibili d’ufficio anche dopo la riforma.
La riforma Cartabia e il correttivo del 2024
Nel 2024, il decreto correttivo alla riforma Cartabia ha modificato la procedibilità del danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, rendendolo procedibile a querela. Tuttavia, una norma inserita nel decreto stabiliva che tale modifica non si estendesse ai delitti connessi, come gli atti persecutori, che continuavano a rimanere procedibili d’ufficio.
La violazione del principio di retroattività favorevole
La Corte costituzionale ha ritenuto che questa norma rappresenti una deroga ingiustificata al principio di retroattività della legge penale più favorevole, tutelato dall’art. 3 della Costituzione e riconosciuto a livello di diritto internazionale dei diritti umani.
In mancanza della deroga, ha spiegato la Corte, la modifica del regime del reato connesso avrebbe comportato il ritorno alla procedibilità a querela anche per lo stalking, come previsto dalla regola generale.
Incostituzionale la norma che cristallizza il regime d’ufficio
Secondo la Consulta, mancano valide ragioni giustificative per escludere la retroattività favorevole in questo caso. La norma impugnata è quindi costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio per gli atti persecutori connessi al danneggiamento, nonostante la sopravvenuta querelabilità di quest’ultimo.