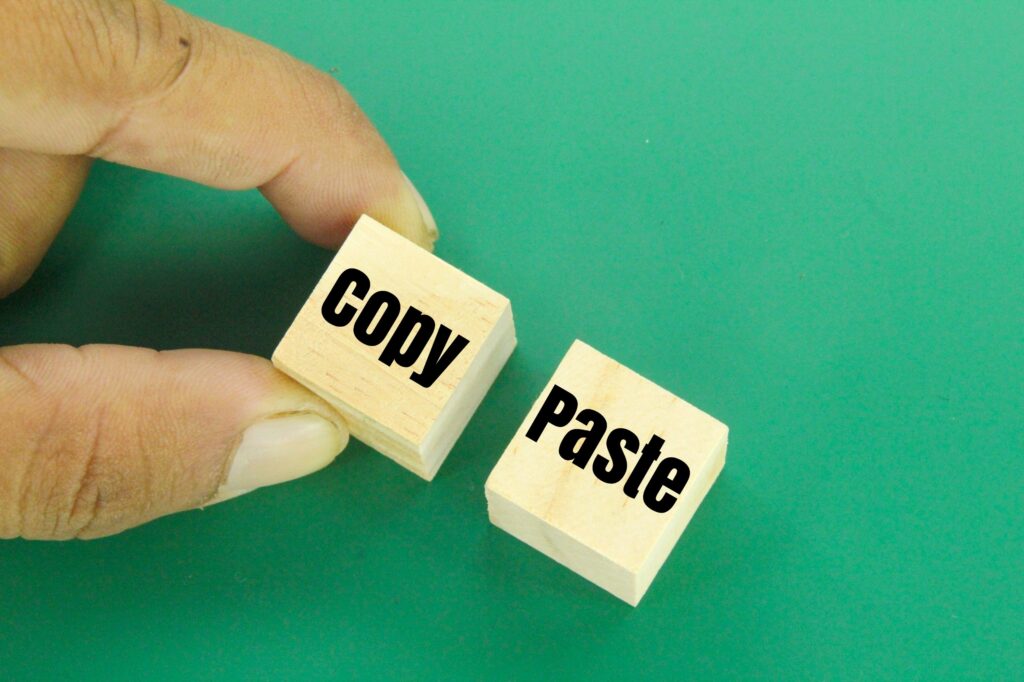Stalking: terminologia e definizione
Reato di stalking: con il termine inglese «stalking» vengono indicate una serie di azioni, ripetute nel tempo, che hanno caratteri di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e/o di comunicazione e che suscitano nel destinatario ansia, preoccupazione e timore.
Il termine, privo di un esatto corrispettivo nella lingua italiana, in inglese ha origine venatoria ed è particolarmente efficace nel descrivere il comportamento, tipico del cacciatore, del seguire, braccare e cacciare una preda.
Al di fuori dell’ambito venatorio, esso indica quei comportamenti molesti, o addirittura francamente persecutori, descritti anche in ambiti diversi da quello delle relazioni di coppia (si veda ad esempio, il noto fenomeno dello star-stalking). Quelli tipicamente più gravi e oggetto di maggiore attenzione sono, tuttavia, quelli messi in atto da ex partner a seguito dell’interruzione di una relazione intima; nel caso specifico questi comportamenti si inscrivono, spesso, in una vera e propria patologia della relazione in cui il «persecutore», che non è riuscito a elaborare la separazione e il lutto della perdita, persiste nel tentativo di entrare in contatto con l’ex partener e/o di spiare e controllare la sua vita.
Fanno tipicamente parte di questi comportamenti molesti, e configurano quindi il fenomeno dello stalking, le richieste ripetute e insistenti di parlare o di avere appuntamenti con l’ex partner, l’invio di lettere, messaggi, telefonate o regali indesiderati, il seguire e controllare gli spostamenti del partner, gli appostamenti sotto casa, fuori dal lavoro o da scuola. Si tratta di comportamenti che di per sé potrebbero anche non configurarsi come reati. Ai fini della configurazione del reato di stalking ciò che li rende minacciosi e persecutori è il fatto di essere ripetuti, insistenti e indesiderati al punto da spaventare la vittima che ne è oggetto.
Lo stalking è stato inquadrato negli studi di psicologia anche come sindrome del molestatore assillante: si tratta di una definizione che risale al 1912: fu uno studioso francese, Gaetan Gratian de Clérambault , che parlò di questa sindrome ed in particolare descrisse l’erotomane come individuo affetto da delirio erotico mosso da gelosia.
Abbiamo studi molto sedimentati sullo stalking, anche in Italia, ad esempio il Modena Stalking Group, che non è un complesso musicali, ma è un gruppo di associazioni che sono raccordate tra loro e che da tempo si occupano in generale della violenza contro le donne ed in particolare del fenomeno dello stalking . In una delle ultime pubblicazioni del Modena Stalking Group, sono contenuti una serie di contributi da parte studiosi di scienze psichiatriche i quali descrivono il comportamento dello stalker che può essere veramente il più vario: si va dal pedinamento al furto d’identità della persona offesa, all’ordinare per suo conto e in suo nome beni oppure lo screditamento della persona sul luogo di lavoro fino a comportamenti più violenti; c’è tutta una escalation di violenza che va dalle lettere minatorie all’uccisione degli animali domestici, alle minacce verso i familiari, insomma c’è una gamma veramente infinita di comportamenti, non necessariamente tra loro omogenei e non necessariamente di per sé costituenti reato.
Il fenomeno dello stalking in tempi più ravvicinati è stato conosciuto soprattutto per la notorietà delle vittime, spesso si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo; così, ad esempio, David Caruso l’attore più conosciuto della serie televisiva americana CSI, nella quale interpreta l’investigatore di polizia Horatio Caine. È rimasto vittima di ripetute molestie da parte di una fan di nazionalità austriaca, che poi venne condannata a sette mesi di prigione dal tribunale di Innsbruck. A questa decisione si è arrivati dopo che la presunta fan aveva inviato 120 lettere, tra cui una in cui lo minacciava di morte semplicemente perché Caruso non le aveva rilasciato un autografo. Ed infatti la California è il primo Stato che si è dotato di una legislazione antistalking nel 1990, poi, mano mano, tutti gli altri Stati si hanno adottato analoghe previsioni legislative anche in Europa.
Le dimensioni del fenomeno
Dall’indagine multiscopo «Sicurezza delle donne» condotta dall’ISTAT, emerge che nel nostro Paese le donne che hanno subito comportamenti persecutori dal marito, dal convivente o dal fidanzato quando si stavano separando da lui o dopo la separazione sono 2 milioni 77 mila.
Su base nazionale risulterebbe che circa il 20% delle donne hanno subito, almeno una volta nella vita, persecuzioni assimilabili allo stalking. Questo dato è confermato dal Centro antipedinamento di Roma secondo cui nella sola capitale il 21% della popolazione è stata vittima, almeno una volta nella vita, di stalking. Questi dati, ci danno ovviamente un quadro generale della situazione; è importante infatti considerare il cosiddetto «numero oscuro», ossia di tutti i casi in cui la molestia assillante non è stata segnalata alle autorità o denunciata.
I volontari dell’Osservatorio Nazionale Stalking (ONS) hanno monitorato 14 regioni, somministrando ed analizzando 8.400 questionari. L’analisi delle variabili socio demografiche ha evidenziato un’assoluta trasversalità del fenomeno. Nello specifico, anche questa analisi conferma l’importante, e per certi versi allarmante, dato sull’incidenza dello stalking sulla popolazione femminile italiana.
Le ragioni di una riforma: inadeguatezza normativa preesistente
Da più parti era avvertita la necessità di adeguare il nostro ordinamento alla realtà dei rapporti sociali ed interpersonali conseguenti all’evoluzione della società italiana.
In particolare sia da parte del mondo dei giuristi (dottrina e giurisprudenza) sia da parte di associazioni varie di cittadini è stato rilevato che alcuni comportamenti particolarmente odiosi ed invasivi dell’altrui sfera privata non sono adeguatamente sanzionati.
Ci si riferisce a vari atteggiamenti tenuti da soggetti i quali per i più svariati motivi turbano la tranquillità privata delle persone attraverso atti di molestia compiuti anche con mezzi telematici o informatici.
L’inadeguatezza dell’attuale normativa si evince chiaramente dalla lettura della vigente norma sanzionatoria prevista dal codice penale all’art. 660 il quale sotto la rubrica della molestia o disturbo alle persone punisce alcuni comportamenti che debbono presentare alcuni anacronistici requisiti sotto il profilo soggettivo determinati dalla petulanza o altro biasimevole motivo, e sotto il profilo oggettivo dall’essere commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Così è stata ravvisata dalla giurisprudenza per esempio la molestia di cui all’art. 660 c.p.:
- in un continuo e pressante tallonamento con la vettura da parte dell’autore del reato nei confronti del veicolo della vittima;
- le proposte di appuntamenti galanti non gradite dall’interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono;
- un pedinamento puro e semplice;
- il continuo e insistente corteggiamento di una donna, chiaramente non gradito;
- colui che assillando la parte offesa con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa compie una serie di telefonate dal tono confidenziale;
- azioni di disturbo ravvisate nella condotta dell’ex fidanzato della persona offesa, che rivolge frasi e atteggiamenti di corteggiamenti per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all’interno di un locale pubblico dove la stessa lavorava.
La stessa collocazione della norma tra le contravvenzioni, la previsione punitiva di questa (arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro), l’inserimento tra le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica, rendono la fattispecie punitiva assolutamente desueta.
La norma di cui all’art. 660 c.p. in realtà ha una dimensione e una ispirazione assolutamente illiberale e poliziesca, privilegiando la tutela dell’ordine pubblico; occorre, invece, modificare la scala dei valori, privilegiando il principio personalistico: in sostanza non è la tutela della persona che deve porsi come strumento per assicurare l’ordine e la tranquillità alla collettività ma al contrario è la garanzia della tranquillità a livello collettivo che deve assicurare il verificarsi delle condizioni necessarie e preliminari al godimento della tranquillità personale.
Altri delitti che venivano utilizzati per sanzionare le condotte oggi punite come atti persecutori erano la violenza privata e il reato di minaccia, delitti per loro natura istantanei, non sempre tuttavia configurabili nelle condotte di stalking, perché se noi lo esaminiamo dal punto di vista fattuale il comportamento dell’autore di atti persecutori può essere il più vario e il più disomogeneo e non necessariamente i singoli atti debbono o possono costituire reato ai sensi delle vecchie norme (artt. 612, 610, 594, 595 c.p.).
Il rafforzamento della tutela, allo stato insufficiente, va inquadrato in un più ampio discorso che presuppone la rimeditazione dei principi e degli strumenti di tutela della vita privata e della riservatezza della persona in un contesto caratterizzato, come quello attuale, da molteplici possibilità di aggressione: si pensi, per esempio, al grado di penetrazione nell’intimità personale che si attua attraverso le risorse informatiche. Di qui la necessità di riaffermare, con forza, il diritto di ogni persona a non subire, nel contatto con gli altri, interferenze tali che alterino in modo rilevante la sua tranquillità personale e la sfera di vita privata senza essere sorrette da esigenze di ordine sociale.
In buona sostanza si tratta di garantire a ciascuno la possibilità di filtrare e selezionare il contatto con gli altri rispetto ad alcune manifestazioni gratuite, fastidiose o superflue che spesso si è costretti a subire.
Legislazione italiana: il D.L. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009
L’art. 7 del D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009, ha introdotto nel codice penale, tra i delitti contro la libertà morale, il nuovo delitto di atti persecutori, collocato dopo l’art. 612 c.p. Il cd. stalking, si sostanzia in un comportamento reiterato consistente in minacce o molestie. Scopo dichiarato della nuova fattispecie è quello di evitare che i comportamenti persecutori possano degenerare in fatti ben più gravi (quali la violenza sessuale e l’omicidio), se non tempestivamente controllati e ridimensionati. La norma ha carattere residuale: essa, infatti non troverà applicazione qualora nei fatti sia configurabile un reato più grave.
La nuova legge in materia di atti persecutori costituisce un sistema integrato di tutela, in quanto la tematica dello stalking viene trattata non soltanto dal punto di vista del diritto penale sostanziale, ma il legislatore ha creato un vero e proprio microsistema integrato di tutela, perché accanto alle norme di diritto penale sostanziale, e cioè all’art. 612bis c.p., ha previsto anche una serie di norme procedurali, per esempio:
- introducendo una nuova figura di misura cautelare all’art. 282ter c.p.p.;
- ha previsto una serie di facilitazioni per l’assunzione della prova, in particolare per quanto riguarda l’incidente probatorio;
- ha previsto un sistema anche di prevenzione attraverso la procedura di ammonimento, che è un atto amministrativo del Questore;
- ha previsto una serie di norme a tutela della vittima attraverso oneri e obblighi di informazione e di sostegno anche socio-sanitario nei confronti della vittima;
- ha previsto infine una tutela di natura civilistica attraverso l’ampliamento degli ordini di protezione.
L’oggetto giuridico della tutela
Il delitto previsto dall’art. 612bis c.p. rientra tra i reati contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà morale.
Il concetto di tranquillità personale
Il concetto di tranquillità personale, che costituisce l’oggetto giuridico che tutela la nuova fattispecie delittuosa, va qui precisamente delineato: esso riflette la personalità del singolo nel momento statico di chiusura agli altri a fronte di quelle interferenze e intrusioni che legittimano la chiusura del soggetto e il rispetto del suo diritto a non essere aggredito nella propria solitudine.
È fin troppo ovvio che tale concetto presuppone il riconoscimento della possibilità di scelta e di selezione dei condizionamenti esterni e si pone come estrinsecazione della personalità individuale garantendo alla stessa l’isolamento da influenze perturbatrici.
È evidente che la lesione o messa in pericolo della tranquillità personale può sfociare in una aggressione alla libertà individuale, personale o morale del soggetto stesso, violando il processo di autodeterminazione del singolo ovvero, in casi estremi, può addirittura risolversi in un attentato alla sua integrità psicofisica.
Sulla scorta di questi principi teorici il D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009 ha introdotto all’art. 612bis c.p. una nuova fattispecie di reato che, sul piano più strettamente concreto tutela il singolo cittadino da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita procurando spesso ansie, preoccupazioni, paure, che le attuali norme non sono idonee a prevenire.
A mero titolo di esempio si possono ricordare i tanti atteggiamenti tenuti da soggetti un tempo legati da vincoli affettivi poi venuti meno successivamente (relazioni sentimentali interrotte, convivenze di fatto allorché uno dei due soggetti non voglia più continuare il precedente rapporto ecc.).
La natura plurioffensiva del reato di atti persecutori
Molestie gravi possono provenire anche da rapporti di vicinato o dai nuovi rapporti telematici ed informatici; si pensi, ad esempio, all’invasione dei messaggi di posta elettronica o ai social media (facebook, tik-tok, instagram ecc.) spesso non graditi sulle proprie utenze cellulari (s.m.s., m.m.s, whatsapp ecc.). Si tratta di nuovi comportamenti antisociali rispetto ai quali la tutela finora prestata non appare adeguata alle nuove esigenze di riservatezza e di tranquillità come dianzi precisati. È evidente che noi abbiamo diritto di scegliere con chi avere rapporti, abbiamo un diritto ad autodeterminarci e di selezionare con chi avere rapporti e con chi non averli. Questa è la frontiera del diritto nella società moderna.
Il reato di stalking offende proprio questo bene giuridico, cioè mette in discussione la mia possibilità di scegliere con chi avere contatti, con chi avere rapporti, quindi tutela il diritto di ogni persona a non subire nel contatto con gli altri interferenze tali che alterino in modo rilevante la sua tranquillità personale e la sfera di vita privata senza essere sorrette da esigenze di ordine sociale. Ciascuno quindi deve avere il diritto di filtrare e selezionare il contatto con gli altri, escludendo tutte le manifestazioni con le quali non voglia ovviamente avere contatti. Non è dunque soltanto – a badarci bene – il concetto della libertà morale, ma occorre far riferimento anche ai concetti di riservatezza e, in casi estremi, anche a quello di incolumità personale, e ciò in quanto la condotta può estrinsecarsi anche in minacce alla incolumità della persona offesa o dei suoi familiari o delle persone a lei legate da vincoli affettivi.
Possiamo allora concludere che il reato in esame abbia natura plurioffensiva in quanto diversi sono i beni protetti seppure tutti riconducibili ai diritti della personalità
Il nuovo delitto previsto dall’art. 612bis c.p.
La norma in esame punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Soggetto attivo
Sotto il profilo criminologico lo stalker è una persona che non riesce ad accettare l’abbandono del partner o di altra figura significativa e che cerca di ristabilire il rapporto interrotto, oppure un individuo che nutre un rancore per una causa estranea ad un rapporto affettivo, ma dovuta ad un altro tipo di rapporto (di lavoro, professionale ecc.). In altri casi lo stalker è un molestatore sessuale, che individua l’oggetto del suo desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettua una serie di tentativi di approccio.
In ogni caso trattasi di delitto comune che può essere commesso da chiunque.
Il reato di atti persecutori può essere commesso anche da una pluralità di soggetti in concorso fra loro. La Giurisprudenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che in tema di atti persecutori, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, ha rilevanza il comune movente, che pur essendo estraneo alla nozione di dolo, lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti persecutori e la sua dimensione plurisoggettiva, intesa come volontà comune di concorrere nel reato. (Fattispecie in cui il contributo di ciascuno degli imputati, componenti del medesimo nucleo familiare, alla realizzazione delle condotte criminose era originato dal comune risentimento nutrito nei confronti delle persone offese per le infamanti accuse mosse contro uno di essi) (Sez. 5, sent. 2675 del 24-1-2022 (ud. 18-10-2021) rv. 282772-01).
Soggetto passivo
Soggetto passivo del delitto di atti persecutori può essere chiunque; il delitto può essere commesso ai danni di più persone e non necessariamente la vittima dei comportamenti minacciosi coincide con la vittima dello stalking.
Integra il delitto di atti persecutori (art. 612bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre (Sez. 5, sent. 20895 del 25-5-2011 (ud. 7-4-2011) rv. 250460).
Integra il delitto di atti persecutori il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l’autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l’impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo.
Le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l’id quod plerumque accidit, a giustificare il verificarsi dell’evento di danno anche nei riguardi della persona offesa (Sez. 5, sent. 43384 del 26-10-2023 (ud. 16-10-2023) rv. 285271-01).
Qualora gli atti persecutori siano posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.
Natura: reato abituale
A proposito del concetto di reiterazione, molti autori hanno qualificato nelle prime note di commento gli atti persecutori come reato abituale; in realtà si può avanzare qualche dubbio sulla piena coincidenza fra i concetti di reiterazione e di abitualità, perché l’abitualità presuppone una pluralità di azioni (più di due) che si attuino in un tempo ben definito, ben determinato .
Se noi guardiamo le altre legislazioni, nessuna fa cenno a quante volte debba reiterarsi la molestia o la minaccia, ad eccezione della normativa inglese, la quale prevede che siano sufficienti almeno due episodi perché si verifichi il reato di stalking.
Uno studio abbastanza serio ed importante del gruppo di Mullen e Pathé sulla sindrome del molestatore assillante ha invece ritenuto che deve trattarsi di atti ripetuti per almeno 10 volte e perduranti nello spazio di tempo di almeno 4 settimane, e che tali atti devono consistere in sgraditi tentativi di avvicinarsi o di comunicare con la vittima .
La giurisprudenza, invece, non ha dubbi circa la natura abituale del reato. Secondo la Suprema Corte di cassazione si tratta di un reato abituale, che si caratterizza proprio per la ripetitività della condotta e che trova proprio in questa la ragione di una autonoma incriminazione rispetto ai singoli episodi di minaccia, molestie o di violenza privata, perché è in essa che si manifesta l’offesa penale. Ad avviso, peraltro, della costante giurisprudenza della Cassazione (da ultimo, Cass. V, 19-7-2018, n. 33842) integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la «reiterazione» richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. Deve, dunque, escludersi che tale delitto, proprio in quanto necessariamente abituale, sia configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di bis in idem (Cass. V, 20-11-2014, n. 48391).
È configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Cass. V, 15-9-2016, n. 38306).
Il delitto di atti persecutori è, altresì, configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la «reiterazione» criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale (Cass. V, 4-8-2021, n. 30525).
Integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di «sms» e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti «social network» (ad esempio «facebook»), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (Sez. 6, sent. 32404 del 30-8-2010 (cc. 16-7-2010) rv. 248285).
Elemento oggettivo: la condotta
La condotta può consistere nella minaccia o molestia che può avvenire in qualsiasi modo anche, ad esempio con mezzi telematici o informatici, al cui abuso possono conseguire nuove forme di pesanti interferenze nella vita privata. Rientrano sotto la tutela della norma anche quella vastissima area di illeciti che vengono oggi commessi a mezzo del telefono (si pensi, ad esempio, agli SMS, agli MMS o all’avvento dei video telefoni o comunque dei messaggi visivi), ovvero ancora alle molestie che attraverso la rete di internet e i vari social network (facebook, twitter, istagram) si attuano con relativa violazione della privacy. Peraltro non vi dovrebbero essere problemi di duplicazione di norme in quanto gli attentati previsti dall’art. 615bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) tutelano l’inviolabilità del domicilio ma non quello della persona. Infatti l’art. 615bis c.p. riguarda l’indebita acquisizione o divulgazione di notizie sulla vita privata, ma non le molestie o il disturbo arrecati al soggetto, indipendentemente da tali acquisizioni o divulgazioni.
Minaccia
Per il concetto di minaccia si rinvia all’ampia produzione dottrinaria e giurisprudenziale formatasi in ordine alla previsione dell’art. 612 c.p. Si riportano di seguito alcune massime esplicative della interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte al concetto di minaccia.
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612 c.p. minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio (Cass. 12-8-1986, n. 8275).
Il delitto di minaccia può attuarsi con qualsiasi mezzo o comportamento idoneo a incutere timore, senza che sia necessario l’uso di parole intimidatorie (Cass. 5-10-1982, n. 8627).
Sussiste il reato di cui all’art. 612 c.p. anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato, ritenuta inaccoglibile la tesi difensiva fondata sul rilievo che, non essendo state percepite le frasi minacciose direttamente dalla persona offesa, bensì dalle sue impiegate e per via telefonica, sarebbe venuta meno ogni loro carica intimidatrice) (Cass. 24-6-1985, n. 6289).
Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell’agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell’imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva «preso una fissazione» per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello) (Cass. 11-6-1999, n. 7571).
Ai fini della configurazione del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l’agente abbia avuto la volontà di produrre l’effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia sia stata pronunciata a persona legata al soggetto passivo da relazioni di amicizia e lavoro) (Cass. 22-9-2003, n. 36353).
In tema di minaccia, anche un mero comportamento può presentare i connotati della minaccia, in quanto, da un lato, la condotta si inserisca in un contesto reiterato di espressioni di inequivoco contenuto minaccioso e, dall’altro, esso risulti oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi (Nella specie, l’agente sostava lungamente con l’autovettura sotto l’abitazione della vittima e, sporgendosi dal finestrino, la chiamava a gran voce affinché fosse sentito da tutto il vicinato) (Cass. 12-12-2004, n. 556).
Ai fini della configurabilità del reato di minaccia (art. 612 c.p.), si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto – la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente – che può derivare anche dall’esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge; non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale (Cass. 6-2-2004, n. 4633).
Anche le frasi intimidatorie pronunziate in forma condizionata integrano il delitto di minaccia, a meno che l’intimidazione, espressa in detta forma, sia intesa non già a restringere la libertà psichica del minacciato, bensì a prevenire un’azione illecita del medesimo, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento potrebbe determinare (Cass. 3-5-1973, n. 3338).
Non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un’azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall’eventuale realizzazione di dette azioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso che l’espressione «se vedi Attilio digli che se si appoggia alla mia macchina in modo provocatorio io l’ammazzo» integri il delitto di minaccia, avuto riguardo al contesto in cui era stata proferita concernente soggetti adusi ad utilizzare messaggi convenzionali, tali da escludere la serietà della frase minatoria, costituente una sorta di avvertimento condizionato alla ostentazione di un comportamento provocatorio) (Cass. 20-7-2007, n. 29390).
Molestie
Per quanto riguarda le molestie in particolare un aiuto alla ampia casistica della giurisprudenza ci viene anche dal nostro ordinamento europeo che seppure il più delle volte non in maniera tassativa, precettiva per il nostro ordinamento statuale, ha comunque adottato sul tema una sorta di catalogo definitorio.
In particolare il Consiglio, nella delibera, la numero 2006/54 della Comunità Europea, a proposito dell’attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne ha dato una definizione sia delle molestie che delle molestie sessuali, ritenendo che per molestia si intende una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona, avente lo scopo di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
Per molestia sessuale invece si intende la situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Quanto, invece al concetto di molestia, si riportano di seguito alcuni orientamenti giurisprudenziali formatisi in sede di interpretazione dell’art. 660 c.p.
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune. Nell’ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore è pertanto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio. (Nella specie trattavasi di continuo e pressante tallonamento con la vettura da parte dell’autore del reato nei confronti del veicolo della vittima) (Cass. 24-9-1984, n. 7355).
Nella generica dizione di cui all’art. 660 c.p. «col mezzo del telefono» sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono ecc.) (Cass. 30-6-1978, n. 8759).
Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), integrano la condotta ivi prevista le proposte di appuntamenti galanti non gradite dalla interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono e, pertanto, palesemente rivolte a molestare le persone (Cass. 25-11-1992, n. 11336).
Il fatto del pedinamento, puro e semplice, non basta ad integrare gli estremi dell’azione molesta punita dall’art. 660 c.p., anche se interferisce nell’altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce. Per rientrare nella previsione della fattispecie legale il pedinamento, infatti, deve concretarsi in un’azione pressante, indiscreta e impertinente (Cass. 2-10-1978, n. 11846).
Il continuo, insistente corteggiamento, chiaramente non gradito, di una donna, che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate, realizza non solo l’elemento materiale del reato di cui all’art. 660 c.p., ossia «la molestia», ma altresì la sua componente psicologica, in quanto la relativa condotta è rivelatrice di «petulanza» oltreché di «motivo biasimevole» (Sez. 1, sent. 6905 dell’11-6-1992 (ud. 28192) rv. 190546).
Il reato di molestie telefoniche commesso assillando la parte lesa con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa non è escluso dal fatto che l’interlocutore (nel caso di specie una donna) assuma con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l’autore delle telefonate, un tono confidenziale rivolgendogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell’autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta (Cass. 25-1-1997, n. 512).
La disposizione di cui all’art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario (Cass. 17-2-2004, n. 28680).
La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato (Cass. 24-3-2004, n. 14512).
Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza. (Nel caso di specie l’imputato, ex fidanzato della persona offesa, le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all’interno del locale pubblico dove la stessa lavorava come cameriera, nonostante le espresse e ripetute rimostranze della vittima) (Cass. 18-5-2007, n. 19438).
Vediamo ora i più recenti orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di atti persecutori.
Rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori nelle condotte reiterate di inoltro alla persona offesa di post dal contenuto molesto o palesemente minaccioso, nell’appostamento effettuato nei pressi della dimora dei suoi genitori e nella grave aggressione fisica perpetrata in loro danno, tali da determinare nella stessa un perdurante e grave stato d’ansia) (Sez. 5, sent. 1753 del 17-1-2022 (ud. 16-9-2021) rv. 282426-01).
Costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un’unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell’unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell’azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612bis c.p. (Sez. 5, sent. 17171 del 21-4-2023 (cc. 16-1-2023) rv. 284399-02).
Rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata. (Fattispecie in cui l’imputato aveva distribuito, all’interno dei bagni di più autogrill, volantini contenenti offerte sessuali falsamente provenienti dalla vittima con indicazione del suo numero telefonico e del suo indirizzo, da cui erano derivate richieste alla stessa di prestazioni sessuali da parte di sconosciuti) (Sez. 5, sent. 25248 dell’1-7-2022 (ud. 12-5-2022) rv. 283369).
Integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di «sms» e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti «social network» (ad esempio, «facebook»), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (Sez. 6, sent. 32404 del 30-8-2010 (cc. 16-7-2010) rv. 248285).
La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Fattispecie relativa a provvedimento de libertate) (Sez. 5, sent. 17698 del 7-5-2010 (cc. 5-2-2010) rv. 247226.
Gli eventi
Le minacce o le molestie devono presentare il carattere dell’idoneità:
- a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero
- a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione affettiva ovvero
- tali da costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Una situazione psichica di difficile dimostrazione, in luogo della idoneità della condotta a determinare tale evento.
Non si tratta di un reato di pura condotta ma è necessario un evento di danno o di pericolo: deve conseguire al comportamento minaccioso, molesto o comunque perturbante la lesione o la messa in pericolo della libertà morale o personale ovvero dell’integrità psicofisica della persona offesa.
Dunque non è necessario che si verifichi un danno alla salute, ma è sufficiente che si produca una semplice alterazione del normale equilibrio fisico psichico del soggetto che non necessariamente trasmodi in una malattia. Il concetto di integrità psicofisica è, infatti, più ampio di quello, di salute psicofisica, avendo riguardo alla sfera complessiva della personalità e non soltanto ad una alterazione misurabile con criteri medico-legali.
Il delitto di atti persecutori ha, dunque, natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo (Sez. 5, sent. 3781 dell’1-2-2021 (ud. 24-11-2020) rv. 280331-01). Si tratta in sostanza di un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo (Sez. 5, sent. 34015 del 22-6-2010).
Primo evento: cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
È stata criticata, sotto il profilo della tassatività, la scelta di accentrare la tipicità dell’illecito sulla realizzazione di un evento, consistente in uno stato di ansia o di paura.
In merito alla nozione di ansia noi abbiamo una letteratura medica che ci dice che cosa è lo stress e ce lo quantifica e qualifica; tale stato tra l’altro deve essere grave e perdurante.
In giurisprudenza si afferma che il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi (Cass. 12-1-2010, n. 11945).
Ma la paura che cos’è? La paura è un concetto affidato alla soggettività del percettore e dunque di carattere estremamente soggettivo, perché è legata alla nostra sfera emozionale, alla nostra sensibilità, che varia da persona a persona: ciò che può far paura a me può non far paura assolutamente ad un’altra persona e viceversa.
L’evento tipico del «perdurante e grave stato di ansia o di paura», che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, non può risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subìte (Cass. V, 21-1-2021, n. 2555).
Il riferimento alla gravità è stato ritenuto elemento di ulteriore indeterminatezza. La prova del prodursi di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve, dunque, essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Cass. VI, 3-12-2014, n. 50746; Cass. V, 7-4-2017, n. 17795).
Come si fa ad accertare lo stato di ansia o di paura?
È sempre necessaria una perizia sulla vittima? In realtà non sempre lo stato di ansia e di paura si traduce in una patologia medicamente accertabile attraverso una perizia. È però evidente che qualora vi sia una documentazione medica che certifica lo stato di ansia e di paura, il giudice avrà a disposizione un elemento di valutazione, perché i centri antiviolenza, molto meglio del perito o del certificato del pronto soccorso sanitario, fanno un percorso di osservazione della vittima e possono accertare effettivamente se sussistano danni che la persona offesa ha subito a seguito degli atti persecutori. Pertanto ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612bis c.p.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (così Cass. 10-1-2011, n. 16864). Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l’evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5, sent. 8832 del 7-3-2011 (cc. 1-12-2010). La prova del grave e perdurante stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, ovvero aggravino una preesistente situazione di disagio psichico della persona offesa (Sez. 5, sent. 7559 del 2-3-2022 (ud. 10-1-2022) rv. 282866-01).
Secondo evento: «ingenerare un fondato timore»
Anche l’esegesi di questa parte della norma in esame pone problemi di interpretazione. In particolare ci si chiede quando un timore possa dirsi fondato. È fondato il timore che sia idoneo a cagionare la messa in pericolo o la lesione dell’incolumità.
Altra questione problematica si rinviene nel concetto di «persona legata affettivamente alla vittima». Chi è la persona legata affettivamente? È quella legata da un vincolo di amicizia, è quella con la quale io convivo o ho una comunanza di vita, è il mio conoscente occasionale, è il mio compagno di viaggio?
La giurisprudenza della S.C. ha ritenuto che le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l’id quod plerumque accidit, a giustificare il verificarsi dell’evento di danno anche nei riguardi della persona offesa (Sez. 5, sent. 43384 del 26-10-2023 (ud. 16-10-2023) rv. 285271-01).
Terzo evento: «costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita»
Che cosa si intende per abitudini di vita?
Anche questo è un concetto la cui definizione appare alquanto problematica, perché l’abitudine di vita sussiste sicuramente se io cambio lavoro, se io cambio città, quindi se trasferisco il mio domicilio. Ma se per esempio io ho il guardone di fronte, il quale ogni mattina si mette alla finestra e mi disturba perché mi vede mentre io in pigiama prendo il caffè e quindi sono costretto o a vestirmi o ad oscurare la finestra e quindi cambio in qualche modo una mia abitudine di vita, possiamo dire che questo è un cambio di abitudine di vita rilevante?
Naturalmente l’esempio è paradossale, ma serve a far capire come in realtà questo è un concetto sul quale bisogna riflettere, perché non qualsiasi abitudine di vita evidentemente sarà tale da integrare l’evento così come è previsto.
La giurisprudenza della S.C. ha dettato i seguenti principi interpretativi:
- ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Cass. V, sent. 29872 del 6-7-2011 (cc. 19-5-2011) rv. 250399;
- ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, quale elemento integrativo del delitto, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Cass. V, 9-6-2014, n. 24021; Cass. V, 6-3-2018, n. 10111);
- l’evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa può essere anche transitorio, ma non occasionale (Cass. V, 6-5-2021, n. 17552);
- l’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Cass. VI, 1-3-2021, n. 8050).
L’alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 612bis c.p., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane (Cass. V, sent. 1541 del 14-1-2021 (cc. 17-11-2020) rv. 280491-01.
Elemento soggettivo
Nel delitto di atti persecutori, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Cass. V, 26-10-2015, n. 43085, nonché Cass. I, 15-10-2020, n. 28682); il dolo, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Cass. V, 8-5-2014, n. 18999).
Consumazione e tentativo
Il delitto di atti persecutori, si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l’unitarietà della condotta di «stalking» non può essere interrotta dall’essersi realizzato prima l’uno o l’altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice (Sez. 5, sent. 3781 dell’1-2-2021 (ud. 24-11-2020) rv. 280331-01).
Stabilire il momento della consumazione del delitto di atti persecutori è importante perché da quel momento decorre sia il termine di prescrizione del reato che il termine per proporre la querela (a meno che non ci si trovi di fronte ad una delle ipotesi di perseguibilità di ufficio).
Come già detto, il delitto è un reato abituale proprio, per la cui commissione è necessaria la realizzazione di più atti di minaccia o molestie.
Si è affermato in giurisprudenza che, nel delitto in esame, che è reato abituale e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l’accertamento processuale, cosicché non si configura violazione del principio del ne bis in idem in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia (Cass. V, 8-5-2017, n. 22210, nonché Cass. V, 8-6-2020, n. 17350).
Nel medesimo senso, si afferma che il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l’unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall’essersi realizzato prima l’uno o l’altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice (Cass. V, 1-2-2021, n. 3781).
Si afferma che il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità della condotta a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612bis c.p. (Cass. V, 13-11-2019, n. 46165, nonché Cass. V, 5-6-2020, n. 17240). Inoltre, il delitto è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (Cass. V, 21-2-2019, n. 7899).
La consumazione del reato in esame prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612bis c.p. (Cass. V, 24-1-2020, 3042).
Da ultimo, si è affermato che il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e di danno che si consuma con la realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612bis c.p., conseguente al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, così che, nell’ipotesi di «contestazione aperta», il giudizio di penale responsabilità dell’imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell’originaria imputazione, anche a fatti verificatisi successivamente alla presentazione della denunzia-querela e accertati nel corso del giudizio, non determinandosi una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e da pregiudicare il diritto di difesa (Cass. V, 21-5-2020, n. 15651).
Nel medesimo senso, si è affermato che il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l’unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall’essersi realizzato prima l’uno o l’altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice (Cass. V, 1-2-2021, n. 3781).
Il reato è compatibile con il tentativo. In particolare, si è ritenuto configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori in quanto, trattandosi di reato di evento, è logicamente e giuridicamente possibile che alla commissione della condotta, ossia degli atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi tipici di cui all’art. 612bis c.p., siano essi di danno o di pericolo, non segua l’effettiva causazione degli stessi (Cass. 18-1-2021, n. 1943).
Le circostanze aggravanti
La norma dell’art. 612 bis c.p. prevede due specifiche aggravanti:
- la prima ad efficacia comune, se il fatto è commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Sull’originario impianto normativo di questa aggravante è intervenuto il D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013 (provvedimento noto come decreto anti-femminicidio e violenza di genere). In particolare, si è provveduto ad estendere il novero delle ipotesi aggravate al fatto commesso dal coniuge in costanza di vincolo matrimoniale con la vittima (in precedenza l’aggravante era connessa allo stato di legale separazione o divorzio del medesimo, la qual cosa riduceva in modo significativo i margini di applicabilità dell’aggravante, in relazione ad un reato di frequentissima ricorrenza intraconiugale).
In sede di riforma della previsione, si è, altresì, attribuito rilevo aggravante al fatto commesso nell’ambito di relazioni affettive in atto (in precedenza rilevavano solo i legami pregressi fra reo e persona offesa; la relazione affettiva, peraltro, assume rilievo se produce l’insorgere di un rapporto di abituale frequentazione, tale da generare sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale: ciò in quanto è parso opportuno evitare il rischio di indefinibili interpretazioni estensive dell’aggravante). Sostanzialmente analogo a tale correttivo è quello che ha interessato il delitto di violenza sessuale aggravata (di cui si è detto esaminando l’art. 609ter, ed al cui esame si rinvia).
Circa il concetto di relazione affettiva, la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto che la «relazione affettiva» tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come «stabile condivisione della vita comune», postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l’abuso o l’approfittamento di tale legame il fondamento della ratio di aggravamento della disposizione in esame (Sez. 5, sent. 21641 del 19-5-2023 (ud. 2-3-2023) rv. 284696-01).
Ulteriore, significativa, innovazione si è tradotta nell’attribuire specifico rilievo aggravante al cd. cyber-stalking, realizzato, cioè, mediante strumenti informatici o telematici. Si è, peraltro, osservato come gli strumenti telematici presuppongano quelli informatici, dunque non possano porsi come alternativi (del resto, è con la telematica che può commettersi il reato, in quanto le persecuzioni sono realizzabili solo mediante comunicazione).
Rileva, dunque, l’invio di messaggi sms o di posta elettronica e l’impiego di social network, che propalando contenuti verbali ed immagini in maniera indefinita, possono tradursi in strumenti di persecuzione almeno molesta. Taluni hanno, peraltro, espresso dubbi sull’opportunità di considerare aggravate condotte persecutorie «a distanza» (quali quelle telematiche) rispetto a quelle commesse mediante contatto diretto con la vittima;
- la seconda ad effetto speciale (la pena è aumentata fino alla metà) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della L. 5-2-1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
La ratio di questa aggravante consiste nell’accentuare l’oggettivo disvalore penale della fattispecie in conseguenza della particolare «vulnerabilità» di talune potenziali vittime del reato in esame, meritevoli, dunque, di tutela penale «rafforzata», ovvero delle modalità oggettive (l’uso di armi) o soggettive (travisamento) della condotta posta in essere.
Viene prevista una ulteriore aggravante anch’essa ad efficacia comune e nel caso in cui il reato venga commesso da chi è stato ammonito dal Questore.
Ulteriore aggravante per l’art. 612bis c.p. è stata prevista dalla L. 168/2023 se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l’ammonimento.
Quindi la condotta è aggravata ed è procedibile d’ufficio qualora il soggetto, già ammonito per uno dei reati indicati, tra i quali il delitto di atti persecutori (nell’ambito della violenza domestica) commetta uno qualunque di tali reati (nell’ambito della violenza domestica) nei confronti della stessa persona offesa o di altra vittima. La ratio è chiara: prevedere apposite misure per prevenire ulteriori condotte di violenza domestica, intesa non solo come violenza ai danni di una vittima specifica (ipotesi usuale), ma come condotta delittuosa che ben può essere posta in essere ai danni di altre persone offese, generalmente donne, come risulta dalla concreta esperienza.
Rapporti con altri reati
Svariati problemi sono sorti dalla comparazione fra il reato di atti persecutori e gli altri reati con i quali può eventualmente concorrere; problemi acuiti dalla clausola di salvezza contenuta nella norma in esame secondo la quale prevede l’applicabilità del delitto di atti persecutori salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Così ad esempio è stato ritenuto che il delitto di cui all’art. 612bis c.p. possa concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) avendo oggetto giuridico diverso, mentre restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sé reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente (Cass. V, 18-5-2016, n. 20696). Si è altresì ritenuto che il delitto di atti persecutori possa concorrere con quello di diffamazione, anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall’art. 612bis c.p. (Sez. 5, sent. 49288 dell’11-12-2023 (ud. 15-11-2023) rv. 285559-01), e con quello di violenza privata, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell’art. 15 c.p., dal momento che il delitto di cui all’art. 612bis c.p., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l’esercizio della violenza e contempla un evento come l’alterazione delle abitudini di vita della vittima di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall’art. 610 c.p. (Cass. V, 22-5-2019, n. 22475).
Spesso risulta problematica la distinzione fra il reato di atti persecutori e quello di maltrattamenti in famiglia. La S.C. ha indicato alcuni parametri distintivi, quali ad esempio, la cessazione della convivenza more uxorio. Ha infatti stabilito la S.C. che il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di «famiglia» e di «convivenza» di cui all’art. 572 c.p. nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612is, comma 2, c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa (Sez. 6, sent. 31390 del 19-7-2023 (ud. 30-3-2023) Rv. 285087-01). In altro arresto giurisprudenziale, tuttavia, si sostiene che integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta «persona della famiglia» fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. (In motivazione la Corte ha precisato che la separazione è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, c.c.) (Sez. 6, sent. 45400 del 29-11-2022 (ud. 30-9-2022) rv. 284020-01). In altro arresto la S.C. ha addirittura ritenuto configurabile il concorso fra i due reati, affermando che è configurabile il concorso fra i reati di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori) (Sez. 6, sent. 10626 del 24-3-2022 (ud. 16-2-2022) rv. 283003-02).
La norma, si distingue, altresì, dalla contravvenzione prevista dall’art. 660 c.p. perché non richiede la commissione in luogo pubblico o aperto al pubblico, né tantomeno i requisiti soggettivi della petulanza o altro biasimevole motivo: si tratta di una fattispecie a dolo generico.
Pertanto anche la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) può concorrere con il delitto di atti persecutori e ciò in quanto ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. (Cass. V, 24-3-2016, n. 12528). Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Cass. VI, 30-7-2020, n. 23375; nel medesimo senso, Cass. V, 26-4-2021, n. 15625).
Rapporto fra stalking e omicidio aggravato ex art. 576 c. 1, n. 5.1), c.p.
Particolarmente discusso è il rapporto fra il reato di atti persecutori e l’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1), c.p., il quale prevede la pena dell’ergastolo se il fatto omicidiario è cagionato dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa.
L’omicidio del soggetto perseguitato si presenta, infatti, nell’esperienza giudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell’intento di annullamento della personalità della vittima; e quindi si integra compiutamente nella complessiva direzione finalistica del fatto, come peraltro sottolineato nei rammentati lavori preparatori.
L’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5.1) venne introdotta proprio dal D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi, che può così sintetizzarsi: «Se, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1), c.p. concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.».
In proposito, va ricordato che l’art. 84, comma 1, c.p. esclude l’applicazione delle disposizioni sul concorso di reati quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato». Quindi, condizione imprescindibile per la ravvisabilità della figura del reato complesso è l’interferenza fra le norme incriminatrici su un fatto oggettivo, comune agli ambiti applicativi delle stesse. La ratio di tale previsione è quella di evitare una duplicazione della risposta sanzionatoria per gli stessi fatti in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, necessità che si manifesta «segnatamente nel rapporto fra il reato complesso e gli altri reati che lo compongono, contraddistinti da un contesto unitario, nell’ambito del quale maggiormente risalta la possibilità di una sproporzione nel cumulo di pene previste per fatti inseriti nella stessa azione criminosa».
L’intenzione del legislatore era nell’occasione chiaramente espressa dall’intento di affrontare con adeguato rigore sanzionatorio un fenomeno criminale notoriamente ricorrente ed ingravescente nella realtà attuale, ossia il verificarsi di fatti omicidiari in danno di vittime di atti persecutori da parte degli stessi autori di tali atti. Orbene, in questa prospettiva la ratio della previsione si individua nella risposta ad un fatto complessivo visto come meritevole di aggravamento per la sua oggettiva valenza criminale, ossia lo sviluppo omicidiario di una condotta persecutoria, con l’effetto di sanzionare tale aggravamento con la massima pena dell’ergastolo; nel quale, pertanto, tale condotta è intranea nella sua fattualità alla struttura della disposizione circostanziale. La fattispecie in esame presenta, in conclusione, le caratteristiche strutturali del reato complesso circostanziato, che include il reato di atti persecutori in una specifica forma aggravata del reato di omicidio.
Non vi è dubbio infatti che, se l’intento legislativo alla base della previsione dell’aggravante è quello di perseguire con maggiore severità l’omicidio costituente sviluppo della condotta persecutoria, è a questa dimensione fattuale che deve aversi riguardo per la definizione della fattispecie aggravante; e quindi ad una situazione nella quale gli atti persecutori e l’omicidio presentano non solo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalistica unitaria.
Dunque secondo la Corte nomofilattica il reato di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1), c.p., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p. (così SS.UU. sent. 38402 del 26-10-2021 (ud. 15-7-2021) rv. 281973).
E ciò in quanto la norma per l’omicidio aggravato assorbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa.
Le Sezioni Unite hanno anche evidenziato come per il caso del reato complesso circostanziato, nel rapporto fra omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1), c.p. e delitto di atti persecutori, affinché il secondo sia assorbito nel primo, occorre che debbano sussistere oltre agli «elementi strutturali esplicitamente indicati dalla norma, anche un ulteriore elemento sostanziale, costituito dall’unitarietà del fatto che complessivamente integra il reato riconducibile a questa fattispecie», aggiungendo che il concetto di unitarietà «si presenta come articolato non solo nella contestualità dei singoli fatti criminosi sussunti della fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica».
La procedibilità
Il delitto è punito normalmente a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi, allungato al doppio di quello ordinario previsto dall’art. 124 c.p. (tre mesi).
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della L. 5-2-1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile di ufficio. La procedibilità di ufficio è inoltre prevista quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi dell’art. 8 del D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009.
L’art. 1 della nuova L. 168/2023 ha inoltre modificato l’art. 3 della L. 119/2013, prevedendo al comma 5quinquies che si procede d’ufficio per il reato di cui all’art. 612bis c.p. anche quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
A proposito della procedibilità di ufficio in caso di ammonimento da parte del questore, la S.C. ha statuito che ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento del questore, non è necessario che vi sia coincidenza tra i fatti oggetto di segnalazione e i fatti di rilevanza penale, in quanto i presupposti di intervento dell’autorità amministrativa si differenziano da quelli dell’autorità giudiziaria sia sul piano della ricognizione dei fatti che lo legittimano, sia in relazione alle modalità del loro accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti oggetto di ammonimento possono assumere rilievo penale qualora, nonostante lo stesso, siano seguiti da condotte espressione del medesimo comportamento molesto) (Sez. 5, sent. 1035 del 13-1-2022 (ud. 30-9-2021) rv. 282732-01).
Sulla procedibilità del reato di atti persecutori aveva già inciso il D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013, con correttivi oggetto di scelte e ripensamenti in sede di conversione. In particolare, il decreto si era limitato a sancire che la querela proposta dovesse essere irrevocabile, in ragione dei rischi cui poteva essere esposta la vittima del reato, possibile obiettivo di ulteriori minacce e violenze finalizzate ad ottenere, per l’appunto, il ritiro della querela. La legge di conversione ha, invece, rimesso in discussione tale opzione normativa, cercando un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà della vittima del reato e di garantirle una tutela effettiva contro il menzionato rischio di essere sottoposta ad indebite pressioni. In tale ottica, si è ripristinata la revocabilità della querela, salvo che nel caso in cui il reato sia stato realizzato mediante minacce reiterate gravi (quelle, cioè perpetrate nei modi di cui all’art. 612, comma 2, c.p.), ma si è posta la condizione che la remissione sia esclusivamente «processuale». In proposito, ha precisato la Cassazione che deve ritenersi idonea ad estinguere il reato in esame anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall’autorità giudiziaria, atteso che l’art. 612bis, comma 4, c.p., laddove fa riferimento alla remissione «processuale», evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. (Cass. IV, 21-4-2016, n. 16669; Cass.V, 25-1-2021, n. 3034). La S.C. ha altresì statuito che ai fini dell’irrevocabilità della querela, non è necessario che la gravità delle reiterate minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità di realizzazione della condotta, incidente sulla revocabilità della querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell’imputazione) (Sez. 5, sent. 34412 del 4-8-2023 (ud. 11-5-2023) rv. 284992-01).
Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con «l’evento di danno» consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con «l’evento di pericolo» consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto (Cass. V, 23-4-2015, n. 17082).
Il problema della consumazione del reato è legato alla querela, che può essere proposta nel termine (lungo) di 6 mesi, ma da quando decorre questo termine? In altri termini quando si consuma il reato di stalking?
Il problema posto non è di poco rilievo e implica anche la considerazione e qualificazione che devono ricevere eventuali ulteriori episodi di stalking verificatisi dopo la proposizione della querela.
Se si ritiene che nel momento in cui viene proposta querela il reato si è consumato, i successivi comportamenti dovrebbero considerarsi come un post factum non punibile (conseguenza questa davvero aberrante), né sembrerebbe possibile utilizzare la categoria della continuazione di cui all’art. 81 c.p., perché, trattandosi di atti persecutori (pluralità di atti) che devono possedere il requisito della reiterazione, è del tutto evidente la incompatibilità ontologica con l’istituto della continuazione, vale a dire con un reato che si consuma in più occasioni più volte.
Se quindi il reato si è già consumato prima della proposizione della querela, i successivi comportamenti pur astrattamente rientranti nel paradigma dell’art. 612bis c.p. dovrebbero considerarsi come un post factum non punibile, a meno che non sia nel frattempo intervenuta una sentenza quanto meno di primo grado la cui emanazione consentirebbe di poter contestare un nuovo reato di stalking.
È del tutto evidente che questo (paradossale) ragionamento non possa essere condivisibile, come parimenti non condivisibile ed arbitrario appare porre un limite temporale alla consumazione del reato (tot comportamenti in tot tempo), dovendosi, invece, ritenere che il reato di stalking si consuma e si reitera fino all’ultimo atto che viene consumato, per cui se dopo la proposizione della querela c’è un altro atto di stalking ovviamente questo entrerà in contestazione anche con quello precedente alla querela.
Questa conclusione è confortata dalla interpretazione giurisprudenziale della Corte di cassazione. Quest’ultima, infatti, ha ritenuto che il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato (Cass. V, 3-10-2016, n. 41431).
La procedura di ammonimento (D.L. 11/2009, conv. in l. 38/2009)
L’art. 8 del D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009 prevede una speciale procedura di carattere amministrativo che conduce ad una misura preventiva atta ad anticipare la tutela della persona offesa: si tratta dell’ammonimento.
Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612bis c.p., introdotto dall’art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
La pena per il delitto di cui all’art. 612bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
All’art. 8 della legge istitutiva dello stalking è stata introdotta una speciale procedura di competenza dell’autorità di P.S., che può adottare prima dell’instaurazione del procedimento penale, qualora la persona offesa prima di proporre la querela esponga i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Questi, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
Fra i compiti specifici dell’autorità di P.S., infatti, all’art. 1 del T.U. di P.S. è previsto il bonario componimento dei dissidi privati.
Con il provvedimento di ammonimento, il Questore invita il soggetto denunciato ad astenersi dai comportamenti delittuosi di molestia o disturbo.
Deve ritenersi che il soggetto ammonito abbia comunque facoltà di difendersi anche in questa sede presentando memorie o deduzioni.
Se nonostante la diffida formale il soggetto denunciato continua nei suoi comportamenti, è previsto un aggravamento della pena prevista per il reato di atti persecutori.
L’ammonimento, in sostanza, dovrebbe avere una immediata efficacia dissuasiva e potrebbe, peraltro, risolvere i casi meno gravi.
Si tratta di una procedura che ha valore e forza di atto amministrativo con specifiche funzioni di natura preventiva, il cui esito, però, viene preso in considerazione in sede di procedimento penale.
In altri disegni di legge proposti anche nelle precedenti legislature l’istituto in esame era sottoposto ad autorizzazione da parte del Pubblico Ministero. Tale autorizzazione nel D.L. in esame è stata eliminata e ciò in quanto si tratta di una misura di carattere preventivo che ha natura amministrativa i cui effetti poi si riverberano nel procedimento penale e pertanto non vi era alcuna necessità di prevedere l’autorizzazione del P.M.: infatti un processo di giurisdizionalizzazione avrebbe poi comportato la convalida della misura da parte dell’A.G. (GIP) con il relativo regime delle impugnazioni (riesame, cassazione) assimilandola, in buona sostanza, ad una ulteriore misura coercitiva che avrebbe appesantito inutilmente l’istituto che, invece, mantenendosi nell’alveo della mera prevenzione, meglio risponde allo scopo cui è diretto di costituire un agevole e veloce strumento per impedire situazioni di pericolo.
I provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 8 del D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009, possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5bis e tenuto conto dei relativi esiti. Quest’ultima disposizione è stata introdotta dall’art. 1 della L. 168/2023 che ha modificato in tal senso l’art. 3 del D.L. 14-8-2013, n. 93, conv. in L. 15-10-2013, n. 119.
L’art. 1 della L. 168/2023 modifica l’art. 8 del D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009:
- a) ampliando l’ambito di applicabilità (comma 1), per cui l’ammonimento richiesto dalla persona offesa, prima di proporre querela, riguarda non solo l’art. 612bis c.p. (atti persecutori), ma anche l’art. 612ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti i seguenti delitti), indipendentemente dall’essere stati commessi nell’ambito della violenza domestica;
- b) prevedendo effetti sostanziali e procedurali quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del citato articolo e (innovativamente) anche se la persona offesa è diversa da quella per cui è stato già adottato l’ammonimento (commi 3 e 4):
- le pene sono aumentate, trattasi di aggravante comune, perciò con aumento fino a un terzo ex art. 64, comma 1, c.p.;
- si procede d’ufficio.
Va affrontata infine la problematica relativa alla facoltà della persona ammonita di esercitare la propria difesa sin dalla fase preventiva: questi potrà eventualmente presentare memorie o deduzioni: ciò anche al fine di evitare che denunce infondate possano avere seguito.
La procedura di ammonimento prevista dalla L. 119/2013
La procedura di ammonimento è stata prevista anche dalla successiva L. 119/2013. Anche su tale disposizione ha inciso l’art. 1 della L. 168/2023 (Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime) che interviene sull’ammonimento applicato dal questore nella materia in esame sulla base di due diverse normative:
- il D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013, che prevede l’ammonimento applicato d’ufficio dal questore per condotte di violenza domestica, attraverso un procedimento avviato dalle forze dell’ordine in presenza di condotte riconducibili all’art. 582, comma 2, c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all’art. 581 (percosse, anch’esse punibili a querela), consumate o tentate, nell’ambito, appunto, di violenza domestica espressamente definita;
- il D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009, che prevede l’ammonimento applicato dal questore su richiesta della persona offesa del delitto di cui all’art. 612bis (atti persecutori) perseguibile a querela, richiesta che può essere presentata fino a che non è proposta la querela, di cui si è detto prima.
La nozione di violenza domestica
Il legislatore prevede che ai fini della procedibilità d’ufficio o della sussistenza dell’aggravante, il nuovo reato debba essere commesso nell’ambito della violenza domestica, conseguentemente richiama espressamente la nozione contenuta nell’art. 1, comma 1, secondo periodo. Tale definizione, originariamente prevista solo «Ai fini del presente articolo» si espande all’area del diritto penale, dovendo accertarsi se il reato (ai fini della procedibilità e della contestazione dell’aggravante) sia riferibile alla violenza domestica.
La violenza domestica è un fenomeno che si verifica all’interno di una coppia spostata o convivente. In senso più ampio invece, si manifesta all’interno della famiglia, legittima o di fatto. Non rileva che il legame sia di tipo eterosessuale o omosessuale.
Secondo l’art. 3 della Convenzione di Istanbul «l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».
Una definizione ampia che arriva a ricomprendere anche rapporti passati senza convivenza e non di coppia. Ne sono un esempio quello tra genitori e figli, fratello e sorella e tra familiari di generazioni diverse. Non sono quindi esclusi dal fenomeno i bambini e gli anziani.
La Convenzione di Istanbul riconosce che la violenza domestica colpisce le donne in misura decisamente sproporzionata. Essa tuttavia si rivolge anche a quegli uomini, che in determinati contesti possono essere vittime di gesti violenti. La Convenzione include inoltre i bambini testimoni di episodi di violenza domestica tra le vittime del fenomeno.
Definizione di violenza domestica per la legge italiana
Una definizione più ristretta rispetto quella contenuta nella Convenzione di Istanbul è quella dell’art. 3 del D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013. Detto articolo dispone che si intendono per violenza domestica, uno o più atti gravi, ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare (o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva), indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Le nuove disposizioni relative all’ammonimento d’ufficio
L’art. 1 della L. 168/2023 modifica in più parti la disciplina dell’ammonimento applicabile d’ufficio dal questore. Assumono rilievo in questa sede alcune modifiche.
Le modifiche all’art. 3, comma 1, D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013
Plurime le modifiche apportate dall’art. 1 della L. 168/2023 all’art. 3 del D.L. citato:
- a) viene ampliato l’ambito di applicabilità, per cui l’ammonimento può essere emesso (d’ufficio) per i seguenti delitti, tentati o consumati (alcuni perseguibili d’ufficio, altri a querela, perciò in quest’ultimo caso indipendentemente dalla presentazione della querela), ritenuti reati spia che richiedono un immediato intervento per interrompe la violenza:
1) art. 581 c.p. (percosse), già previsto in precedenza;
2) art. 582 c.p., indipendentemente dalle diverse ipotesi previste nella versione previgente (in precedenza il riferimento era al solo comma 2, lesioni personali perseguibili a querela);
3) art. 610 c.p. (violenza privata);
4) art. 612, comma 2, c.p. (minaccia aggravata);
5) art. 612bis c.p. (atti persecutori);
6) art. 612ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
7) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
8) art. 635 c.p. (danneggiamento).
- b) è estesa la nozione di violenza domestica, nell’ambito della quale devono essere commessi i delitti su indicati per consentire l’ammonimento.
Per espressa dizione normativa, si intendono commessi nell’ambito della violenza domestica: uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica gravi ovvero non episodici o (a seguito della modifica) commessi in presenza di minorenni, che si verificano: all’interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Viene ripresa, come ricordato in precedenza, la nozione di violenza domestica prevista dalla Convenzione di Istanbul.
- c) sono previsti, innovativamente, effetti sostanziali e procedurali quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica (come su definita), da soggetto già ammonito ai sensi del citato articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per cui è stato già adottato l’ammonimento:
- le pene sono aumentate; trattasi di aggravante comune, perciò con aumento fino a un terzo ex art. 64 c.p. (comma 5quater);
- si procede d’ufficio, nei casi in cui è prevista la perseguibilità a querela (comma 5quinqunquies).
Quindi la condotta è aggravata ed è procedibile d’ufficio qualora il soggetto, già ammonito per uno dei reati indicati (nell’ambito della violenza domestica) commetta uno qualunque di tali reati (nell’ambito della violenza domestica) nei confronti della stessa persona offesa o di altra vittima. La ratio è chiara: prevedere apposite misure per prevenire ulteriori condotte di violenza domestica, intesa non solo come violenza ai danni di una vittima specifica (ipotesi usuale), ma come condotta delittuosa che ben può essere posta in essere ai danni di altre persone offese, generalmente donne, come risulta dalla concreta esperienza e dalla relazione della commissione femminicidio che individua una recidiva dell’85%.
Naturalmente l’informazione sull’esistenza di un ammonimento in atto dovrà essere fornita dalla polizia giudiziaria all’atto della trasmissione della notizia di reato acquisendola dal Sistema Informativo di Indagine, anche verificando, se necessario, presso la questura l’operatività dell’ammonimento.