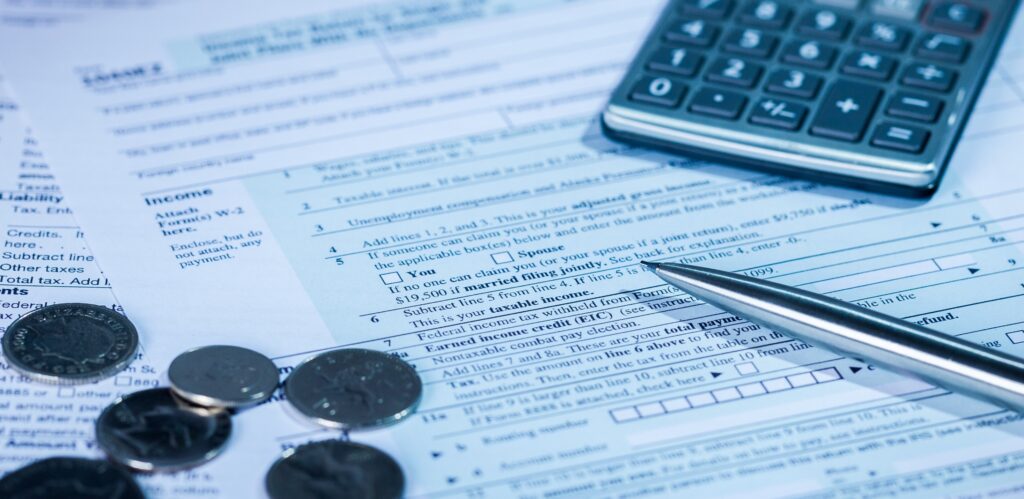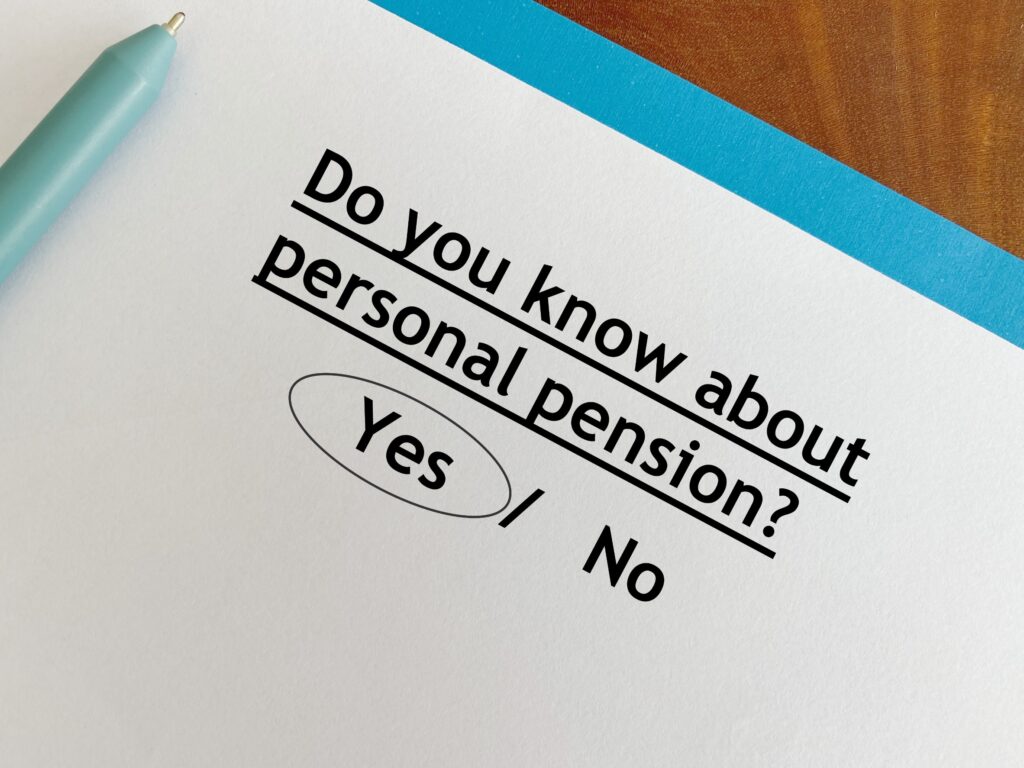Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino
L’art. 167, comma 1, cod. pen. mil. pace deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. – Corte cost. 2 dicembre 2022, n. 244.
La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., q.l.c. dell’art. 167 c.p.m.p., censurandolo nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità, attenuazioni della pena per fatti di lieve entità. Si ritiene violato il principio di uguaglianza nella misura in cui il menzionato art. 167 punisce le medesime condotte previste dall’art. 253 c.p. con l’unica differenza relativa al soggetto attivo (nel primo caso, il militare; nel secondo, chiunque); tuttavia, al delitto previsto dall’art. 253 c.p. sarebbe applicabile l’attenuante di cui all’art. 311 c.p., mentre analoga circostanza non è contemplata dal codice penale militare di pace, lacuna non superabile in via interpretativa. In secondo luogo, si paventa la violazione del principio di proporzionalità in quanto il citato art. 167 prevede una sanzione fissa e inderogabile, improntata nel minimo edittale ad asprezza eccezionale, senza possibilità di mitigare, in funzione del concreto disvalore del fatto, il severo trattamento sanzionatorio contemplato. Di conseguenza, l’impossibilità di individualizzare quest’ultimo risulta in contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost., secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 5 dicembre 2018, n. 222).
La Corte costituzionale muove dalla ricognizione delle numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., di previsioni dalle quali discendeva per il militare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello riservato al comune cittadino (es. la mancata previsione del rilievo scusante, anche nell’ordinamento militare, dell’ignoranza inevitabile della legge penale: Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 61).
Da tale giurisprudenza può evincersi che, in linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni è irragionevole a fronte della sostanziale identità della condotta punita, dell’elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato.
Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono, invece, in contrasto con il principio di uguaglianza laddove siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni che vengono a raffronto, o del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato, come nell’ipotesi delle norme incriminatrici che puniscono fatti commessi da militari nei confronti di altri militari, allo scopo di salvaguardare la coesione interna alle Forze armate e le delicate funzioni attribuite.
La Corte costituzionale, dunque, disattende le osservazioni del giudice rimettente in merito alla pedissequa sovrapponibilità degli artt. 253 c.p. e 167 c.p.m.p., in quanto ogni appartenente alle Forze armate, a differenza del comune cittadino, è responsabile dell’installazione militare e della sua custodia ai sensi dell’art. 723, D.P.R. 90/2010 ed è, dunque, gravato da precisi doveri di diritto pubblico.
Tuttavia, la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità ricompresi nel perimetro applicativo dell’art. 167 c.p.m.p. viola il principio di proporzionalità della pena. Sono ipotizzabili, infatti, sabotaggi di lieve entità consistenti, a titolo esemplificativo, nel rendere meramente inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, le cose elencate nell’art. 167 c.p.m.p., come nel caso del rifornimento con carburante non idoneo.
L’assenza, in tale ultimo codice, di una circostanza attenuante equiparabile all’art. 311 c.p. comporta che il tribunale militare sia vincolato ad applicare la pena della reclusione non inferiore a otto anni anche rispetto a condotte del militare che non provochino alcun disservizio significativo.
La soluzione non può consistere nell’estensione, al delitto di cui all’art. 167 c.p.m.p., della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 c.p., poiché quest’ultimo non costituisce idoneo tertium comparationis. Appare, invece, più corretto richiamare l’art. 171, n. 2), c.p.m.p. laddove prevede che la pena sia diminuita (nella misura sino a un terzo ex art. 51, n. 4, c.p.m.p.) “se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità”; la disposizione dev’essere estesa al solo frammento dell’art. 167 c.p.m.p. concernente le condotte di sabotaggio temporaneo, consistenti nel rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, le cose elencate dallo stesso art. 167.
Ne discende la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 167 c.p.m.p. “nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità”.
| PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Corte cost. 8 luglio 2021, n. 143; Corte cost. 17 luglio 2017, n. 205;
Corte cost. 18 aprile 2014, nn. 105 e 106; Corte cost. 15 novembre 2012, n. 251;
Corte cost. 23 marzo 2012, n. 68 |