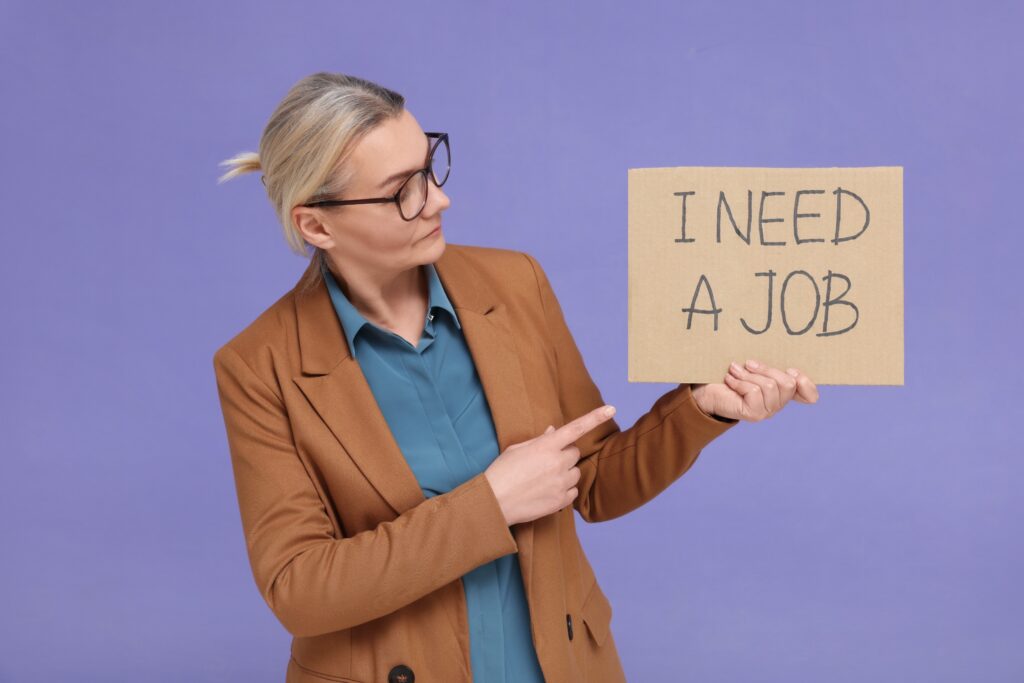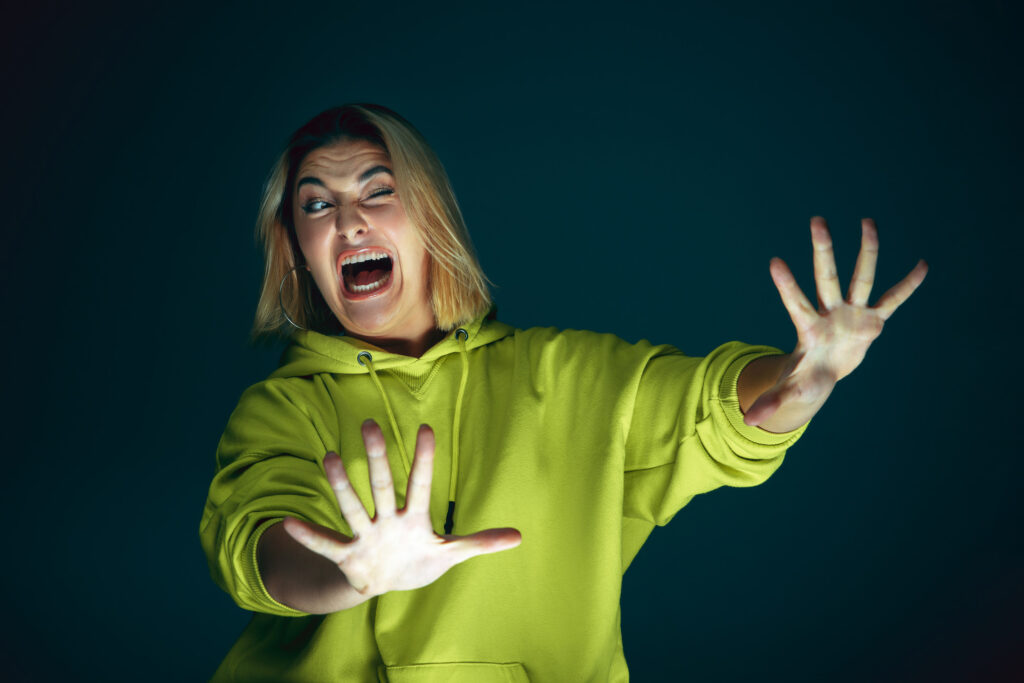Dl Lavoro è legge: cosa prevede Convertito dalla legge n. 199/2024 il Dl Lavoro n. 160/2024, che contrasta il lavoro sommerso e recluta nuovo personale docente per attuare al meglio il PNRR
DL Lavoro n. 160/2024: convertito in legge
La legge n. 199/2024 ha convertito con modifiche il decreto Lavoro n. 160/2024, che era stato approvato dal Governo e in vigore dal 29 ottobre 2024.
Leggi il testo coordinato del dl n. 160/2024 e della legge di conversione
Il provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” si compone di 12 articoli, raggruppati in tre capi: lavoro, sistema universitario e istruzione.
DL Lavoro: lotta al lavoro sommerso
L’articolo 1 dedicato al contrasto del lavoro sommerso, prevede che dal 1° gennaio 2026 vengano introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva. Questa previsione vuole promuovere il rispetto degli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia, dopo aver sentito l’INPS e l’Ispettorato nazionale del Lavoro, dovranno approvare i primi due ISAC entro il 31 dicembre 2025. Dovranno quindi individuare ulteriori 6 settori a rischio di evasione contributiva entro il 31 agosto 2026.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà consentire l’accesso al portale nazionale del sommerso alle amministrazioni pubbliche e agli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.
Per contrastare la disoccupazione l’articolo 2 del provvedimento riconosce ai dipendenti dei datori di lavoro, anche artigiani, un’integrazione al reddito. La disposizione si rivolge in particolare agli artigiani, che nel semestre precedente abbiano occupato fino a 15 addetti nei settori tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature e conciario.
L’articolo 3 stabilisce che un decreto del Presidente del Consiglio, che dovrà essere adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà stabilire annualmente, in misura percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, da destinare alle crisi occupazionali che compiscono i soggetti impiegati in questi settori.
Reclutamento e Consiglio Universitario Nazionale
L’art. 4 istituisce i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti dal bando del 2023. Il tutto per garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR.
Nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale, il decreto prevede che lo stesso continui a operare nella composizione attuale fino al 31 luglio 2025. A questa novità consegue la proroga fino a tale data dei mandati dei componenti attuali del Consiglio.
Per contrastare il problema abitativo degli universitari il decreto prevede che gli immobili sequestrati alla criminalità organizzata vengano destinati a residenze e alloggi universitari. A tale fine la legge riconosce poteri e ruoli specifici alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.
Il provvedimento autorizza inoltre la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 e il 2025 per completare l’ammodernamento del Campus del Politecnico Campus Nord di Bovisa, Milano.
Istruzione: promozione ITS Academy e personale
Vengono stanziate risorse per potenziare strutture e laboratori e per ampliare l’offerta formativa attraverso la promozione di percorsi negli ITS Academy.
L’articolo 9 precisa invece che i vincitori dei concorsi disposti per ricoprire i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano preso parte solo con il possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, nel primo anno di servizio, ossia 2024/2025 debbano conseguire l’abilitazione, conseguendo il CFU.
Disposto, invece, nell’articolo 10, l’aumento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, di 13.700.000 euro, anche per supportare le azioni relative al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
Infine, l’articolo 11 prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa per fornire alle famiglie meno abbienti i libri di testo.
Leggi anche: Lavoro nero: come funzionano le sanzioni