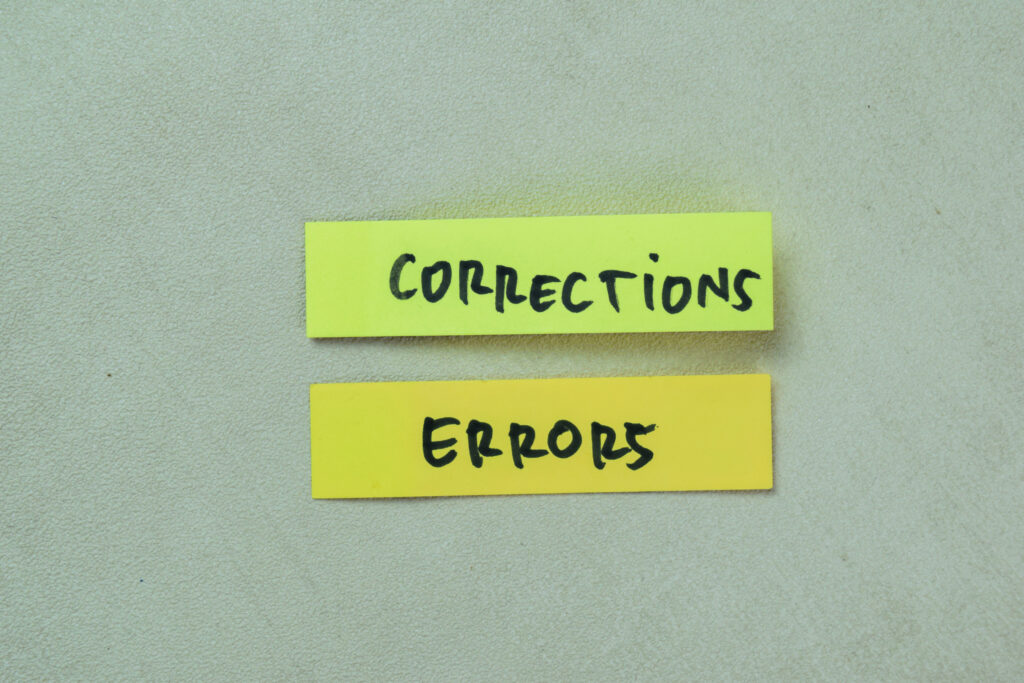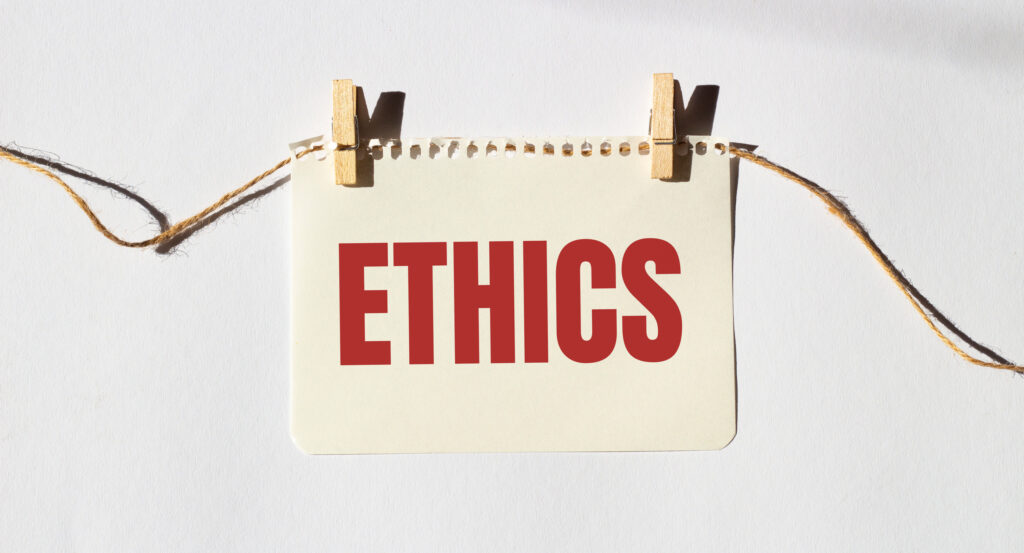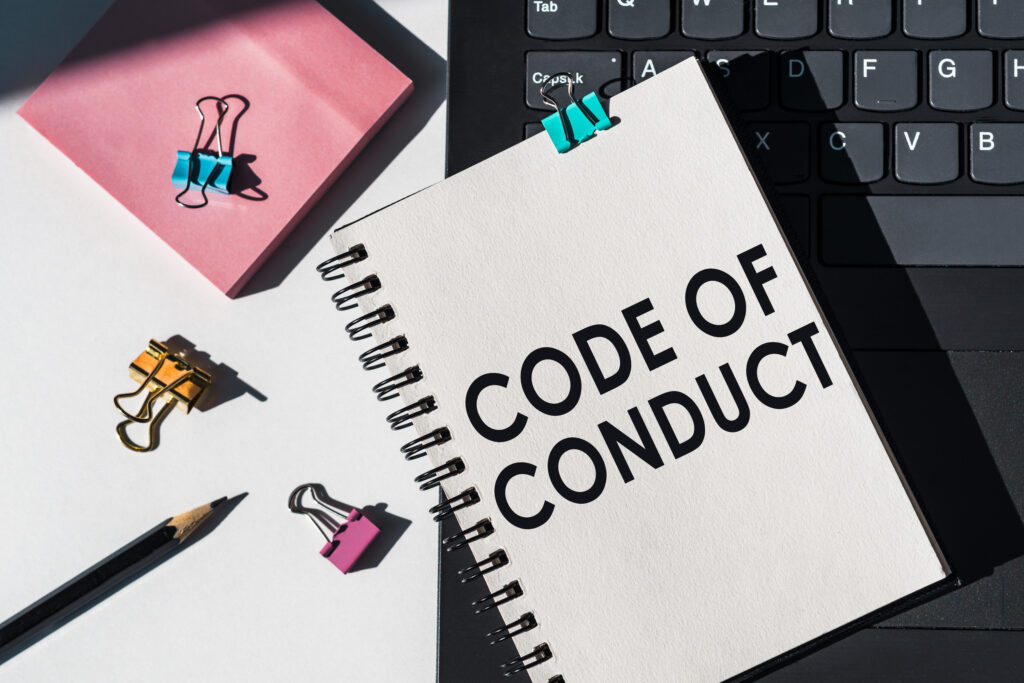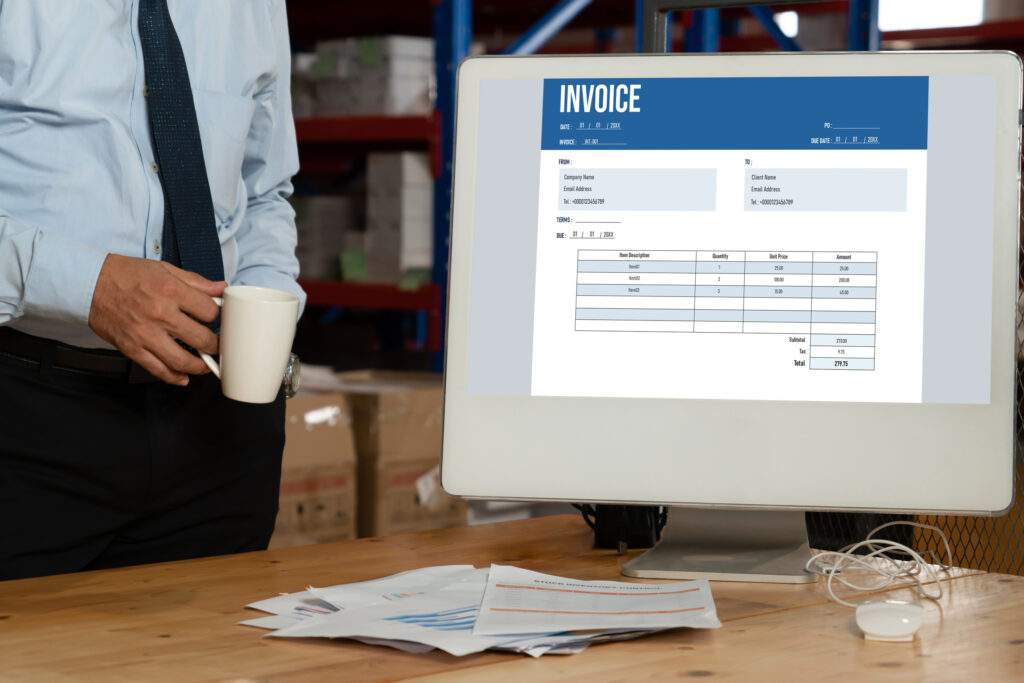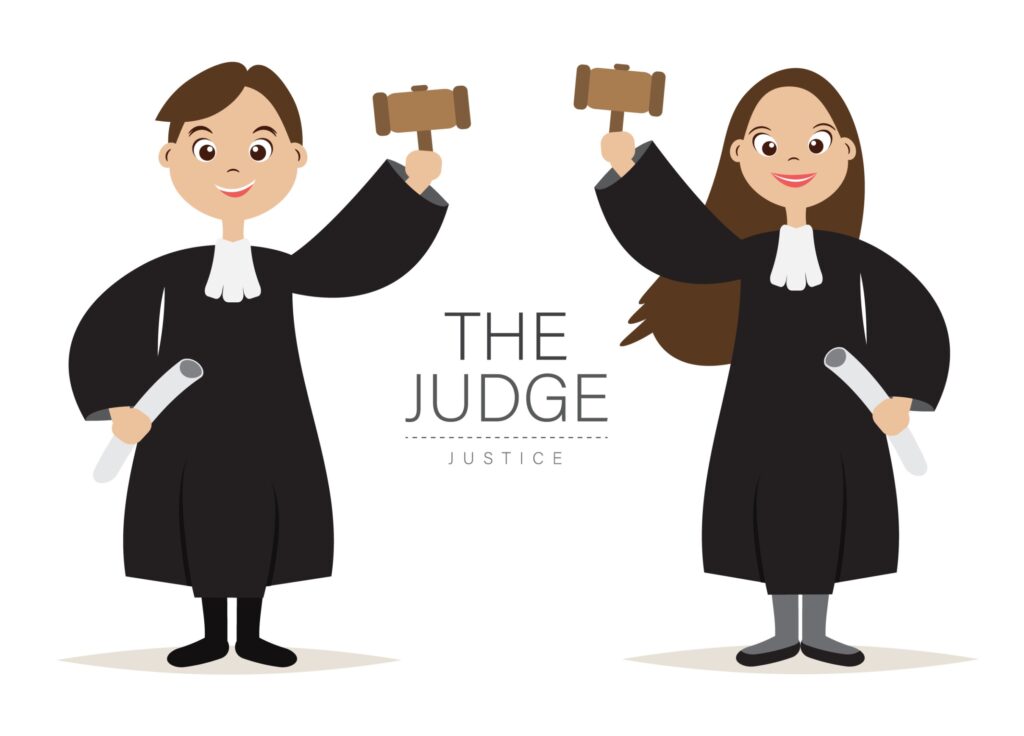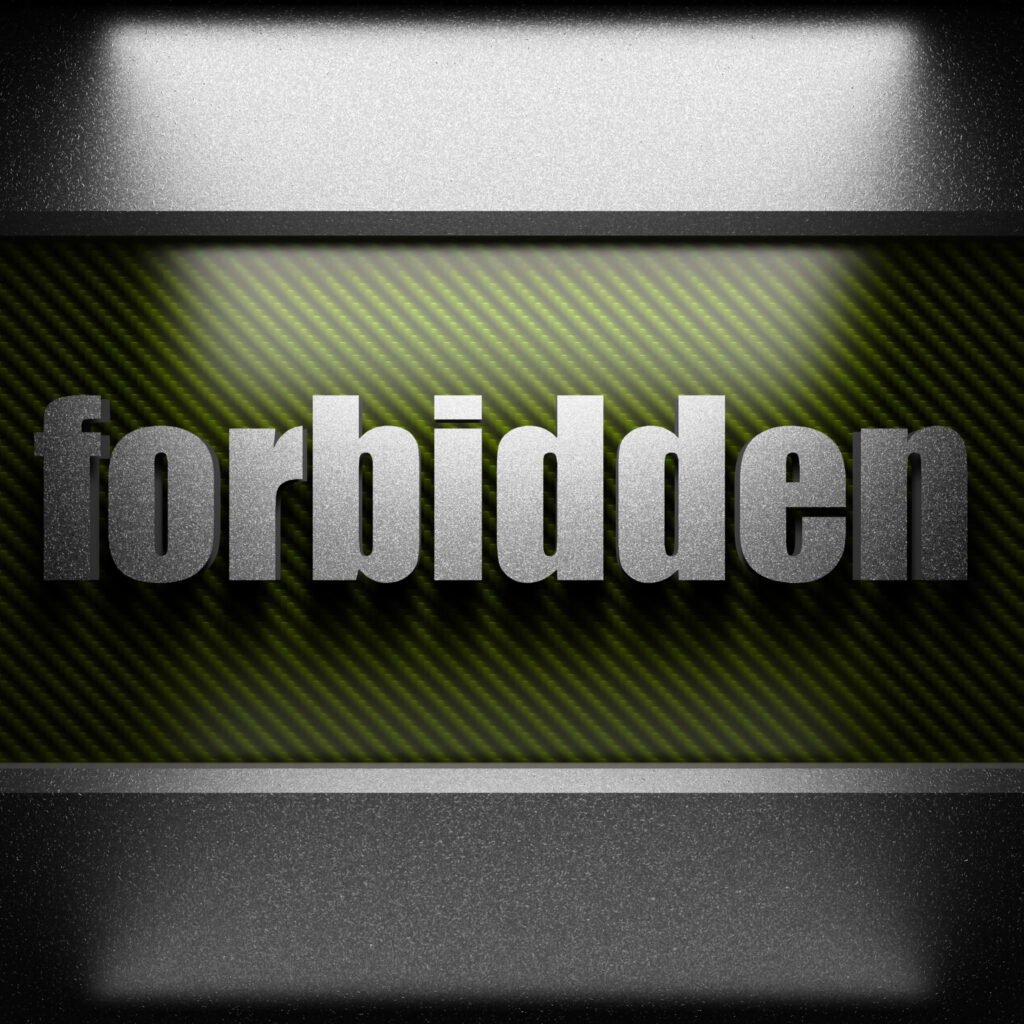Condotta irreprensibile avvocato già “specchiatissima e illibata” Condotta irreprensibile avvocato: cos’è, normativa, chi la valuta e cosa dice il CNF in caso di cancellazione e richiesta di reiscrizione
Condotta irreprensibile: requisito per l’iscrizione all’albo
La condotta irreprensibile dell’avvocato, definita prima del 2012 con i termini “specchiatissima e illibata” è uno dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’albo.
L’articolo 17 della legge n. 247/2012, contenente la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” al comma 1 lettera h) richiede infatti la “condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico” tra i requisiti di cui l’avvocato deve essere in possesso per potersi iscrivere all’albo.
Che cosa si intende per condotta irreprensibile?
La definizione e i confini della condotta irreprensibile li fornisce il CNF nella sentenza n. 214/2017. In questa decisione il Consiglio nazione Forense precisa che quando si valuta l’affidabilità di un avvocato, le condotte moralmente apprezzabili che rilevano non sono quelle della sua vita privata, ma piuttosto quelle che sono pertinenti alla sua capacità di svolgere correttamente i compiti assegnati.
E’ fondamentale inoltre non prendere in considerazione o valutare condotte che, per la loro natura, occasionalità, distanza nel tempo, o qualsiasi altro motivo, non siano ragionevolmente in grado di influenzare l’affidabilità attuale dell’avvocato rispetto alla sua specifica funzione o attività. In altre parole, si devono considerare solo i comportamenti che hanno un impatto concreto e attuale sulla sua professionalità e integrità in quel contesto specifico.
Valutazione della condotta irreprensibile dell’avvocato
La sentenza n. 214/2017 del CNF, richiamando quanto sancito da due sue precedenti sentenze, ricorda che spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (C.O.A) valutare in modo autonomo e indipendente la “condotta irreprensibile”. Questa valutazione però non deve essere automaticamente condizionata dall’esito di un eventuale procedimento penale che abbia coinvolto l’interessato. Di conseguenza, una condanna penale non comporta un automatico impedimento all’iscrizione. Il C.O.A deve considerare tutti gli elementi per determinare se la condotta dell’individuo sia compatibile con la dignità e il decoro della professione forense, indipendentemente da sentenze penali.
Giurisprudenza recente sulla condotta irreprensibile
Sempre il CNF in tre recenti sentenze si è espresso sulla “condotta irreprensibile” dell’avvocato fornendo così importanti indicazioni.
La reiscrizione all’albo di un altro COA è una nuova iscrizione
Nella sentenza n. 473/2024, il CNF si trova a decidere sul ricorso presentato da un avvocato, che dopo essere stato cancellato dall’albo di del COA Pordenone in seguito alla sua detenzione, si è visto rigettare l’iscrizione presso il COA di Belluno a causa dell’assenza della condotta irreprensibile e dell’assenza del legame territoriale, ossia il domicilio, all’interno del circondario.
Nel rigettare il ricorso il CNF ricorda, prima di tutto, che per la reiscrizione all’albo degli avvocati, l’interessato deve aver rimosso le cause della precedente cancellazione, ma anche dimostrare di possedere ancora i requisiti originali di iscrizione. Il COA quindi deve riesaminare tutti i requisiti previsti dall’articolo 17, commi da 1 a 7, della Legge 247/2012, inclusa la condotta irreprensibile. Per principio consolidato il COA può cancellare d’ufficio un iscritto condannato per reati che compromettano tale condotta, indipendentemente da un procedimento disciplinare.
La reiscrizione è considerata infatti una nuova iscrizione, richiedendo la verifica di tutti i requisiti legali richiesti per essere inseriti nell’albo.
Il CNF ha sancito lo stesso principio nella sentenza n. 477/2024. Il Consiglio ha infatti rigettato il ricorso di un avvocato, originariamente iscritto all’albo di Pordenone, che dopo la detenzione e l’affidamento in prova, si è visto rigettare l’iscrizione al COA di Rovigo.
Reiscrizione allo stesso albo: tutti i requisiti di cui al co.1, art. 17, Legge n. 247/2012
Nella sentenza n. 475/2024 il CNF si è espresso su un ricorso presentato da un avvocato che, dopo essere stato cancellato dall’albo dopo un periodo di detenzione, si è visto rigettare la reiscrizione allo stesso albo del COA di Pordenone per assenza di condotta irreprensibile, incertezza del domicilio professionale e permanenza dello stato di esecuzione della pena nella forma dell’affidamento in prova.
Il CNF anche nel caso della richiesta di reiscrizione allo stesso albo enuncia lo stesso principio esposto nei due casi precedenti. Per la reiscrizione all’albo dopo la cancellazione verificatasi a causa della pena detentiva irrogata all’avvocato, non è sufficiente la condotta irreprensibile. Il COA infatti deve valutare il possesso di tutti i requisiti che l’articolo 17 della legge 24772012 richiede, per procedere all’iscrizione.
Leggi anche: Avvocati: come valutare la condotta irreprensibile