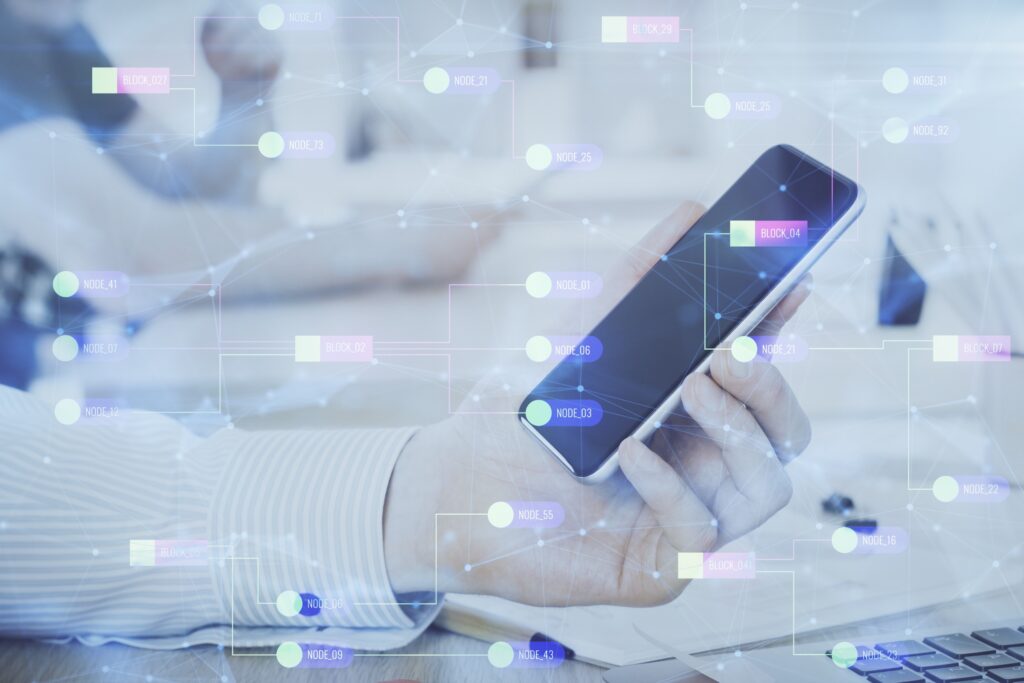Quesito con risposta a cura di Stella Maria Liguori e Claudia Nitti
Non è configurabile il delitto di concussione nel caso in cui la condotta del pubblico agente si risolva in un mero condizionamento, o in un’attività di generica persuasione, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Cass., sez. VI, 4 ottobre 2024, n. 36951).
Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare l’applicazione del regime dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., in luogo della fattispecie di concussione ex art. 317 c.p.
La Corte d’Appello territoriale, invero, aveva confermato la condanna del ricorrente per i delitti di concussione tentata e consumata, dichiarando inammissibile l’appello proposto dalla parte civile. L’imputato, all’epoca dei fatti appuntato scelto dai Carabinieri, era stato ritenuto responsabile di detti reati in relazione alle condotte tenute al fine di ottenere il risarcimento dei danni della propria autovettura, commessi da minori non identificati. Tali condotte sono consistite nel convocare i genitori dei minori sospettati di essere tra i possibili autori del danneggiamento, presentandosi, in una occasione, in divisa, nel chiedere loro con insistenza di individuare i colpevoli o di contribuire tutti alla riparazione dell’auto, sulla base di preventivi presentati dallo stesso ricorrente, richiesta cui aderivano solo alcuni dei genitori, raccogliendo una somma di danaro che, tuttavia, veniva rifiutata dall’imputato, poiché inferiore all’importo richiesto dallo stesso nei preventivi predetti.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, in primo luogo, la mancanza della condizione di coazione psicologica delle vittime. Egli, infatti, aveva agito in qualità di privato cittadino e senza provocare nei genitori – come riferito da un teste – alcuna forma di timore riverenziale.
La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, cui assorbiva gli altri.
La Corte, preliminarmente, evidenziava che il delitto di concussione richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, commessa con abuso dei suoi poteri o delle sue qualità, che incida in modo significativo sulla libertà di autodeterminazione del destinatario, costringendolo alla dazione o alla promessa indebita.
È fondamentale, dunque, ai fini della configurabilità del reato, che l’agente pubblico si sia avvalso della posizione di preminenza sul privato, per cercare di prevaricarne le scelte e le decisioni (Cass., sez. VI, 4 giugno 2021, n. 24560), atteso che l’avverbio “indebitamente”, utilizzato nell’art. 317 c.p., qualifica non già l’oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione (Cass., sez. VI, 1° febbraio 2011, n. 27444).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius”, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; inoltre, si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, perimetrato il confine tra le due modalità di realizzazione della condotta del pubblico agente chiarendo, in primo luogo, che l’abuso della qualità – c.d. abuso soggettivo – consiste nell’uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva – senza alcuna correlazione con atti dell’ufficio o del servizio – così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute. In secondo luogo, le Sezioni Unite evidenziavano che tale abuso della qualità, per assumere rilievo come condotta costrittiva o induttiva (rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 319quater c.p.), deve sempre concretizzarsi in un “facere” (non è configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato che deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all’indebita richiesta. In terzo luogo, l’abuso dei poteri – c.d. abuso oggettivo – consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Infine, tale abuso può essere realizzato in forma sia commissiva che omissiva, potendo il pubblico funzionario deliberatamente astenersi dall’esercizio dei propri poteri, ricorrendo a sistemi defatigatori di ritardo o di ostruzionismo volti a conseguire la dazione o la promessa di denaro o di altre utilità in cambio del sollecito compimento dell’atto richiesto.
Affinché possa configurarsi il delitto di concussione, occorre, dunque, che, attraverso tale abuso, dei poteri o delle qualità, il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, eserciti forme di pressione di tale intensità da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato.
Nel caso di specie, pertanto, ad avviso dei giudici di legittimità, la Corte territoriale, formulando una valutazione che esulava da tali coordinate ermeneutiche, si era limitata a porre l’accento su alcuni particolari di per sé non determinanti, quali la qualifica pubblicistica del ricorrente -indipendentemente da una sua effettiva strumentalizzazione, ma solo in quanto nota a tutti i genitori – e il fatto che lo stesso si sia presentato ad una riunione in divisa.
Invero, secondo quanto emerge dalle due sentenze di merito, l’imputato si era sostanzialmente limitato ad una generica pressione, prospettando le possibili ragioni di convenienza legate a eventuali indagini sui danneggiamenti o di carattere socio-familiare da parte dei servizi sociali, qualora non fossero stati individuati gli autori dei danneggiamenti ovvero non si fosse provveduto, in ogni caso, alla riparazione dell’auto privata del ricorrente.
Tale richiesta, sebbene posta in essere nei confronti di soggetti che ne conoscevano l’appartenenza all’Arma dei Carabinieri, non appare in alcun modo attuata con modalità tali da configurare quella indebita strumentalizzazione della qualifica o del potere idonea a coartare la volontà dei destinatari. Egli, infatti, si era limitato a chiedere loro di individuare i colpevoli o, comunque, di attivarsi al fine di risarcirlo del danno, pretesa quest’ultima che, sebbene censurabile sotto un profilo civilistico, non risulta accompagnata da alcuna prospettazione di un male ingiusto che ne giustifichi una rilevanza agli effetti penali (tale non potendosi intendere il generico riferimento alle indagini che sarebbero state svolte in caso di denuncia riguardante minorenni).
Siffatta condotta esorbita dal perimetro della “costrizione”, come sopra definita, trattandosi di una mera pressione che, oltre a non apparire correlata ad un abuso né dei poteri né della qualità del ricorrente, per le modalità con le quali è stata esercita non appare idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione dei destinatari della richiesta.
Deve, dunque, ribadirsi che non è configurabile il delitto di concussione nel caso in cui la condotta del pubblico agente si risolva in un mero condizionamento, o in un’attività di generica persuasione, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo.
(*Contributo in tema di “Sinistro stradale e risarcimento del terzo trasportato”, a cura di Stella Maria Liguori e Claudia Nitti, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)