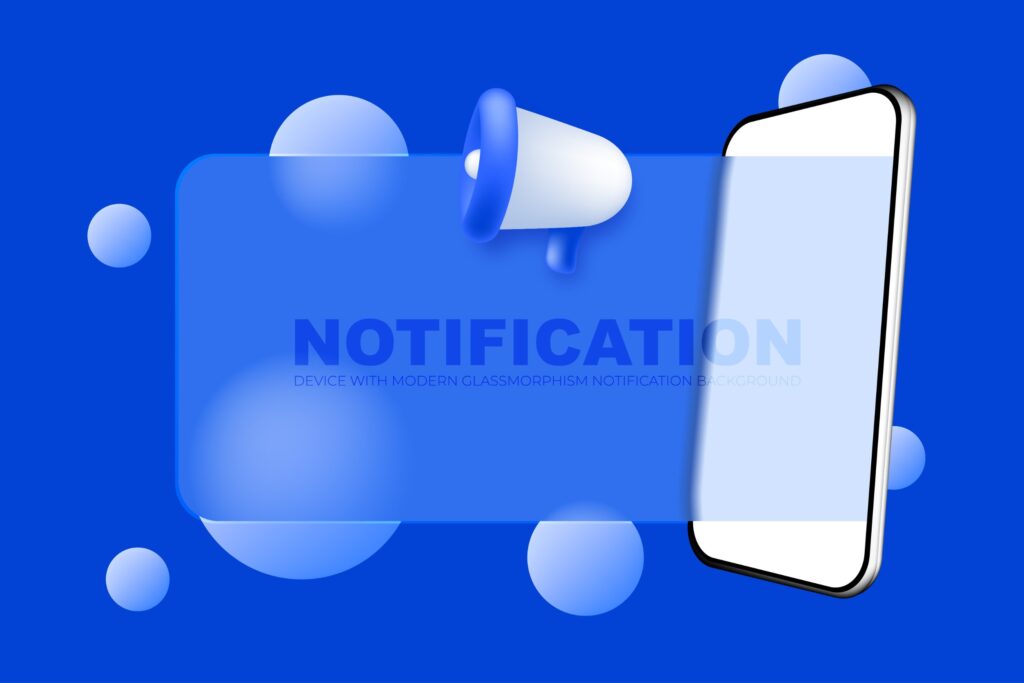Riforma processo civile: ecco i nuovi correttivi In vigore dal 26 novembre 2024 il decreto legislativo sui correttivi alla riforma Cartabia del processo civile
In vigore i nuovi correttivi alla riforma Cartabia
I correttivi alla Riforma del processo civile approvati dal Consiglio dei Ministri (atto n. 137 bis) il 26 settembre, in secondo esame preliminare, vanno a modificare il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, meglio noto come riforma Cartabia.
Il testo, dopo aver ricevuto il parere favorevole da parte delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il 29 ottobre 2024 è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri.
Il decreto (Dlgs-164/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024, per entrare in vigore il 26 novembre 2024.
Dal provvedimento emerge un’attenzione particolare al processo di cognizione per garantire un miglior coordinamento, alla procedura di notifica delle impugnazioni, ai procedimenti che riguardano le persone e la famiglia e al processo esecutivo.
Processo civile: gli interventi
Scendendo nello specifico, vediamo quali sono i correttivi apportati al testo.
Regolamento di competenza
In relazione al regolamento di competenza il decreto prevede:
- che l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’ 38 c.p.c siano rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza;
- l’ampliamento da 20 a 40 giorni del termine per il deposito delle difese del resistente nel regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c.
Digitalizzazione del processo
Sul tema della digitalizzazione del processo l’art. 123 c.p.c. sul giuramento dell’interprete e del traduttore il testo prevede che lo stesso venga prestato ai sensi dell’art. 193 c.p.c ossia nelle stesse modalità previste per il consulente con dichiarazione sottoscritta con firma digitale.
Comunicazioni e notificazioni
Il nuovo articolo 136 c.p.c prevede che qualora la comunicazione non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procederà con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali. Se invece la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’atto viene inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia. Le modalità per l’inserimento dell’atto nel portale saranno descritte nel nuovo articolo 149-bis.
Cambia infatti anche la formulazione dell’articolo 149 bis c.p.c. dedicato alle notificazioni a mezzo PEC dell’ufficiale giudiziario. Il nuovo comma 2 dispone che l’ufficiale giudiziario potrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso.
Il nuovo terzo comma dell’art. 149 bis c.p.c invece dispone che la notifica per il notificante si perfeziona quando il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario, per il destinatario invece quando il gestore di posta elettronica genera la ricevuta di avvenuta consegna.
Procedimento di cognizione ordinaria
Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi (non 5 giorni) prima della nuova udienza fissata.
Sostituito completamente l’art 171 bis c.p.c che si occupa delle verifiche preliminari. Da segnalare i nuovi commi 4 e 5.
Il comma 4 prevede in particolare che il giudice, in presenza del presupposti di legge, possa disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi con deposito di memorie e documenti.
Cambia anche l’art. 330 c.p.c. sulla notifica dell’impugnazione
Di estremo interesse il nuovo comma 2, che così dispone: “L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.”
Rito speciale persone, famiglia e minori
Il decreto interviene sull’articolo 473 bis in misura piuttosto corposa.
Il nuovo comma 1 stabilisce l’ambito di applicazione delle norme contenute nel titolo IV bis:
- procedimenti sullo stato delle persone, dei minorenni e della famiglia attribuiti al tribunale ordinario, al giudice tutelare e al tribunale per i minorenni,
- domande di risarcimento del danno derivanti dalla violazione di doveri familiari a meno che la legge non disponga diversamente.
Da segnalare anche le modifiche che lo schema apporta agli articoli 473 bis.24, 473 bis.38, 473 bis.39, 473bis.48.
Fattura elettronica per il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo potrà essere emesso anche sulla base delle fatture elettroniche. All’art. 634 c.p.c. dopo il primo periodo i nuovi correttivi aggiungono il seguente: “Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.”
Processo di esecuzione
Il nuovo comma 2 dell’art. 492 c.p.c., che si occupa della forma del pignoramento, prevede che il pignoramento debba contenere anche l’invito al debitore ad effettuare presso la cancelliera del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui si trova il giudice competente o indicare il proprio indirizzo PEC con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza al domicilio le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis c.p.c.
Importante anche la modifica che investe l’articolo 543 c.p.c., relativa alla forma del pignoramento nell’espropriazione presso terzi. Il nuovo sesto comma prevede che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine prevista per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, lo debba comunicare immediatamente al debitore o al terzo. In questo caso, l’obbligo del terzo viene meno dal momento in cui riceve la comunicazione.