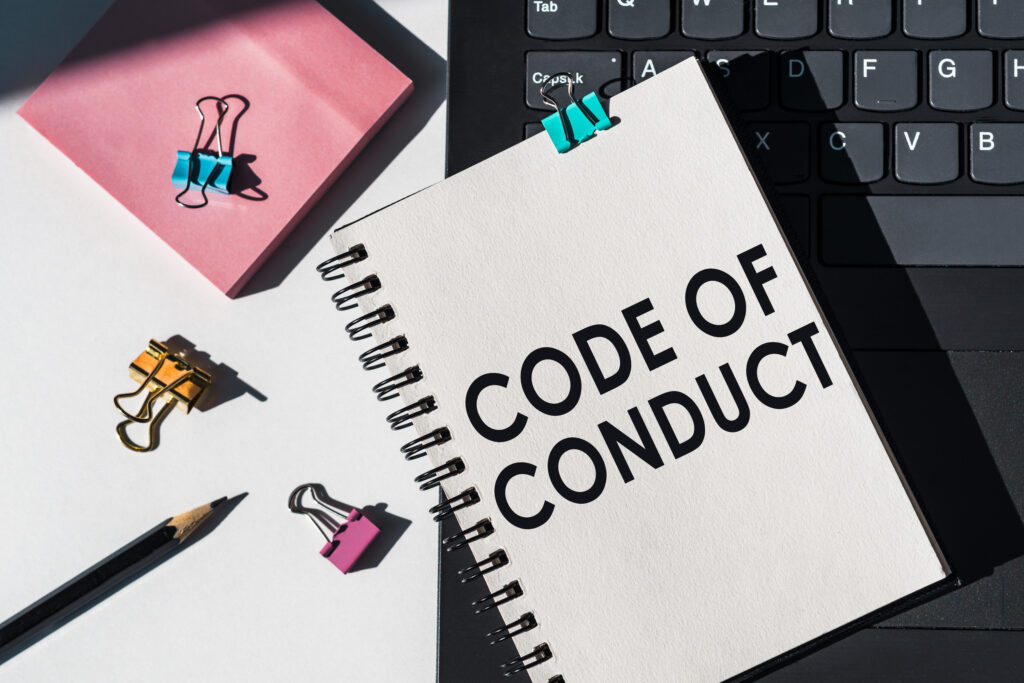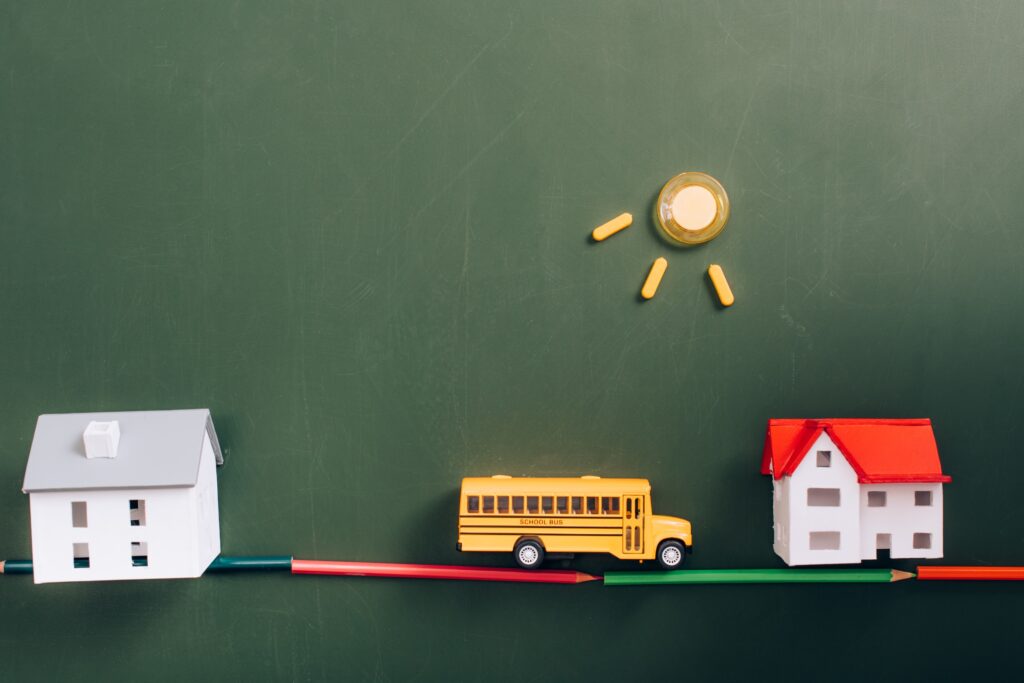Certificato di abitabilità: cos’è
Il certificato di abitabilità fino agli anni ’90, veniva rilasciato se l’immobile era salubre dal punto di vista igienico sanitario. L’articolo 221 del Regio Decreto n. 1265/1934 subordinava a questo documento infatti l’uso residenziale degli edifici.
Alle Unità Sanitarie Locali spettava il compito di verificare le condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni.
Certificato di abitabilità: evoluzione normativa
Con il d.P.R. n. 425/1994, la disciplina dell’abitabilità e quella dell’agibilità si uniscono.
Il certificato di abitabilità attestante la salubrità dell’immobile non basta più per la legalità d’uso. Il decreto richiede anche il certificato di collaudo e la dichiarazione di conformità del direttore dei lavori.
Il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) muta poi il nome certificato di abitabilità in
certificato di agibilità, rendendolo un titolo unico per tutte le destinazioni d’uso, che viene rilasciato in presenza della sicurezza statica, salubrità, risparmio energetico, accessibilità e conformità urbanistica dell’immobile.
Da certificato di abitabilità, a quello di agibilità fino alla SCA
Nel 2013 si verifica un’importante fusione normativa. Nasce la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), un documento cruciale per l’uso legittimo di ogni immobile. Questo documento unisce infatti i concetti di “abitabilità” e “agibilità”, cancellando la distinzione tra usi residenziali e non residenziali.
L’obiettivo primario della SCA consiste nell’attestare la conformità di un edificio o unità immobiliare a standard elevati. Tali standard includono condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e adeguata installazione degli impianti.
La SCA inoltre verifica la conformità dell’opera al progetto originale e, dove richiesto, il rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale. In sintesi, garantisce che ogni immobile rispetti rigorosi requisiti normativi.
Le recenti modifiche del decreto “Salva Casa” (d.l. 69/2024) hanno semplificato ulteriormente il processo. Hanno escluso la nuova agibilità per lavori interni non alteranti, hanno ammesso l’agibilità parziale per singole unità autonome e hanno eliminato la sanzione pecuniaria per la mancata agibilità, sebbene rimangano conseguenze civili e urbanistiche.
SCA: quando è obbligatoria
Il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380-2001) stabilisce le linee guida generali per la presentazione della SCA. Le normative regionali e comunali possono poi implementare queste direttive. La SCA è necessaria per le nuove costruzioni e per le ricostruzioni totali o parziali. Si richiede anche per sopraelevazioni e interventi su edifici esistenti.
Queste opere però devono potenzialmente influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico. Perfino le sanatorie, che regolarizzano interventi abusivi rientranti in queste categorie, richiedono la presentazione della SCA. Le amministrazioni locali definiscono poi specifici interventi soggetti a questa dichiarazione.
Chi la presenta
Possono presentare la SCA il titolare del permesso di costruire, il soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), i loro successori e gli aventi causa.
Nella pratica, un professionista abilitato, come un ingegnere, geometra, architetto o perito edile, solitamente deposita la SCA.
Come si presenta
Il deposito avviene presso lo Sportello Edilizia e Urbanistica entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori. Alcuni comuni permettono di indicare la fine lavori direttamente nella SCA. Il Comune può anche disporre che vengano eseguite delle ispezioni, tramite la ASL, entro 180 giorni dal deposito per verificare i requisiti.
Validità della SCA
La SCA non ha una durata, quindi non scade e non necessita di essere rinnovata. Tuttavia, è necessaria una nuova segnalazione se intervengono modifiche. Queste modifiche per devono influenzare la sicurezza, l’igiene, la salubrità o il risparmio energetico dell’immobile.
Mancata presentazione: sanzioni
Il Decreto SCIA 2 (D.Lgs. n. 222/2016) ha abolito il rilascio del certificato da parte del Comune.
Ora, la SCA è un’autocertificazione presentata dal proprietario o dal costruttore.
La mancata presentazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Leggi anche: Agevolazione prima casa anche per l’immobile inagibile