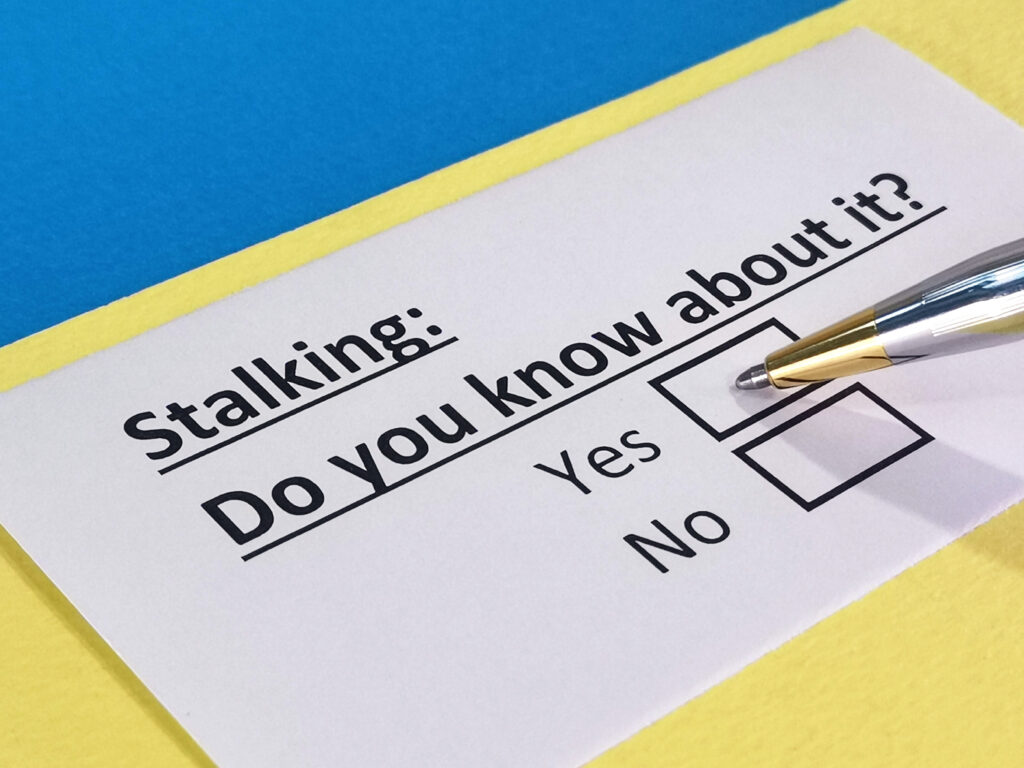Licenziamento dei dirigenti durante il Covid: è legittimo La Corte costituzionale ha dichiarato legittimo il licenziamento dei dirigenti durante l’emergenza Covid, ritenendo conforme alla Costituzione il diverso trattamento rispetto agli altri lavoratori
Licenziamento dei dirigenti durante il Covid
Licenziamento dei dirigenti: con la sentenza n. 141/2025, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d’appello di Catania in merito al divieto di licenziamenti economici introdotto durante la pandemia da Covid-19.
La norma non includeva i dirigenti, per i quali restava possibile il licenziamento individuale, mentre veniva applicato il blocco solo in caso di licenziamenti collettivi.
Blocco dei licenziamenti individuali
La Consulta ha chiarito che il diverso trattamento non è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il dirigente, infatti, ricopre una posizione peculiare di autonomia e rappresentanza, assimilabile a quella dell’imprenditore. Questo status giustifica l’applicazione del principio di libera recedibilità, senza le garanzie previste per gli altri lavoratori subordinati.
Il ruolo della contrattazione collettiva
Pur ribadendo la definizione legale di “dirigente” (art. 2095 cod. civ.), la Corte ha sottolineato che la contrattazione collettiva e il datore di lavoro possono attribuire tale qualifica anche come riconoscimento di miglior favore, senza che ciò incida sulla disciplina generale dei licenziamenti.
La disciplina eccezionale durante la pandemia
Il legislatore, durante l’emergenza sanitaria, ha riproposto per i dirigenti lo stesso assetto previsto in via ordinaria:
-
i licenziamenti collettivi erano bloccati,
-
i licenziamenti individuali per motivi economici restavano consentiti.
Questa scelta, secondo la Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore e rispetta i principi di eccezionalità, temporaneità e proporzionalità, già richiamati in precedenti pronunce.
Una misura proporzionata e temporanea
Il blocco dei licenziamenti durante il Covid è stato considerato uno strumento eccezionale, legato alla durata della pandemia e adottato come extrema ratio per tutelare interessi sociali ed economici generali.
Nel caso dei dirigenti, il legislatore ha ritenuto coerente limitare la tutela al solo ambito dei licenziamenti collettivi, senza violare la Costituzione.