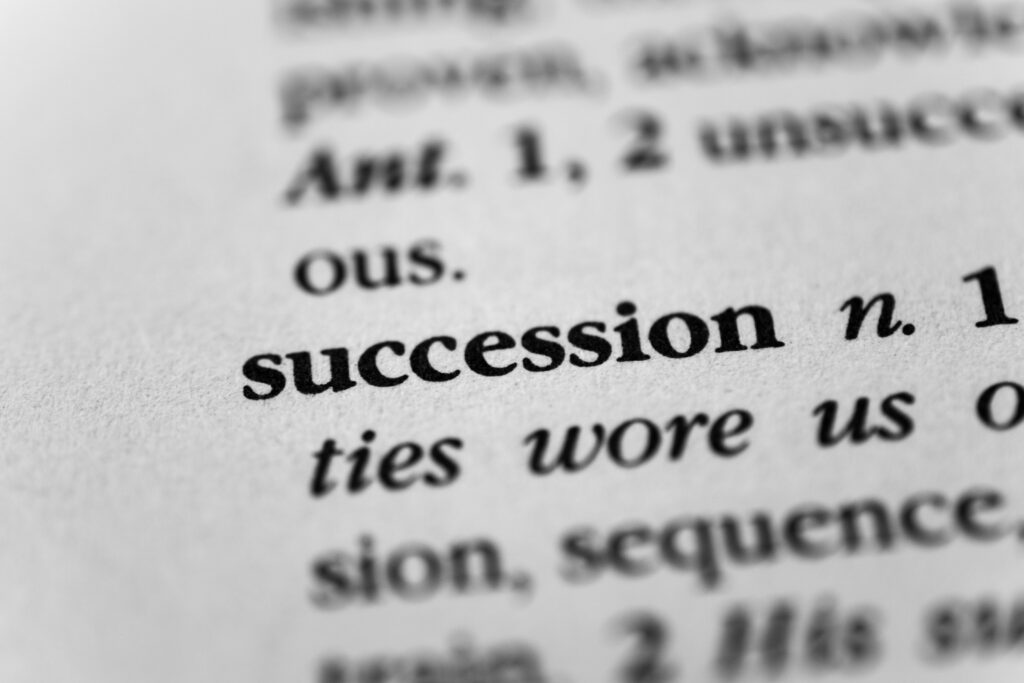Innovazioni in condominio Cosa sono le innovazioni condominiali, quali sono le maggioranze necessarie per deliberarle e quali diritti ha il condomino dissenziente
Cosa sono le innovazioni in condominio
Le innovazioni in condominio sono quegli interventi che migliorano o rendono più comode da utilizzare le cose comuni.
Trattandosi di interventi che vanno oltre la semplice manutenzione del bene, mutandone, invece, in qualche modo la natura o la destinazione sostanziale, le innovazioni sono soggette ad una particolare disciplina codicistica e possono essere deliberate solo con maggioranze qualificate, individuate dall’art. 1120 del codice civile.
Quale maggioranza per le innovazioni?
Nel dettaglio, per l’approvazione di un intervento innovativo sulle parti comuni è necessario il voto della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio.
La legge n. 220 del 2012, però, ha introdotto alcune ipotesi, corrispondenti ad innovazioni oggettivamente meritevoli di apprezzamento, per le quali è sufficiente, per l’approvazione assembleare, la consueta maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. secondo comma (cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà del valore dell’edificio).
Le ipotesi
Tali ipotesi sono le seguenti:
- interventi che migliorino la sicurezza e la salubrità dell’edificio o dei suoi impianti;
- interventi tesi all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- innovazioni mirate al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio;
- realizzazione di posti auto al servizio delle unità immobiliari;
- realizzazione di impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili;
- realizzazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, anche via satellite o cavo.
Richiesta di innovazioni in condominio
La richiesta di realizzazione di un intervento che costituisca innovazione condominiale può provenire anche da un singolo condomino.
A fronte di tale richiesta, l’amministratore è tenuto a convocare apposita assemblea entro trenta giorni.
Il proponente deve indicare il contenuto specifico della propria istanza, descrivendo anche le possibili modalità di esecuzione dell’intervento. Se l’amministratore non ritiene sufficientemente precisa la richiesta, deve chiedere le opportune integrazioni al condomino.
Quali sono le innovazioni vietate ex art. 1120 c.c.
Un aspetto importante della disciplina relativa alle innovazioni condominiali è quello individuato dall’ultimo comma dell’art. 1120 c.c., che vieta tutti quegli interventi suscettibili di mettere in pericolo la stabilità o la sicurezza del fabbricato o che ne ledano il decoro architettonico (peggiorandone, cioè, il suo aspetto estetico e il suo carattere di pregio).
Altrettanto vietate, in base alla norma appena citata, sono le innovazioni che renderebbero inservibili alcune parti comuni anche per un solo condomino.
Quali sono le innovazioni voluttuarie
La disciplina codicistica delle innovazioni condominiali è completata dalle disposizioni dell’art. 1121 c.c., secondo il quale ciascun condomino ha il diritto di essere esonerato dalla relativa spesa, quando l’innovazione comporti una spesa molto gravosa o sia da considerare innovazione voluttuaria rispetto alle condizioni dell’edificio.
Resta fermo il diritto dell’esonerato e dei suoi eredi, in qualunque tempo, di decidere di partecipare ai vantaggi offerti dall’opera, versando in un momento successivo gli importi corrispondenti alle spese di esecuzione e manutenzione.
L’esonero di cui sopra, però, è previsto solo se l’innovazione consista in opere o impianti che possono essere utilizzati separatamente dai vari condomini. Diversamente, in caso di opera non suscettibile di utilizzo separato, la sua realizzazione non è consentita, a meno che la maggioranza dei condomini che la desiderano non intendano sopportarne integralmente la spesa.
In chiusura, va segnalato che molti degli aspetti sopra descritti coinvolgono la discrezionalità dell’interprete (e cioè dei condomini, dell’amministratore e dello stesso giudice, qualora dalla realizzazione dell’innovazione derivi una controversia legale). Starà a questi ultimi, cioè, di volta in volta, cercare di capire, innanzitutto, se l’intervento rappresenti un’innovazione (secondo quanto si è detto in apertura di articolo) o una mera modifica; se esso sia suscettibile di utilizzo separato (si pensi a un impianto centralizzato), o meno (ad esempio, un c.d. cappotto termico).
Ancora, sarà il condomino a dover dimostrare in giudizio se l’innovazione comporti una spesa che possa considerarsi voluttuaria (prevedendo, ad esempio, l’installazione di finiture o l’utilizzo di materiali di particolare pregio); e, infine, se l’innovazione leda i suoi diritti di singolo condomino, rendendogli inservibile una parte comune (si pensi all’installazione di un manufatto che oscuri una finestra della sua unità immobiliare).