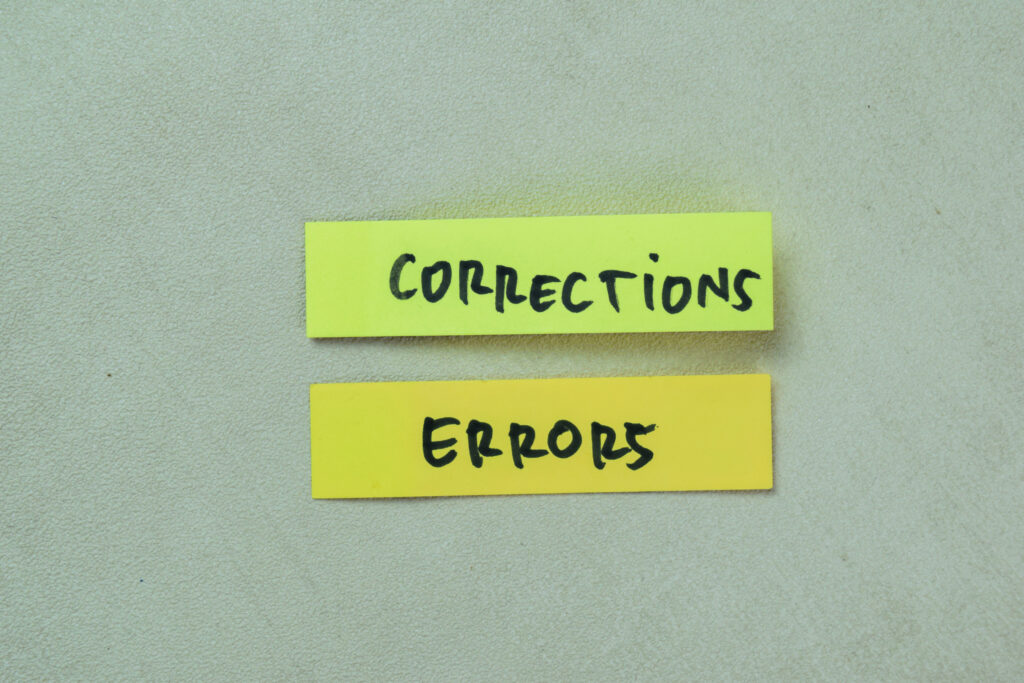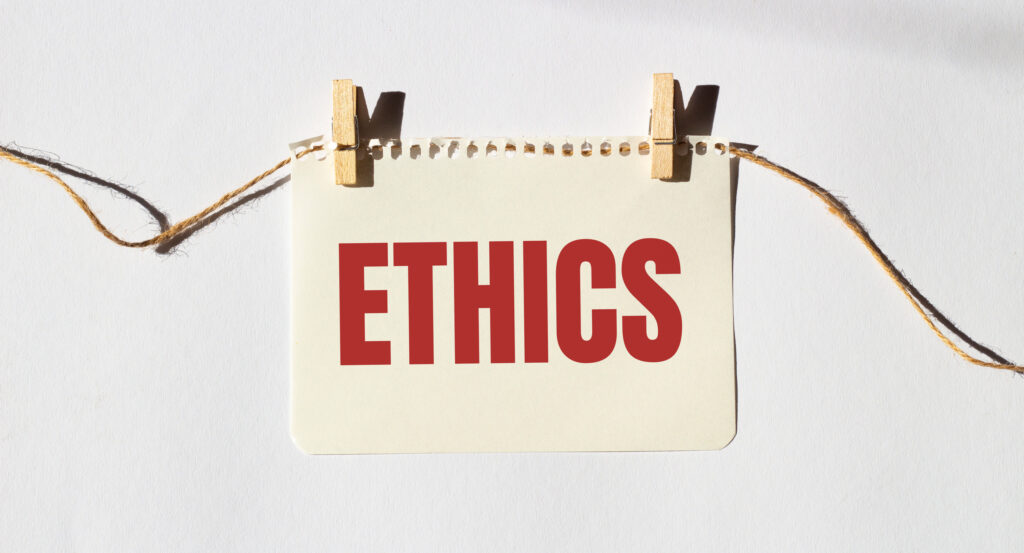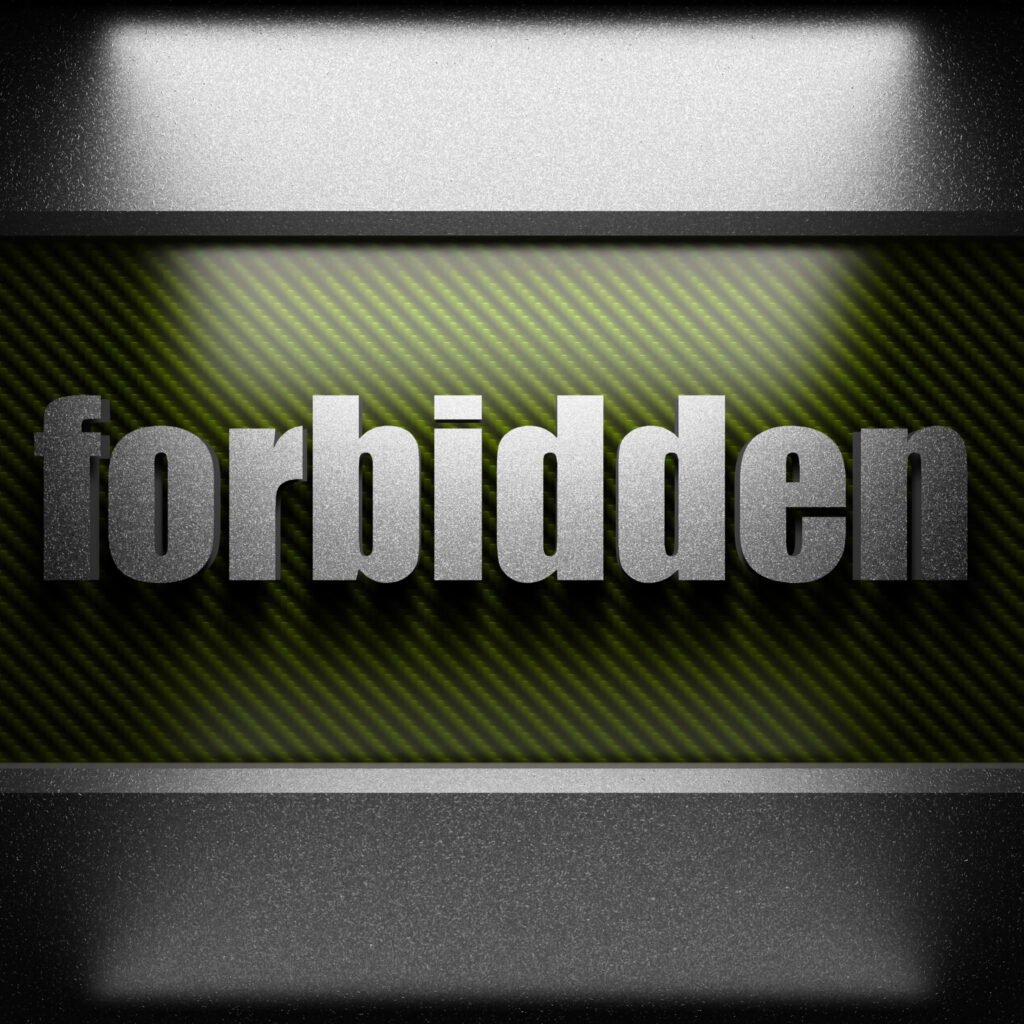Codice deontologico forense: prime modifiche in GU
Il 1° settembre 2025 sono entrate in vigore alcune importanti modifiche al Codice Deontologico Forense, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 202. Queste revisioni, approvate dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), riguardano in particolare il rafforzamento delle norme sul segreto professionale e la gestione delle informazioni.
Impatto delle modifiche al Codice deontologico forense
Le modifiche toccano gli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e la nuova titolazione del Titolo IV del Codice Deontologico. L’obiettivo principale è adattare le regole deontologiche all’evoluzione della professione forense.
- Le nuove norme mirano a rendere più rigorose le regole che tutelano la riservatezza delle informazioni scambiate tra avvocato e cliente. Questo aspetto infatti è cruciale per preservare il rapporto di fiducia.
- Vengono introdotte o potenziate inoltre le disposizioni che regolano il modo in cui gli avvocati devono trattare e proteggere i dati e le informazioni sensibili, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza.
- Più attenzione infine all’ascolto del minore e alle ADR, istituti potenziati dalla Riforma Cartabia.
Queste novità normative richiedono agli avvocati di adeguarsi a nuovi doveri e obblighi, con un impatto diretto sulla loro routine lavorativa. Le modifiche sottolineano l’importanza di una condotta etica e professionale, in linea con le sfide attuali del contesto legale e tecnologico.
Analisi delle modifiche al Codice deontologico forense
Per comprendere al meglio le modifiche confrontiamo la vecchia e la nuova formulazione degli articoli del Codice Deontologico Forense.
Corrispondenza tra colleghi riservatezza: art. 48, comma 3
La formulazione precedente vietava all’avvocato di consegnare al cliente la “corrispondenza riservata tra colleghi”. La nuova versione, invece, si riferisce alla “corrispondenza di cui al comma 1”, che disciplina l’intero spettro della comunicazione tra avvocati. Questa precisazione è fondamentale: non è più necessario che la corrispondenza sia esplicitamente qualificata come “riservata” per far scattare il divieto. L’obbligo di segretezza si estende a tutta la corrispondenza professionale, rafforzando la fiducia reciproca e il principio di lealtà tra avvocati, pilastri di una corretta dialettica processuale.
Obbligo di conoscenza: art. 50, comma 6
L’obbligo dell’avvocato di indicare i provvedimenti già ottenuti (inclusi quelli di rigetto) è stato affinato. La nuova formulazione aggiunge l’importante specificazione “di cui sia a conoscenza”. Questa modifica rende la norma più equa e aderente alla pratica. La precedente formulazione poteva imporre un onere di conoscenza assoluto, che a volte era irragionevole per il professionista che subentrava in un incarico. La nuova norma lega il dovere di comunicazione alla conoscenza effettiva, pur non diminuendo l’obbligo di diligenza.
Riservatezza nelle trattative: art. 51, comma 2
Questa è una delle modifiche più incisive. La passata formulazione imponeva il dovere di astenersi dal deporre sui colloqui e sulla corrispondenza riservata con i colleghi. La nuova versione estende esplicitamente tale divieto anche alle “proposte transattive e relative risposte”. Questo aggiunge un ulteriore strato di protezione alle trattative stragiudiziali, riconoscendone il valore e l’importanza. Le proposte di accordo, spesso fatte in un’ottica di compromesso, devono rimanere protette per incentivare la risoluzione alternativa delle controversie e non essere utilizzate come prova in un futuro contenzioso. L’avvocato assume così un ruolo più forte come negoziatore e mediatore.
Ascolto del minore: art. 56, commi 1 e 1-bis
La novità più rilevante è l’introduzione del comma 1-bis, che non esisteva in precedenza. Mentre il comma 1 mantiene l’obbligo di ottenere il consenso dei genitori per l’ascolto del minore, salvo conflitto di interessi e a condizione che l’avvocato non sia stato nominato curatore speciale, il nuovo comma 1-bis sancisce che l’ascolto deve avvenire secondo “modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso”. L’avvocato non deve quindi rispettare solo la formalità del consenso dei genitori, ma deve anche garantire che l’interazione con il minore sia svolta con la massima cura e attenzione, proteggendolo da eventuali traumi o pressioni. Si pone l’accento sulla tutela del soggetto debole, una priorità sempre più centrale nel diritto moderno.
Imparzialità nell’arbitrato e nella mediazione: art. 61 e art. 62
Le modifiche a questi articoli rafforzano in modo significativo i principi di indipendenza e imparzialità dell’avvocato che ricopre il ruolo di arbitro o mediatore. Le nuove formulazioni estendono il divieto previsto per l’avvocato arbitro o mediatore di accettare l’incarico non solo se “una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni” da soci, associati o colleghi che esercitano nello stesso studio, ma anche a coloro che “collaborino professionalmente in maniera non occasionale”. Questo va a coprire una zona grigia, includendo tutte quelle forme di collaborazione che non sono formalizzate in una società, ma che possono comunque creare un conflitto di interessi, minando l’imparzialità del professionista.
Negoziazione assistita: art. 62 bis
L’introduzione ex novo dell’art. 62-bis è una delle più grandi novità del codice e risponde all’esigenza di disciplinare una procedura, la negoziazione assistita, che è diventata sempre più comune. L’articolo stabilisce regole precise per l’avvocato.
- Si ribadiscono i doveri di lealtà verso le parti e di riservatezza delle informazioni.
- Si vieta di usare suggestioni per ottenere deposizioni compiacenti, garantendo l’autenticità delle dichiarazioni.
- Si preclude all’avvocato di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, fatta salva la sussistenza di eccezioni giustificate.
- Vengono introdotte sanzioni disciplinari ad hoc (censura e sospensione) per la violazione di queste norme, sottolineando la serietà dei doveri in materia.
Leggi anche: Deontologia forense: guida generale