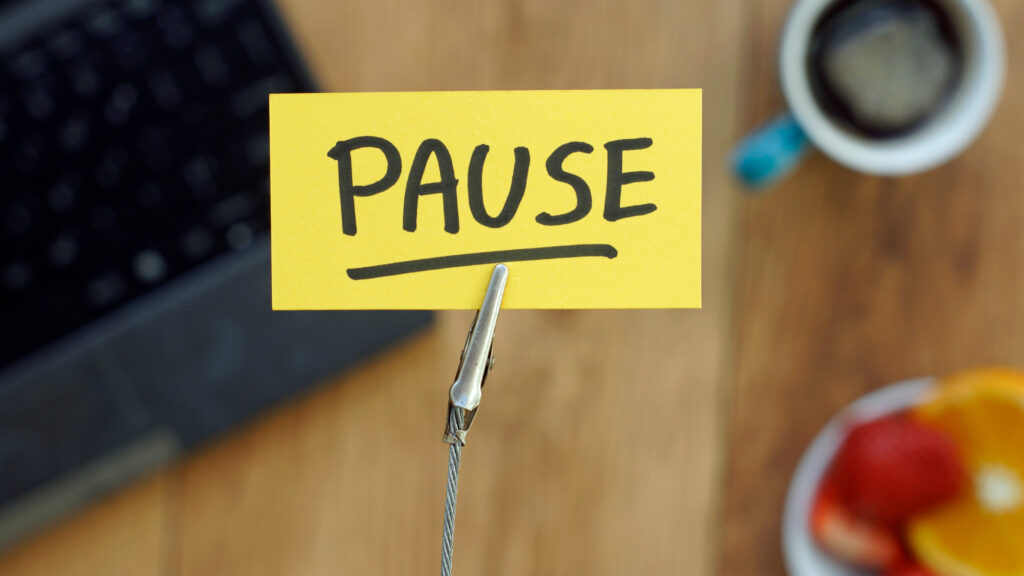Scontrino elettronico obbligatorio Scontrino elettronico obbligatorio: prevista l'introduzione graduale dello scontrino digitale per pagamenti elettronici
Dallo scontrino cartaceo allo scontrino elettronico obbligatorio
In arrivo lo scontrino elettronico obbligatorio. Nella Risoluzione 7-00286 la VI Commissione della Camera ha affrontato infatti il tema delle modalità di emissione dello scontrino fiscale in relazione alle transazioni elettroniche, proponendo la transizione verso la dematerializzazione. Le ragioni sono di natura ambientale e pratica.
Scontrino cartaceo: documento commerciale
Con l’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (Decreto Legislativo n. 127/2015), lo “scontrino fiscale” ha acquisito la natura di documento commerciale. La memorizzazione e l’invio telematico dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione e di certificazione fiscale tradizionali.
Vero che il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.12.2016 ha previsto l’emissione di documenti commerciali per mezzo di strumenti tecnologici sicuri, tuttavia l’emissione su supporto cartaceo resta la norma. Il formato elettronico è infatti possibile solo previo accordo con il destinatario. Questa pratica comporta l’emissione di innumerevoli scontrini cartacei, che però non sono riciclabili come la carta comune. Questo genera un significativo impatto ambientale nella fase di produzione e in quella di smaltimento.
Verso la digitalizzazione: lo scontrino elettronico obbligatorio
Un altro passo verso la digitalizzazione è stato compiuto grazie all’art. 1, co. 74, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024). Questa norma, dal 1° gennaio 2026 introduce infatti l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronici (POS) e il registratore di cassa telematico per la registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.
Scontrino elettronico obbligatorio: le tappe
Alla luce di queste innovazioni la risoluzione stabilisce che a partire dal 2027 gli strumenti per i corrispettivi dovranno inviare lo scontrino digitalmente (SMS, email, app) al cliente, a sua scelta.
Questa infrastruttura sarà interoperabile con l’Agenzia delle Entrate, migliorando tracciabilità e trasparenza fiscale e rafforzando la lotta all’evasione. È un passo chiave verso un sistema fiscale più efficiente e sostenibile, integrando l’attuale trasmissione telematica e riducendo l’impatto ambientale della carta.
Queste le tappe per l’introduzione graduale dell’obbligo dello scontrino digitale per i pagamenti elettronici:
- dal 1° gennaio 2027: imprese della grande distribuzione;
- dal 1° gennaio 2028: altri soggetti con un volume d’affari superiore a una certa soglia;
- dal 1° gennaio 2029: tutti i restanti esercenti.
Gli acquirenti potranno richiedere comunque la stampa del documento commerciale, che potrebbe servire per la garanzia o il reso del prodotto.
Leggi anche gli altri articoli dedicati al diritto fiscale