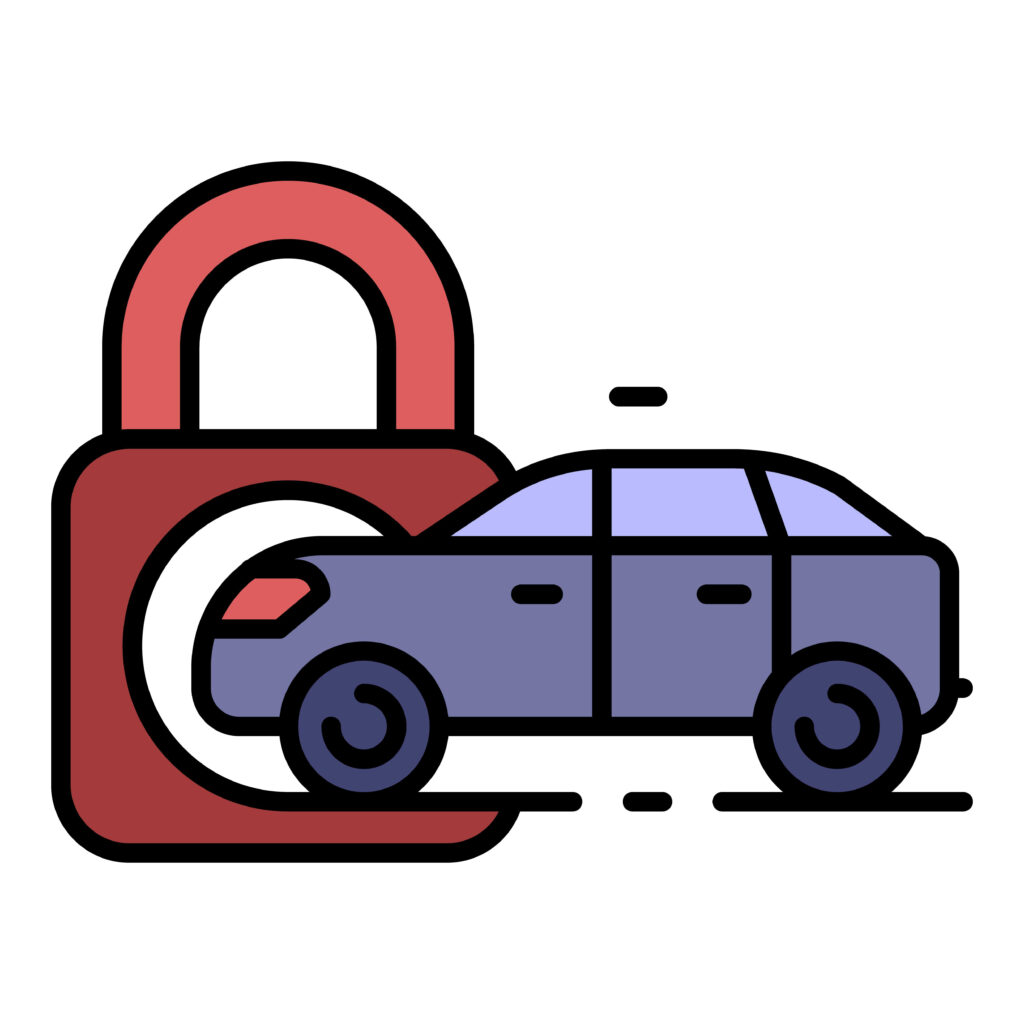Indegnità a succedere Indegnità a succedere: analisi dell'istituto ex art. 463 c.c. che esclude dalla successione chi ha compiuto atti gravi contro il de cuius o persone a lui vicine
Indegnità a succedere: cos’è
L’indegnità a succedere è una causa di esclusione dalla successione, sancita dall’articolo 463 del Codice Civile italiano. In base a questo istituto una persona, normalmente chiamata a succedere, viene privata del diritto di ereditare, a causa di comportamenti gravemente lesivi nei confronti del defunto o di persone a lui vicine. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio l’articolo 463 del Codice Civile, i suoi effetti sulla successione, e le principali pronunce giuridiche che hanno interpretato e applicato questa norma, per fornire una panoramica chiara e completa dell’istituto.
Quando si verifica l’indegnità a succedere
L’indegnità a succedere si verifica quando una persona, pur avendo diritto all’eredità come successibile, viene esclusa dalla successione a causa comportamenti gravi o immorali della stessa nei confronti del defunto. Il Codice Civile italiano prevede che alcune azioni, particolarmente gravi, possano privare un soggetto della capacità di ereditare.
L’istituto ha quindi natura punitiva e preventivo-sociale. Esso impedisce a chi ha compiuto atti gravi di godere dei benefici derivanti dalla morte di chi ha danneggiato.
Articolo 463 c.c.: cosa prevede
L’articolo 463 c.c. stabilisce che una persona è indegna a succedere se, con azioni od omissioni, ha compiuto atti gravi di rilievo penale e civile. L’indegnità colpisce infatti:
- chi, con volontà, ha ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente dello stesso, in assenza di una delle cause che ne escludono la punibilità;
- chi ha commesso, in danno di uno dei suddetti soggetti, un fatto a cui la legge dichiara applicabile le disposizioni sull’omicidio;
- chi ha denunciato una delle persone suddette per un reato punibile con l’ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata poi calunniosa nell’abito del giudizio penale; chi ha testimoniato contro le stesse persone imputate per i predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata falsa nel giudizio penale;
- chi è decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta e non è stato reintegrato nella stessa alla data di apertura della successione;
- chi ha indotto con dolo o violenza la persona a fare, revocare o mutare il testamento;
- chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento che regolerebbe la successione;
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Indegnità a succedere: cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza ha avuto e ha ancora un ruolo fondamentale nell’interpretare e applicare l’articolo 463 del Codice Civile. Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno infatti contribuito a chiarire l’ambito e i limiti dell’indegnità a succedere. Vediamo alcune delle principali pronunce.
Indegno chi contravviene ai doveri di assistenza familiare
La sentenza della Cassazione Civile n. 19547/2008 ha stabilito che l’indegnità a succedere non si limita ai casi di omicidio o tentato omicidio. Essa si realizza in tutti i casi in cui il comportamento del successibile contravvenga ai doveri di rispetto e di assistenza familiare. Il caso riguardava un figlio che, pur non avendo ucciso il padre, aveva compiuto atti di grave maltrattamento psicologico e fisico nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto che tali azioni giustificassero l’esclusione dalla successione. A conclusioni similari è giunta, sempre la Cassazione, nella sentenza n. 10591/2012. La Corte ha escluso infatti dalla successione una persona che, pur non avendo compiuto atti di violenza fisica diretta, aveva continuato a trattare il padre malato in modo indegno e disumano, causando allo stesso un grave danno psicologico. La decisione della Cassazione ha sancito quindi che l’indegnità può derivare da atti non necessariamente violenti, ma comunque lesivi della dignità del defunto.
Indegno chi commette violenza economica
Gli Ermellini, nella sentenza n. 5935/2018 si sono occupati invece della questione della violenza economica come causa di indegnità a succedere. Un coniuge che aveva abusato della posizione di potere economico nei confronti del defunto, sottraendo beni o controllando in modo oppressivo le risorse finanziarie, è stato ritenuto indegno a succedere. La Corte ha interpretato l’indegnità come una misura che tutela non solo la vita fisica del defunto, ma anche il suo patrimonio e la sua integrità morale.
Dichiarazione di indegnità
L’indegnità a succedere non si verifica in ogni caso automaticamente: deve essere accertata in giudizio. Per dichiarare una persona indegna di succedere è necessario infatti che il tribunale prenda una decisione formale in seguito a una causa avviata da un altro soggetto che vanta diritti sull’eredità. Chi ha interesse a escludere un successibile dalla successione può quindi ricorrere al tribunale per ottenere una sentenza di indegnità, che ha natura costituiva.
Effetti dell’indegnità a succedere
La sentenza di indegnità comporta l’esclusione dalla successione del soggetto indegno, che perde quindi il diritto a ricevere beni e diritti rientranti nell’eredità del defunto.
La persona indegna non eredita nulla dal defunto, neppure legati o donazioni disposti in suo favore dal de cuius. Il patrimonio del defunto verrà quindi suddiviso tra quei soggetti che, per legge o per testamento, possono succedere al de cuius.
Riabilitazione dell’indegno
L’articolo 466 c.c prevede però che, chi è stato dichiarato indegno, possa essere riammesso a succedere se lo stesso è stato riabilitato espressamente per mezzo di un atto pubblico o di un testamento. Se poi l’indegno che non è stato riabilitato espressamente, è stato incluso nel testamento e il testatore conosceva la causa di indegnità, allora l’indegno può essere ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria in suo favore.
Leggi anche: Testamento: no all’interpretazione troppo “tecnica”