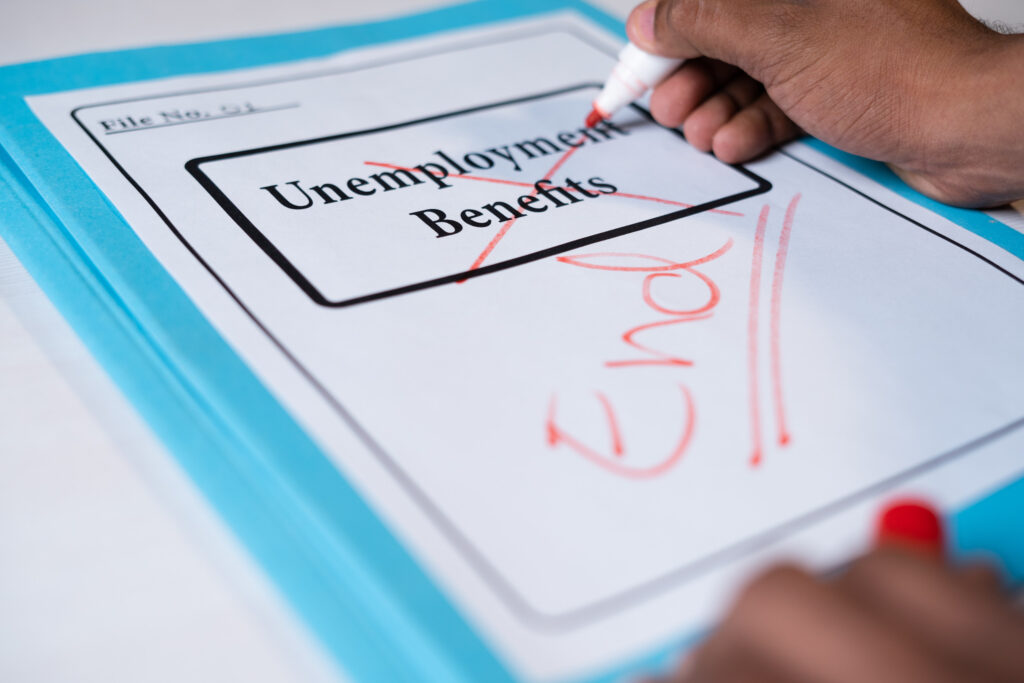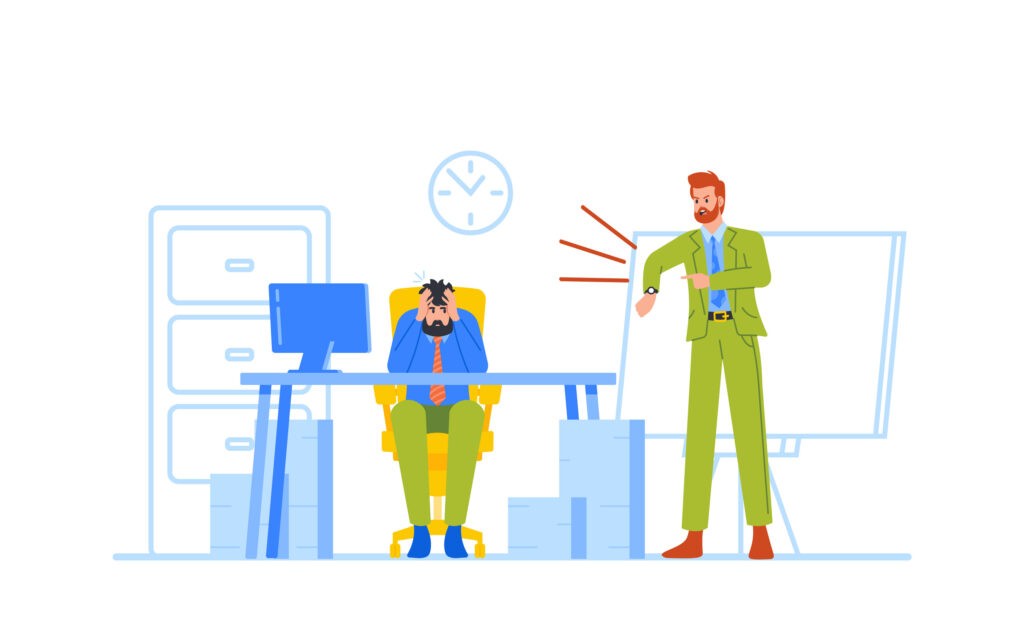Somministrazione di lavoro: la guida Somministrazione di lavoro: cos’è, normativa, tipologie contrattuali, principali novità 2025, quando la somministrazione è irregolare
Cos’è la somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è una forma contrattuale regolata dal diritto del lavoro italiano che consente a un soggetto (agenzia per il lavoro) di assumere un lavoratore per poi “somministrarlo” a un’altra azienda. Questo modello è utilizzato per garantire flessibilità alle imprese e tutele ai lavoratori. La somministrazione di lavoro configura quindi un rapporto triangolare tra:
- agenzia per il lavoro (somministratore), che assume il lavoratore;
- lavoratore somministrato, assunto dall’agenzia;
- impresa utilizzatrice, che ne utilizza le prestazioni lavorative.
L’impresa utilizzatrice non è il datore di lavoro in senso giuridico, ma esercita il potere direttivo e di controllo durante la prestazione.
Normativa di riferimento
Il contratto di somministrazione è regolato principalmente da:
- Decreto legislativo n. 81/2015, articoli 30-40;
- Decreto legislativo n. 276/2003, per alcuni profili ancora vigenti;
- Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.
Le agenzie autorizzate devono essere iscritte nell’apposito albo dell’ANPAL e possono operare solo se accreditate.
Tipologie di contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione può essere:
1. A tempo determinato
È la forma più diffusa e ha una durata massima di 24 mesi presso lo stesso utilizzatore.
2. A tempo indeterminato (staff leasing)
Il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia e messo a disposizione dell’utilizzatore per periodi anche lunghi, superiori ai 24 mesi. Questa forma è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi.
Somministrazione di lavoro: forma contratto
Il contratto di somministrazione deve essere:
- stipulato per iscritto a pena di nullità;
- deve contenere elementi essenziali come: identità delle parti, la durata, l’attività richiesta, la sede di lavoro, il livello contrattuale.
Anche il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore deve essere scritto e deve contenere:
- le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro;
- la previsione del diritto alla parità di trattamento del lavoratore in somministrazione rispetto agli altri dipendenti;
- eventuali benefit (es. buoni pasto, premi aziendali).
Parità di trattamento e tutele del lavoratore
Il lavoratore in somministrazione, proprio in virtù del diritto alla parità di trattamnento, ha diritto alle medesime condizioni economiche e normative previste per i dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice (inclusi ferie, malattia, permessi, sicurezza sul lavoro, accesso alla mensa, ecc.).
Ha inoltre diritto alla:
- formazione professionale da parte dell’agenzia;
- indennità mensile di disponibilità (se a tempo indeterminato e non assegnato a missione);
- copertura assicurativa INAIL e previdenziale INPS.
Somministrazione di lavoro: novità 2025
Nel 2025 sono state apportate modifiche significative al contratto di somministrazione di lavoro ad opera del Decreto Lavoro 2024 (attuativo del PNRR), in particolare:
- l’utilizzo di lavoratori somministrati a tempo indeterminato è contingentato: non possono superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda utilizzatrice. Tuttavia, questa limitazione non si applica a categorie specifiche come i lavoratori in mobilità, i disoccupati da almeno sei mesi con sostegno al reddito e i lavoratori svantaggiati;
- è stata eliminata la possibilità di impiegare lo stesso lavoratore somministrato a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi senza l’effetto di l’instaurare un contratto a tempo indeterminato con l’azienda utilizzatrice;
- per i contratti a tempo determinato, inclusi quelli in somministrazione, è previsto un limite numerico complessivo: non possono eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’utilizzatore. Anche in questo caso, sono esenti da tale limite i lavoratori somministrati a tempo indeterminato, i disoccupati di lunga durata con ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati.
A partire dal 1° luglio 2025, inoltre, conclusa la fase transitoria, non è più possibile stipulare contratti di somministrazione di durata superiore ai 24 mesi. In caso contrario, si costituisce un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Somministrazione irregolare
Se il contratto di somministrazione viene stipulato senza rispettare le condizioni previste dagli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 81/2021, la somministrazione risulta irregolare (art. 38 d.lgs. 81/2015). In questo caso, il lavoratore può chiedere la constitutio ex tunc del rapporto con l’utilizzatore, con assunzione diretta.
Leggi anche: Collegato Lavoro: cosa prevede