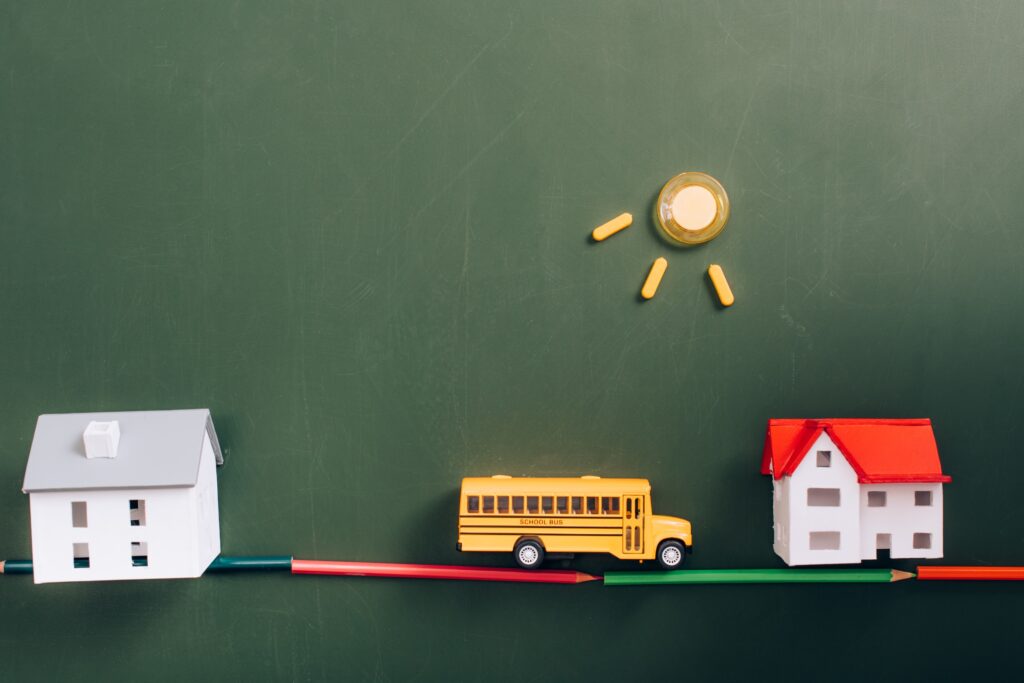Diritto alla pausa Diritto alla pausa: cos'è, quale normativa lo disciplina e cosa prevede la recente giurisprudenza della Cassazione
Diritto alla pausa: cos’è
Il diritto alla pausa è un diritto che il nostro ordinamento riconosce al lavoratore dipendente quando la giornata lavorativa supera le sei ore. Questa sospensione dall’attività lavorativa è necessaria per recuperare le energie, consumare un eventuale pasto e interrompere la ripetitività del lavoro.
Disciplina di riferimento: art. 8 dlgs n. 66/2003
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 66/2023 (attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) dispone che qualora la giornata lavorativa preveda più di 6 ore di attività, il dipendente ha diritto a un intervallo di pausa per il recupero delle energie fisiche e psichiche, per la consumazione di un eventuale pasto e per attenuare la monotonia delle mansioni.
Le specifiche riguardo alla durata e alle modalità di fruizione della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva. Qualora non sia presente una specifica disciplina collettiva, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di almeno 10 minuti. Questa pausa deve essere concessa tra l’inizio e la fine del turno giornaliero, tenendo conto delle esigenze tecniche del processo produttivo.
In linea generale, e salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, i periodi di pausa non sono considerati ore di lavoro retribuite e non concorrono al superamento dei limiti massimi di durata dell’orario di lavoro.
Questa disposizione si rifà a normative storiche in materia di orario di lavoro e riposi.
L’articolo 5 del Regio decreto n. 1955/1923 prevede infatti che le interruzioni di almeno 10 minuti e non più di due ore, durante le quali non viene richiesta alcuna prestazione al dipendente non vengono calcolate come lavoro effettivo. Di conseguenza, non sono retribuite e non rientrano nel calcolo dell’orario massimo, salvo particolari eccezioni.
Parimenti l’articolo 4 del Regio decreto n. 1956/2023 prevede che le pause intermedie che si prendono durante la giornata lavorativa non sono considerate lavoro effettivo. Di conseguenza, non vengono calcolate nel limite massimo di ore di lavoro giornaliere stabilito dalla legge.
Diritto alla pausa: giurisprudenza
Diversi aspetti applicativi del diritto alla pausa lavorativa sono stati specificati anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione.
Cassazione n. 21878/2025: il diritto alla pausa viene riconosciuto solo se il lavoratore può dimostrare che la pausa stessa è strettamente connessa o collegata alla sua prestazione lavorativa.Inoltre, per poter usufruire di questo diritto, la pausa deve essere eterodiretta, ovvero deve essere gestita e controllata dal datore di lavoro, e il lavoratore non deve averne la completa autonomia per quanto riguarda la sua durata.
Cassazione n. 20249/2025: la continua inosservanza dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 può causare un danno da usura psicofisica al lavoratore. Questo danno può essere riconosciuto anche senza una prova diretta, purché si basi su presunzioni fondate.
Cassazione n. 12504/2025: la pausa non può essere negata o limitata dal datore di lavoro, in quanto è un elemento fondamentale per la salute e il benessere del lavoratore.Il datore di lavoro può intervenire e limitare la pausa solo in due casi: se la durata supera il tempo stabilito dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale, in mancanza di queste disposizioni, se la pausa supera i 10 minuti. In conclusione, il datore di lavoro può vietare la pausa solo se questa eccede i limiti di tempo previsti.
Cassazione n. 8707/2025: legittimo il licenziamento dell’incaricato della raccolta porta a porta dei rifiuti. La motivazione è stata la violazione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003, che riguarda le pause intermedie. Nello specifico, il lavoratore aveva effettuato soste frequenti e prolungate in bar durante l’orario di servizio, superando i limiti di tempo previsti per le pause.
Leggi anche: Diritto al pasto anche fuori dalle fasce orarie per i turnisti