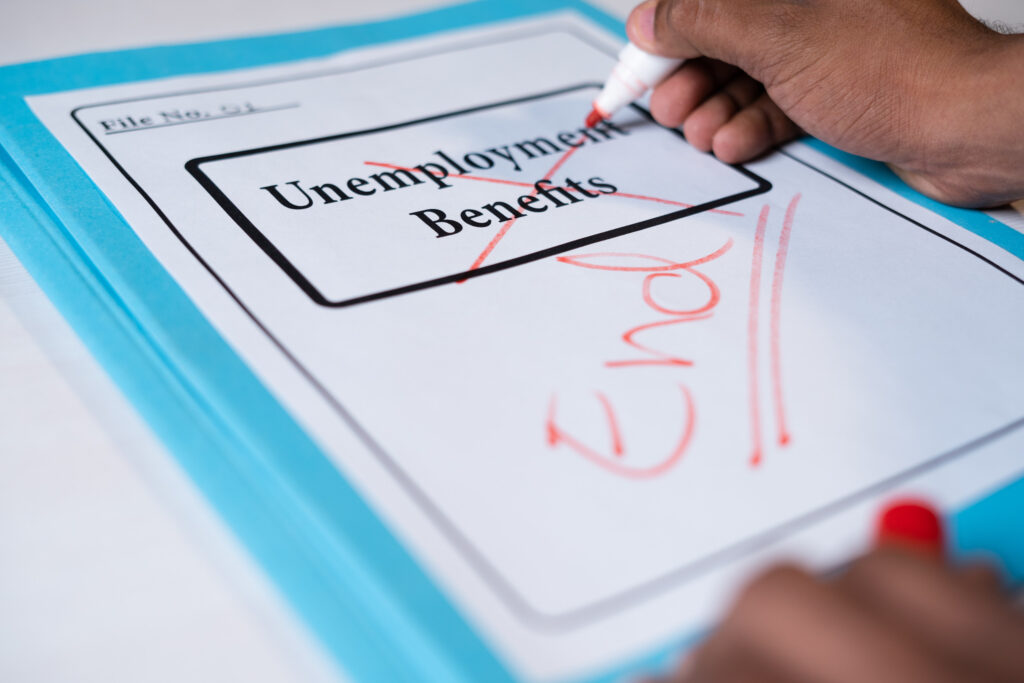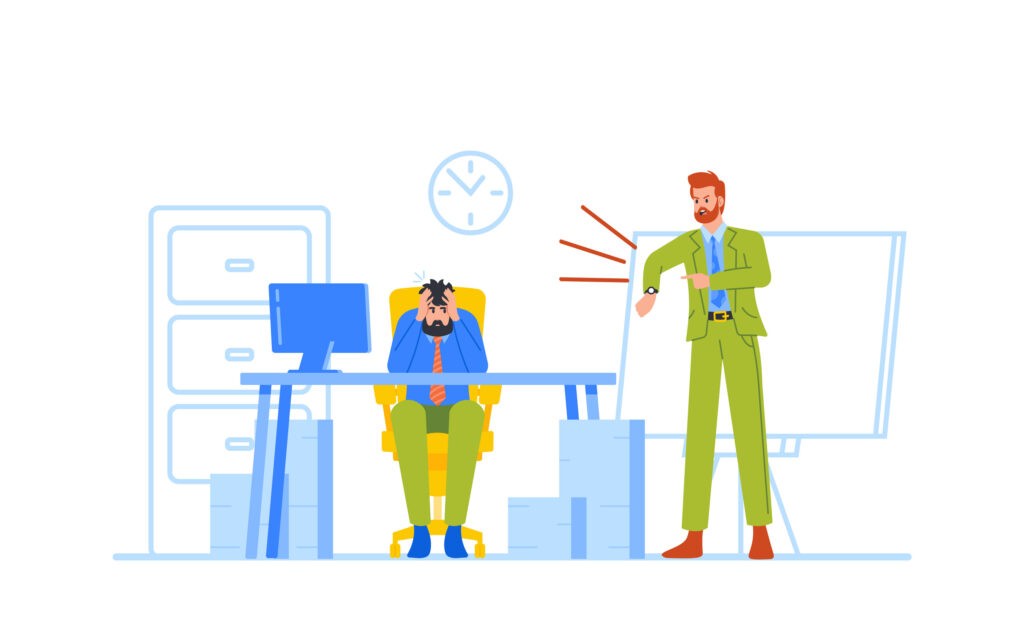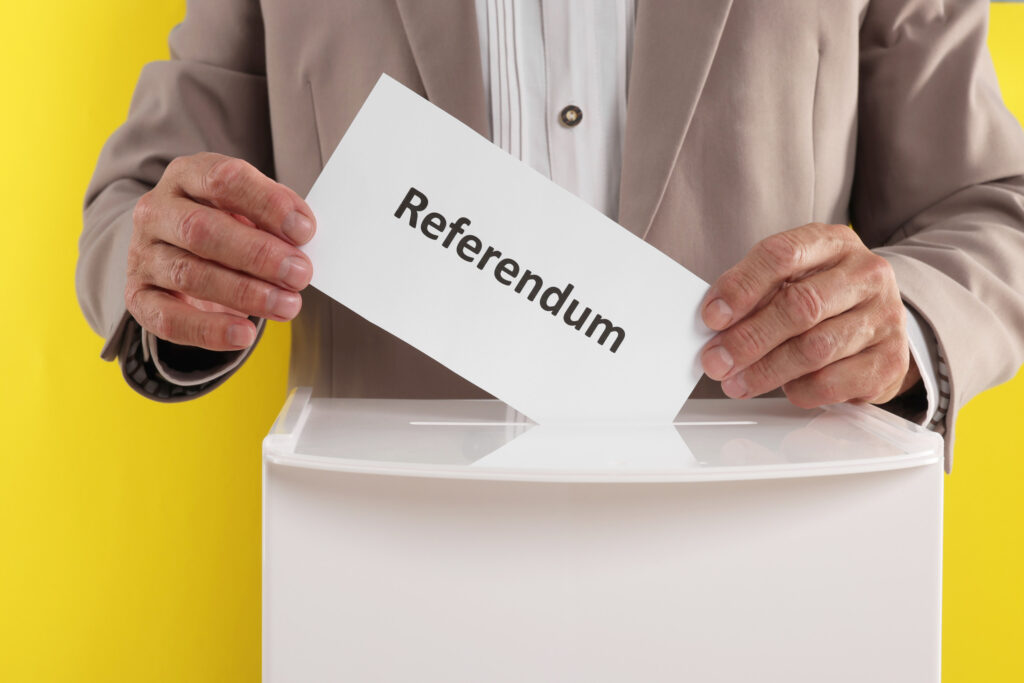Bonus giovani under 35: come ottenerlo Bonus giovani under 35: in cosa consiste l'esonero contributo previsto dal decreto Coesione e come presentare domanda
Bonus giovani under 35
Bonus giovani under 35: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 i datori di lavoro privati possono usufruire di un incentivo contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano mai avuto un contratto stabile. Lo ha previsto il decreto-legge n. 60/2024 (decreto Coesione) e le modalità operative sono state dettagliate nella circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025.
A partire dal 16 maggio 2025, è attivo il modulo telematico per richiedere l’agevolazione sul Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), modificato dall’istituto a partire dal 18 giugno 2025 in conformità alle indicazioni del ministero del Lavoro.
A chi spetta il Bonus giovani 2025
L’incentivo, si ricorda, è rivolto a tutti i datori di lavoro privati (esclusi gli enti pubblici) che assumano, o trasformino un contratto da determinato a indeterminato, giovani che:
-
non abbiano ancora compiuto 35 anni alla data di assunzione;
-
non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato, in Italia o all’estero.
Quali sono i vantaggi per le imprese?
Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con un tetto mensile di 500 euro per lavoratore.
Per i datori di lavoro con sede in una delle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno – ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – il limite dell’incentivo mensile sale a 650 euro per ciascun lavoratore assunto.
Requisito dell’incremento netto dell’occupazione
A seguito della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del decreto interministeriale 11 aprile 2025, che ha definito i criteri e le modalità attuative del Bonus giovani, sono state fornite nuove indicazioni ai fini della legittima fruizione dell’esonero contributivo.
Come richiesto, nello specifico, dalla Commissione europea, la fruizione del bonus, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata, come condizione di ammissibilità, al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.
Pertanto, l’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha comunicato di aver aggiornato sia le procedure attuative che il modulo di domanda in aderenza alle indicazioni fornite.
Chi sono i lavoratori esclusi?
Non rientrano nell’ambito del Bonus:
-
i dirigenti;
-
i lavoratori domestici;
-
i rapporti di lavoro instaurati con contratto di apprendistato.
Come presentare la domanda
Per accedere all’incentivo, è necessario:
-
accedere al Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo);
-
compilare e inviare l’apposito modulo online disponibile dal 16 maggio 2025;
-
seguire le istruzioni operative contenute nella circolare INPS n. 90/2025.
Leggi anche Decreto coesione: bonus under 35 e donne