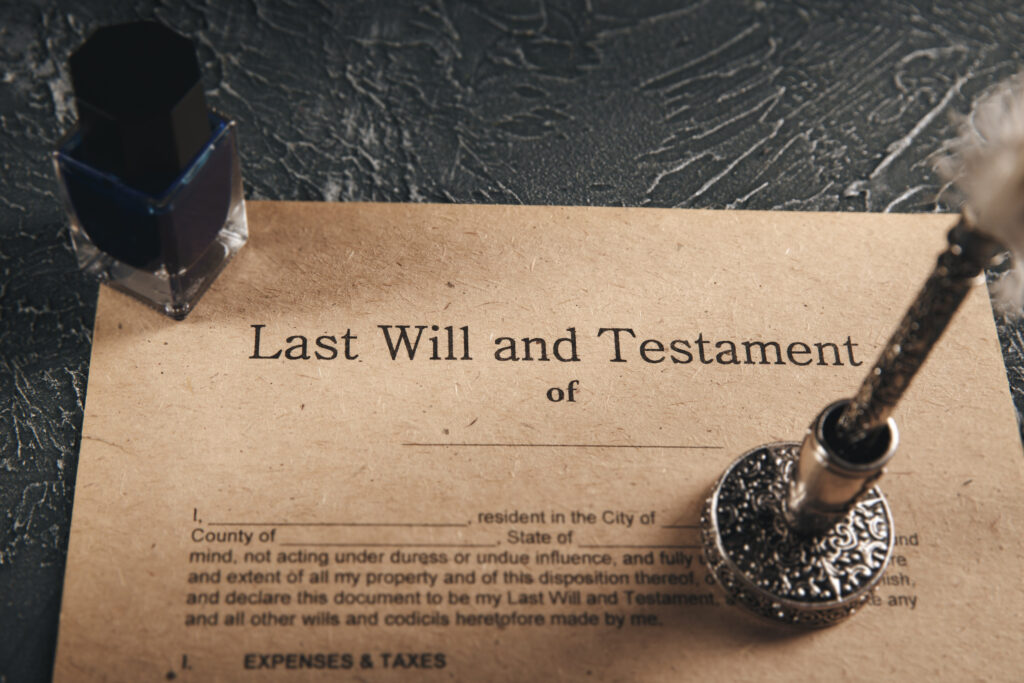Tribunale online
Tribunali più smart per una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini. E’ questo l’obiettivo della sperimentazione del progetto “Tribunale online” attivo in sette sedi (Catania, Catanzaro, L’Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona) dal 1° marzo 2024.
Dal 1° luglio 2025 si entra nella seconda fase di sperimentazione con l’ampliamento dell’offerta di servizi con nuove tipologie di istanze disponibili online, tra cui la nomina del cancelliere o del notaio incaricato dell’inventario, l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, l’istanza di proroga per l’inventario e le autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.
Contestualmente, cresce anche la rete dei Tribunali coinvolti nella sperimentazione: alle sette sedi giudiziarie già attive – Catania, Catanzaro, L’Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona – si aggiunge il Tribunale di Roma.
L’iniziativa, realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, è stata finanziata nell’ambito del Pon Governance 2014-2020, in coerenza con le priorità indicate dal Pnrr.
Caratteristiche
Il portale, fruibile da qualsiasi dispositivo, è costituito da una sezione pubblica accessibile a tutti, di natura informativa, e da una sezione riservata, in cui i cittadini dotati di identità digitale (SPID, CIE o CNS) possono depositare autonomamente alcune istanze nei procedimenti di volontaria giurisdizione e monitorarne lo stato di avanzamento.
Il portale Tribunale Online è disponibile all’indirizzo https://smart.giustizia.it/to e raggiungibile dal portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia https://pst.giustizia.it.
All’interno dell’area pubblica, liberamente accessibile, sono contenute informazioni su iter procedurali, attori, tempi e costi dei servizi, modulistica completa e istruzioni sul deposito presso i Tribunali, oltre a una sezione dedicata alle domande frequenti.
La sperimentazione del Tribunale Online ha reso possibile ad oggi, il deposito telematico delle istanze in alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione, come l’amministrazione di sostegno, la gestione di eredità giacente e la nomina del curatore. Dal 1° luglio 2025, l’offerta di servizi si amplia ulteriormente. Con la seconda fase, infatti, la piattaforma si arricchisce di nuove funzionalità, offrendo ai cittadini la possibilità di svolgere un numero crescente di attività in modo sempre più semplice, rapido e digitale.
Nei prossimi mesi, il Tribunale Online continuerà ad evolversi con l’introduzione di ulteriori servizi e strumenti pensati per migliorare e ampliare l’esperienza d’uso, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente a tutti i Tribunali sul territorio nazionale, per una giustizia sempre più accessibile e vicina alle persone.
Procedimenti ammessi
I procedimenti ammessi al deposito telematico attraverso la piattaforma sono: amministrazione di sostegno (art.473-bis.58 c.p.c.); gestione dell’eredità giacente e nomina del curatore (art.782 c.p.c.); richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione in favore di minori (art. 320, 374 c.p.c.); autorizzazione al rilascio di passaporto o documento valido per l’espatrio per figli minori (art 3, lett.a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185).
La piattaforma è predisposta altresì per la consultazione di molteplici procedimenti nell’ambito della volontaria giurisdizione. Nei casi in cui il procedimento, o il Tribunale di riferimento, non sia tra quelli coinvolti nella sperimentazione, l’utente avrà la possibilità di recepire informazioni utili all’avvio dell’iter per l’atto di interesse, con indicazione e riferimenti dell’ufficio giudiziario di competenza territoriale.
Il deposito per l’utenza non qualificata sarà possibile attraverso la compilazione online con procedura guidata e l’invio della domanda direttamente dalla piattaforma.
Le notifiche cartacee da parte dell’ufficio giudiziario, spedite tramite raccomandata postale, saranno sostituite dalle notifiche di avvenuta consegna visualizzabili nell’area riservata del portale.
La modulistica eterogenea tra uffici giudiziari sarà sostituita da una modulistica standard, disponibile nell’Area pubblica del portale.