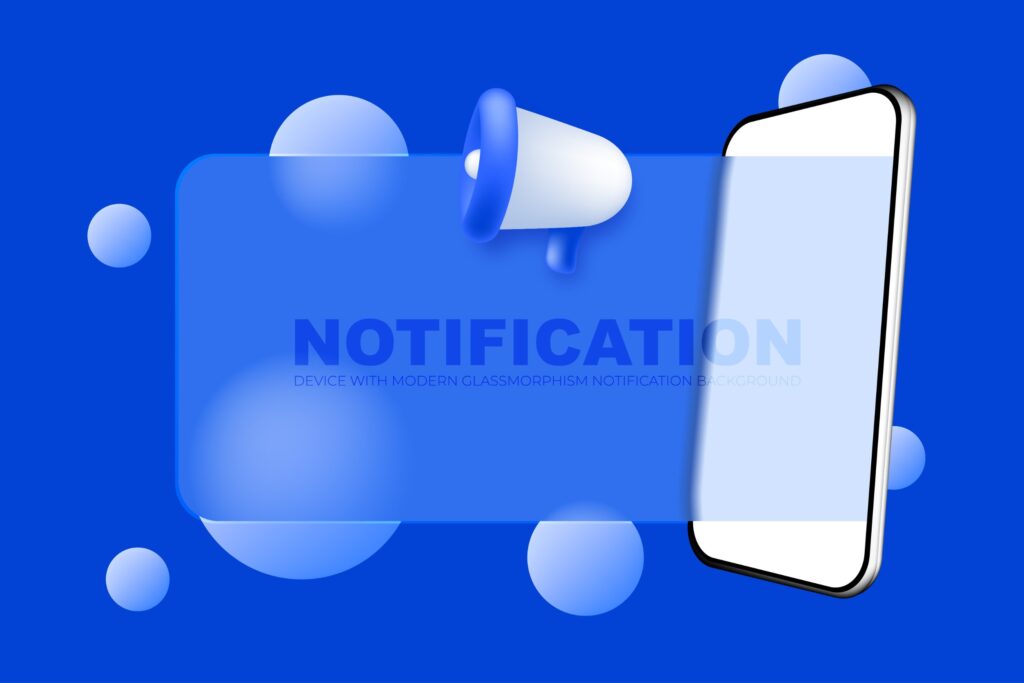Usufrutto: guida breve Usufrutto: guida breve al diritto reale più ampio che consente al titolare di godere di un bene altrui anche per tutta la vita
Usufrutto nel codice civile
L’usufrutto è uno dei diritti reali di godimento disciplinati dal Codice Civile italiano, dall’articolo 978 e seguenti. Si tratta di un istituto giuridico che consente all’usufruttuario di utilizzare e godere di un bene altrui, traendone i frutti, senza tuttavia che lo stesso possa modificarne la destinazione economica e acquisirne la proprietà.
Cos’è l’usufrutto?
Ai sensi dell’articolo 978 del Codice Civile, l’usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Esso può riguardare beni mobili, immobili o universalità di beni, come un’azienda o un patrimonio ereditario.
L’usufruttuario ha il diritto di utilizzare il bene come se fosse il proprietario, ma deve preservarne l’integrità per restituirlo al nudo proprietario al termine del periodo stabilito.
Oggetto
L’oggetto di questo istituto è molto ampio e comprende beni mobili, immobili e anche diritti. La regola generale è che il bene deve essere infungibile o inconsumabile per poter essere restituito. Il quasi-usufrutto rappresenta un’eccezione, riguardando beni consumabili che, per loro natura, non possono essere restituiti in natura. In questo caso, l’usufruttuario acquista la proprietà del bene consumato e ha l’obbligo di corrispondere il suo valore al termine dell’usufrutto.
Costituzione
L’usufrutto può nascere in diversi modi:
- per legge: i genitori, ad esempio, hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minorenni;
- per contratto: è la modalità più comune, ma richiede la forma scritta e la trascrizione;
- per testamento: il testatore può lasciare in usufrutto un bene a una persona;
- per usucapione: acquisendo il diritto mediante il possesso prolungato nel tempo.
Durata
L’usufrutto può essere:
- temporaneo: con una durata determinata contrattualmente o stabilita dalla legge;
- vitalizio: termina con la morte dell’
In base all’articolo 979 del Codice Civile, questo diritto reale non può eccedere la vita dell’usufruttuario e, nel caso di enti giuridici, non può durare per più di 30 anni.
Diritti e doveri dell’usufruttuario
L’usufruttuario gode di ampi diritti sull’uso del bene:
- uso e godimento: può utilizzare il bene personalmente o concederlo in locazione a terzi (art. 980 c.c.);
- frutti: ha diritto ai frutti naturali e civili del bene, come prodotti agricoli o rendite da affitto (art. 984 c.c.),
- modifiche migliorative: può apportare migliorie al bene, ma senza alterarne la destinazione economica.
A fronte di questi diritti l’usufruttuario ha anche tutta una serie di obblighi:
- conservazione del bene: deve utilizzare il bene come un buon padre di famiglia, evitando deterioramenti (art. 1001 c.c.);
- riparazioni ordinarie: egli è tenuto a sostenere le spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 c.c.), mentre quelle straordinarie spettano al nudo proprietario;
- garanzia: in caso di costituzione contrattuale, l’usufruttuario potrebbe essere obbligato a prestare garanzia per tutelare il nudo proprietario (art. 1002 c.c.).
Estinzione dell’usufrutto
L’usufrutto si estingue in diverse circostanze, come previsto dagli articoli 1014 e seguenti del Codice Civile:
- morte dell’usufruttuario: per gli usufrutti vitalizi;
- scadenza del termine: se è temporaneo;
- consolidazione: quando il diritto di usufrutto si unisce alla proprietà nello stesso soggetto;
- perimento del bene: se il bene su cui grava viene distrutto;
- rinuncia: volontà dell’usufruttuario di rinunciare al diritto.
Usufrutto e nuda proprietà
Il rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario è centrale nell’usufrutto. Il nudo proprietario mantiene il diritto di proprietà, ma non può godere del bene fino alla cessazione di questo diritto reale. Questo equilibrio consente una gestione condivisa del bene, con benefici reciproci.
Implicazioni pratiche
L’istituto trova ampia applicazione in ambito familiare e commerciale. Spesso è utilizzato per garantire il sostentamento di un coniuge superstite, per la gestione di patrimoni immobiliari o come strumento per pianificazioni successorie. Un genitore infatti può decidere di mantenere l’usufrutto su un immobile donato ai figli, assicurandosi così il diritto di abitazione.
Leggi anche: Usufrutto coniuge legittimario