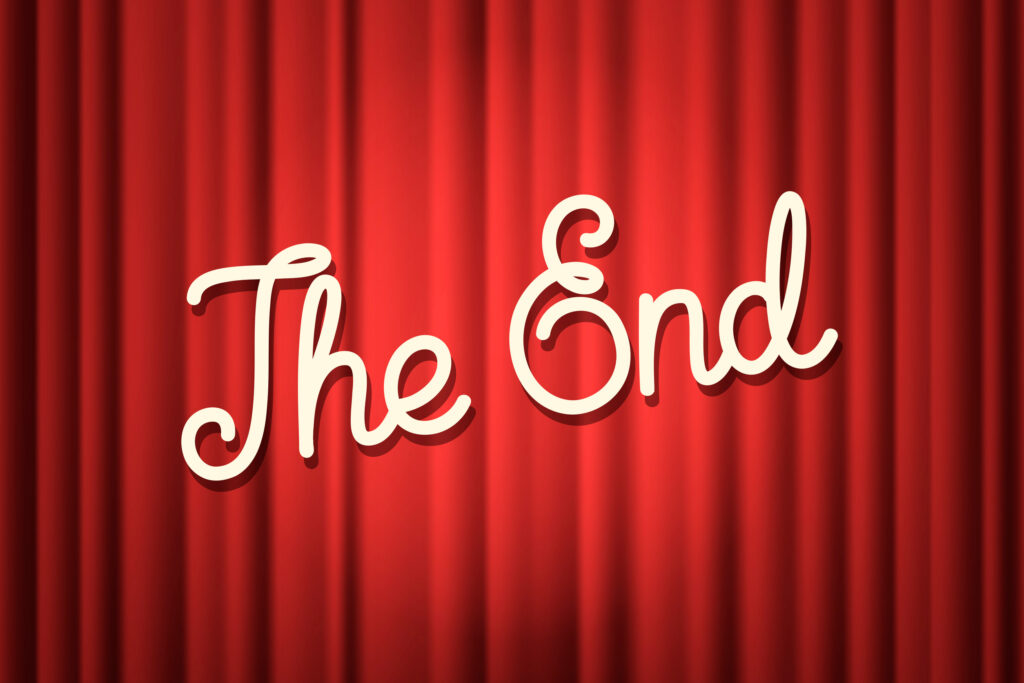Perenzione nel processo amministrativo
La perenzione è un istituto giuridico che regola la scadenza di certi termini processuali. Essa determina infatti la cessazione automatica di un’azione legale se la stessa non viene svolta entro il periodo previsto dalla legge. Questo concetto ha un’importanza fondamentale per garantire l’efficienza e la certezza dei processi amministrativi. In Italia, la perenzione è disciplinata dal DLgs n. 104/2010, noto come Codice del Processo Amministrativo, che ha introdotto diverse norme in materia di scadenze processuali e decadenze dei ricorsi.
In questo articolo, esamineremo gli articoli 81-85 del DLgs n. 104/2010, che regolano la perenzione nel processo amministrativo, approfondendo la sua applicazione pratica e le principali pronunce giuridiche che hanno contribuito a chiarire l’ambito di operatività di questo istituto.
Cos’è la perenzione?
La perenzione si verifica quando un’azione legale, che non venga portata avanti nel tempo previsto dalla legge, perde efficacia, determinando la decadenza del ricorso.
Nel contesto del processo amministrativo, la perenzione si applica principalmente ai ricorsi giurisdizionali amministrativi, che, se non attivati o non seguiti con le necessarie attività procedurali (come il deposito di documenti o l’avanzamento della causa), cadono in perenzione, estinguendosi automaticamente.
La perenzione ha quindi lo scopo di velocizzare i processi ed evitare l’accumulo di cause non attuali, ottimizzando il lavoro dei tribunali amministrativi e delle autorità competenti.
Codice del processo amministrativo: artt. 81-85
Come anticipato, la perenzione trova la sua disciplina negli articoli 81, 82. 83, 84 e 85 del decreto legislativo n. 104/2010, che ha disposto il riordino del processo amministrativo. Analizziamo singolarmente queste norme.
Articolo 81 – Perenzione: un ricorso è considerato perento se non viene compiuto alcun atto di procedura per un anno. Il termine di un anno non decorre dal momento della presentazione di un’istanza per la fissazione dell’udienza, fino a quando non vi sia una decisione su di essa, salvo eccezioni.
Articolo 82 – Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali: se un ricorso rimane pendente per più di cinque anni dalla sua presentazione, la segreteria notifica alle parti l’obbligo per il ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza entro 120 giorni. Tale istanza deve essere firmata dal ricorrente e dal suo avvocato. In mancanza di questa istanza, il ricorso è dichiarato perento. Se invece viene comunicata la fissazione dell’udienza senza la notifica precedente, il ricorso può essere deciso solo se il ricorrente dichiara interesse alla decisione, altrimenti è dichiarato perento con decreto.
Articolo 83 – Effetti della perenzione: La perenzione si applica automaticamente (di diritto) e può essere rilevata anche d’ufficio. Ogni parte sopporta le proprie spese processuali.
Articolo 84 – Rinuncia: Una parte può rinunciare al ricorso in qualsiasi fase del processo attraverso: 1. una dichiarazione scritta firmata dalla parte stessa o dall’avvocato con mandato speciale, da depositare presso la segreteria; 2. una dichiarazione resa in udienza e registrata nel verbale. Il rinunciante deve sostenere le spese degli atti compiuti, salvo diversa decisione del collegio. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima dell’udienza. Se non vi è opposizione, il processo si estingue. Il giudice può comunque dedurre la perdita di interesse alla causa da fatti o comportamenti delle parti.
Articolo 85 – Procedura per l’estinzione e l’improcedibilità: l’estinzione e l’improcedibilità possono essere dichiarate con un decreto del presidente o di un magistrato delegato. Il decreto è comunicato alle parti dalla segreteria. Le parti hanno 60 giorni dalla comunicazione per opporsi al collegio mediante atto notificato a tutte le altre parti. Il giudizio di opposizione è deciso con un’ordinanza che, se accoglie l’opposizione, fissa una nuova udienza. In caso di rigetto, le spese sono a carico dell’opponente senza possibilità di compensazione. L’ordinanza è comunicata alle parti e può essere impugnata in appello. Se l’estinzione o l’improcedibilità si verificano durante l’udienza di discussione, vengono dichiarate con sentenza.
Giurisprudenza sulla perenzione
La giurisprudenza ha avuto un ruolo cruciale nell’interpretare e applicare i principi della perenzione, cercando di chiarire i contorni di questa disciplina e di bilanciare le esigenze di celerità dei processi con la tutela dei diritti degli utenti del processo amministrativo.
Consiglio di Stato sentenza n. 4318/2017
Nel processo amministrativo, il termine di perenzione previsto dall’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) non decorre se la mancata fissazione dell’udienza da parte della Segreteria dipende da un’omissione di quest’ultima. In tali circostanze, l’inerzia del procedimento non può essere attribuita alle parti, che non hanno la possibilità di intervenire in un’attività procedurale demandata esclusivamente all’ufficio. Le parti hanno quindi il diritto di fare affidamento sull’obbligo della Segreteria di fissare l’udienza d’ufficio.
Consiglio di Stato sentenza n. 3017/2018
La perenzione nel processo amministrativo ha una duplice natura: privatistica, perché presuppone una tacita rinuncia delle parti alla prosecuzione del giudizio; pubblicistica, in quanto mira a soddisfare l’interesse pubblico a una rapida definizione delle controversie relative all’esercizio del potere amministrativo. Questo istituto risponde quindi all’esigenza di garantire la chiusura delle situazioni giuridiche coinvolgenti la Pubblica Amministrazione entro un termine ragionevole.
Consiglio di Stato sentenza n. 3426/2019
Nel giudizio amministrativo, il giudice può rilevare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa anche in assenza delle formalità previste dall’art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010. Tale valutazione può basarsi su fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, nonché sul comportamento delle parti, che possono fornire elementi utili a dimostrare la perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Effetti della perenzione
La perenzione ha effetti rilevanti sul processo amministrativo. Quando si applica la perenzione, il ricorso diventa inefficace, e il procedimento legale si estingue senza che sia necessaria una pronuncia di merito. Ciò significa che il ricorrente perde la possibilità di far valere i propri diritti in quel determinato processo, e il ricorso non potrà più essere ripreso nemmeno su richiesta della parte. I termini di perenzione sono dunque strumenti utilizzati per accelerare i procedimenti amministrativi e per evitare l’accumulo di ricorsi inerti. Tuttavia, la legge consente alcune deroghe, soprattutto nei casi in cui vi siano impedimenti giustificati che impediscono al ricorrente di proseguire l’azione.
Leggi anche: gli altri interessanti articoli di diritto amministrativo