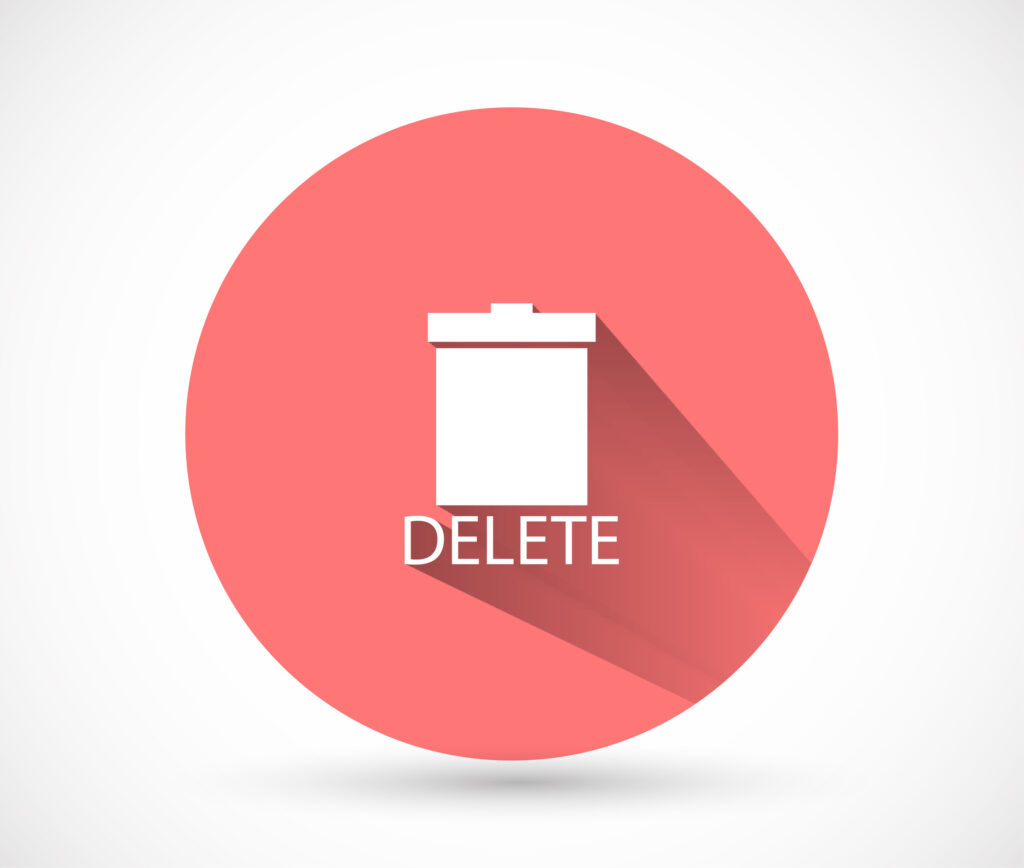Procedimento amministrativo: i principi
Il procedimento amministrativo è regolato da una serie di principi fondamentali che garantiscono il corretto esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione (PA). Tali principi, sanciti dalla legge n. 241/1990, assicurano che l’azione amministrativa sia efficiente, equa e trasparente. In questo articolo analizzeremo in dettaglio i principali principi: economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità, con riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Normativa di riferimento
La disciplina del procedimento amministrativo è contenuta nella legge n. 241/1990, intitolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Questa legge ha introdotto un modello più moderno di amministrazione partecipata, ponendo l’accento su criteri di efficienza e tutela dei cittadini.
Tra gli articoli più rilevanti troviamo:
Articolo 1: stabilisce i principi generali dell’azione amministrativa;
Art. 3: impone alla PA di motivare i provvedimenti amministrativi;
Articolo 7 e seguenti: disciplinano la partecipazione al procedimento;
Art. 22 e seguenti: regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
I 5 principi del procedimento amministrativo
L’azione della PA e il procedimento amministrativo devono ispirarsi e rispettare i seguenti principi:
Economicità
Il riferimento normativo di questo principio si trova nell’art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990. Il principio di economicità impone alla PA di svolgere la propria attività ottimizzando risorse e costi. Ciò significa che le amministrazioni devono adottare soluzioni che garantiscano il miglior risultato possibile con il minore impiego di risorse pubbliche.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’economicità dell’azione amministrativa non deve tradursi in un risparmio fine a sé stesso, ma deve essere bilanciata con gli altri principi, come l’efficacia e l’imparzialità.
Efficacia
Il riferimento normativo del principio dell’efficacia è rinvenibile nell’art. 1, comma 1, legge n. 241/1990. L’efficacia indica la capacità dell’azione amministrativa di raggiungere gli obiettivi prefissati nel minor tempo possibile. Questo principio è strettamente collegato ai termini procedimentali previsti dalla legge, che devono essere rispettati per evitare ritardi ingiustificati.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che un provvedimento amministrativo è inefficace se non è idoneo a produrre effetti concreti e conformi agli obiettivi della normativa di riferimento.
Imparzialità
Questo principio è richiamato dall’art. 97 Costituzione e dall’art. 1, legge n. 241/1990. Il principio di imparzialità, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, impone alla PA di operare senza favoritismi o discriminazioni. Gli atti amministrativi devono essere adottati in modo neutro e obiettivo, senza influenze esterne o interessi personali.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2070/2009 ha chiarito che il principio di imparzialità, con quello di legalità e del buon andamento, rappresenta uno dei pilastri sui quali si poggia lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. L’articolo 97 della Costituzione rappresenta un parametro importantissimo di valutazione dell’attività amministrativa e della sua legittimità, perchè rappresenta una declinazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzionale.
Trasparenza
Il riferimento normativo per la trasparenza che deve caratterizzare l’azione della Pubblica Amministrazione si rinviene nel D.lgs. 33/2013 e nell’art. 1 della legge n. 241/1990. La trasparenza garantisce ai cittadini il diritto di conoscere l’azione amministrativa, favorendo il controllo diffuso sull’operato della PA. La normativa prevede che gli atti e i procedimenti siano accessibili e consultabili da chiunque ne abbia interesse.
Il Tar Veneto n. 2548/2024 ha sancito che la Pubblica Amministrazione è tenuta a soddisfare le richieste di accesso civico generalizzato, a meno che non comportino un aggravio per le normali attività degli uffici, che la stessa deve dimostrare.
Pubblicità
Il riferimento normativo è rinvenibile nell’art. 22 della legge n. 241/1990 e del D.lgs. 33/2013.
Il principio di pubblicità impone alla PA di rendere conoscibili ai cittadini atti e provvedimenti, salvo i casi di riservatezza espressamente previsti dalla legge (ad esempio, per ragioni di sicurezza nazionale o tutela della privacy).
Consiglio di Stato n. 7470/2010: il principio di pubblicità nelle gare d’appalto si applica rigorosamente solo quando le decisioni del seggio di gara possono influenzare la partecipazione dei concorrenti. Tale interpretazione è supportata da precedenti giurisprudenziali della Sezione V, specificamente le sentenze n. 6311 del 14 ottobre 2009 e n. 2355 dell’11 maggio 2007.
Considerazioni conclusive
L’azione della pubblica amministrazione deve essere efficiente, equa e accessibile, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 241/1990 e dalla Costituzione. La giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato l’importanza di questi principi, che rappresentano un baluardo contro abusi e inefficienze.
Leggi anche la guida: Il procedimento amministrativo