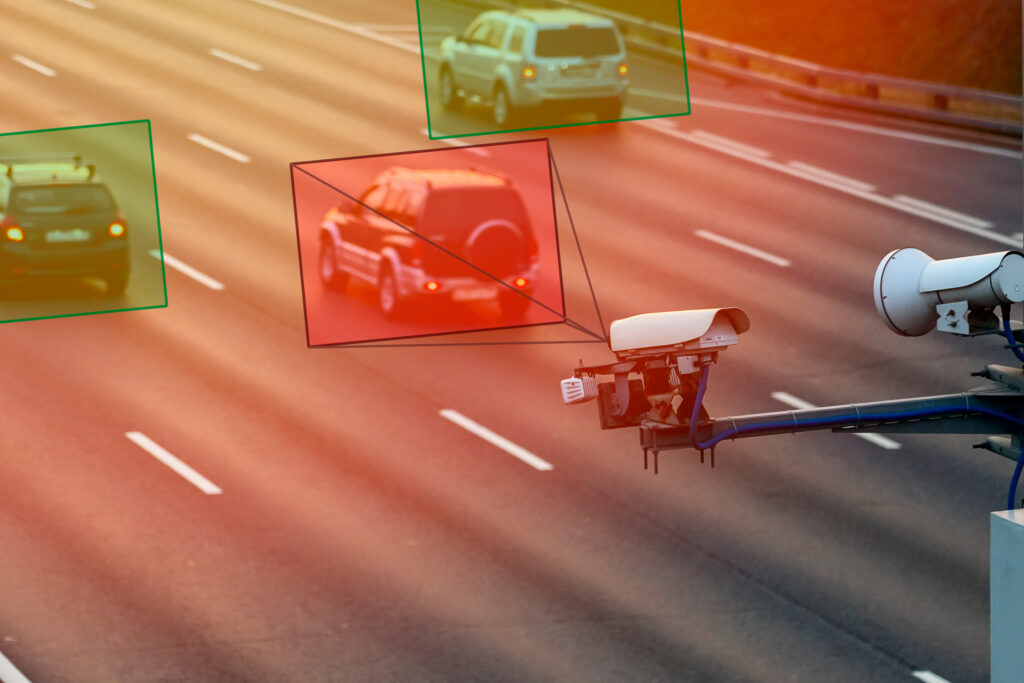Responsabilità della Pubblica Amministrazione Responsabilità della pubblica amministrazione: principi, tipologie, conseguenze giuridiche e riparto di giurisdizionale
Responsabilità della pubblica amministrazione
La responsabilità della pubblica amministrazione è un concetto giuridico fondamentale per garantire legalità, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa. Essa rappresenta l’obbligo dell’amministrazione di rispondere delle proprie condotte illecite o dannose sotto il profilo civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare.
Il principio di responsabilità della pubblica amministrazione
Alla base dell’ordinamento democratico e dello Stato di diritto vi è il principio secondo cui anche la Pubblica Amministrazione (PA) è soggetta alla legge e deve rispondere delle conseguenze derivanti dalla propria attività.
Tale principio trova fondamento:
- nell’art. 28 della Costituzione italiana, secondo cui i funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili, civilmente, penalmente e amministrativamente, degli atti compiuti in violazione dei diritti;
- nell’art. 2043 del codice civile, che stabilisce il generale principio di responsabilità aquiliana (extracontrattuale);
- nel principio di buona amministrazione sancito dall’art. 97 Costituzione;
- nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.
La responsabilità della PA può derivare sia da atti illegittimi che da omissioni, e può essere azionata dai cittadini, dalle imprese e da altri enti che abbiano subito un danno ingiusto.
Responsabilità civile della pubblica amministrazione
La responsabilità civile può essere di due tipi:
1. Responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.)
È il caso più frequente: si verifica quando l’attività illegittima della PA provoca un danno ingiusto a un soggetto, lesivo di un interesse tutelato dall’ordinamento. Per configurarsi, devono sussistere tre presupposti:
- condotta illecita della PA o del suo agente;
- danno ingiusto subito dal privato;
- nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Un esempio classico è la responsabilità da ritardo nell’emissione di provvedimenti amministrativi o da mancata esecuzione di sentenze.
2. Responsabilità contrattuale (es. in caso di appalti o convenzioni)
Meno frequente, ma può insorgere quando la PA stipula contratti con soggetti privati e non adempie correttamente agli obblighi assunti, incorrendo così nella responsabilità da inadempimento.
Responsabilità penale della pubblica amministrazione
I funzionari pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni, possono incorrere in responsabilità penale nei casi previsti dal codice penale e da leggi speciali. I principali reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale.
Tra i reati più rilevanti si segnalano:
- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
È importante sottolineare che, in ambito penale, la responsabilità non è mai collettiva, ma personale: ricade sul singolo funzionario che ha tenuto la condotta illecita, anche se in rappresentanza della PA.
Responsabilità amministrativo-contabile
È la forma di responsabilità peculiare dei dipendenti e funzionari pubblici quando recano un danno erariale al patrimonio pubblico con dolo o colpa grave.
Rientrano in questa categoria:
- l’indebito pagamento di somme;
- l’acquisto di beni o servizi a prezzi maggiorati;
- l’omessa riscossione di crediti pubblici;
- la mancata vigilanza che comporta un danno alle finanze pubbliche.
Questa responsabilità è personale e patrimoniale, è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, e può comportare l’obbligo di risarcimento del danno all’erario.
Responsabilità disciplinare
Oltre alle responsabilità civile, penale e contabile, i dipendenti pubblici sono soggetti anche a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri d’ufficio, secondo quanto previsto dai codici di comportamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del pubblico impiego.
Le sanzioni disciplinari possono variare:
- dal richiamo scritto alla sospensione,
- fino al licenziamento per giusta causa.
Il principio dell’autoresponsabilità
La giurisprudenza ha sviluppato il principio secondo cui la PA risponde in giudizio come qualsiasi altro soggetto giuridico, senza privilegi o immunità particolari, in ossequio al principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione.).
Competenza dei giudici nella azioni di responsabilità
Semplificando all’estremo, le azioni risarcitorie nei confronti della PA vengono proposte:
- dinanzi al giudice ordinario, quando il privato stato leso in suo diritto soggettivo. Un esempio tipico di lesione di diritto soggettivo si verifica quando un soggetto viene leso nell’affidamento riposto nell’attendibilità di una attestazione della PA sull’edificabilità di un’area, che poi si rivela erronea;
- dinanzi al giudice amministrativo (TAR), quando il danno deriva dalla lesione di interessi legittimi nelle materie affidate a questa autorità giudiziaria in via esclusiva. La nota sentenza della Cassazione n. 500/1999 ha chiarito però che affinché vi sia tutela risarcitoria la lesione dell’interesse legittimo non è sufficiente, è necessaria la lesione del bene della vita collegato all’interesse legittimo.
Leggi anche gli altri articoli dedicati alla pubblica amministrazione