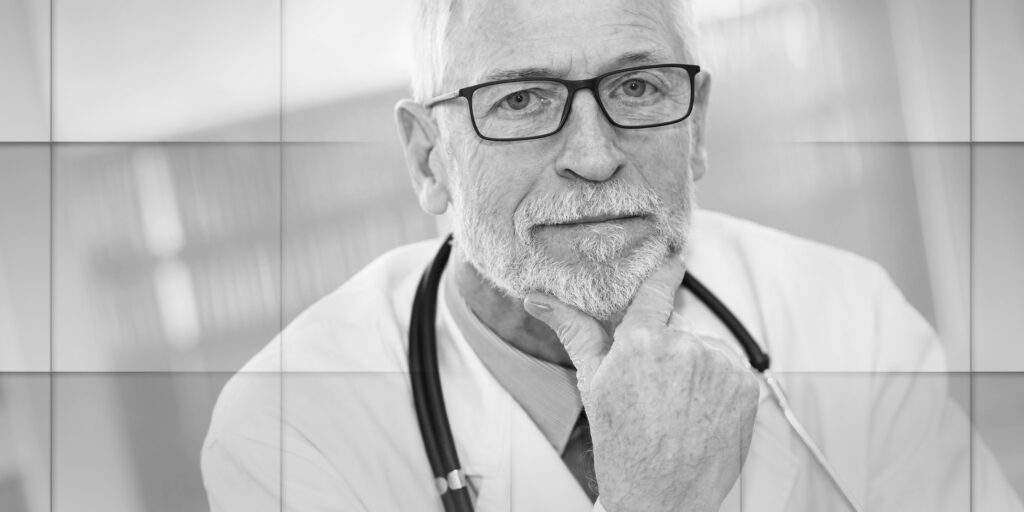Polizze catastrofali: cosa sono
Le polizze catastrofali sono polizze assicurative che la legge di bilancio 2024 (n. 213/2023) ha reso obbligatorie per tutte le imprese che hanno la sede legale in Italia, per proteggerle da eventi catastrofici e calamità naturali (Cat Nat). La normativa è conseguente ai fenomeni climatici che negli ultimi anni si sono abbattuti sul territorio italiano con ripercussioni negative anche sulle attività economiche e produttive.
Il decreto attuativo, DM n. 18 del 30 gennaio 2025 ha dettato le modalità di attuazione e di operatività degli schemi assicurativi dei rischi catastrofali.
Polizze catastrofali: il termine del 31 marzo 2025
L’articolo 1 comma 101 e successivi della legge di bilancio n. 213/2023 aveva stabilito l’obbligo di adeguamento al 31 dicembre 2024.
Il decreto Milleproroghe ha rinviato però tale obbligo al 31 marzo 2025.
Rinvio per medie, piccole e micro imprese
Il Senato il 21 maggio 2025 con 78 voti a favore, nessuno contrario e 53 astenuti ha approvato in via definitiva il “ddl di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.” Il testo della nuova legge n. 78/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 31 maggio 2025.
Fatta questa necessaria premessa, che cosa stabilisce il testo definitivo? Chi e quando deve sottoscrivere le polizze catastrofali?
Imprese obbligate e termini per la stipula
Le grandi imprese, con più di 250 dipendenti, devono stipulare dette polizze entro il termine del 30 giugno 2025, anche se l’obbligo è in vigore dal 31 marzo 2025. Il decreto infatti ha previsto per queste imprese un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per permettere alle aziende prive di contratto di adeguarsi.
Le medie imprese con un minimo di 50 dipendenti fino a un massimo di 250, hanno invece altri sei mesi di tempo, ossia fino al 1° ottobre 2025, per stipulare i contratti assicurativi.
Per le micro e piccole imprese l’obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.
La mancata stipula comporterà il mancato accesso a incentivi statali e risorse pubbliche per sviluppare l’attività. Le imprese che intendono chiedere determinati aiuti dovranno infatti dimostrare di essere in regola con la stipula.
Obbligo assicurativo: eccezioni
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli immobili che non possono essere assicurati perchè:
- costruiti o ampliati in assenza di un titolo edilizio valido o ultimati quando il titolo non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o con procedimento di sanatoria o condono in corso.
Indennizzo assicurativo
L’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale spetta al proprietario dell’immobile se l’imprenditore assicura beni di proprietà altrui impiegati per l’attività di impresa, comunicando al proprietario la stipula della polizza. L’indennizzo, una volta corrisposto, deve essere impiegato solo per ripristinare i beni danneggiati. Se questa regola non viene rispettata all’imprenditore spetta comunque una somma per la riparazione del lucro cessante nel limite del 40% dell’indennizzo massimo indennizzabile.
Polizze catastrofali: le faq del MIMIT
Sul sito Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sono presenti le FAQ sulle polizze assicurative contro eventi catastrofali. Le risposte chiariscono aspetti essenziali in merito all’obbligo assicurativo per le imprese e agli effetti sull’accesso ai benefici pubblici.
Obbligo assicurativo e incentivi pubblici
Il Ministero precisa che la norma relativa all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro calamità naturali – prevista dall’art. 1, comma 102 della Legge n. 213/2023 – non è immediatamente applicabile in modo automatico. Infatti, la disposizione stabilisce che la mancata sottoscrizione della polizza deve essere tenuta in considerazione nella concessione di contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche, ma non ne definisce in modo vincolante gli effetti.
Questo significa che l’inadempimento all’obbligo assicurativo non comporta automaticamente l’esclusione dai benefici pubblici, ma richiede un’espressa valutazione da parte dell’ente erogatore, secondo i criteri stabiliti nei singoli provvedimenti attuativi.
Nessuna retroattività della norma
Il MIMIT chiarisce inoltre che la disciplina in questione non ha efficacia retroattiva. Pertanto, l’obbligo assicurativo e le eventuali conseguenze sulla concessione di agevolazioni pubbliche si applicano solo a partire dalla data di recepimento della norma da parte delle specifiche misure di incentivazione o dalle eventuali diverse decorrenze indicate nei relativi atti.
Polizze catastrofali: incentivi per chi si adegua all’obbligo
Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025, di cui è stato dato avviso il 28 luglio 2025, si subordinano tutta una serie di incentivi e di agevolazioni all’adempimento dell’obbligo assicurativo “fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo.”
La disciplina riguarda sia le imprese che hanno la sede legale nel territorio italiano che quelle che hanno la sede legale all’estero, ma che hanno in Italia un’organizzazione stabile e che sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.
Nel rispetto delle scadenze previste per adempiere l’obbligo assicurativo, ossia il 30 giugno 2025 per le grandi imprese, il 1° ottobre 2025 per le medie imprese e il 31 dicembre 2025 per le piccole imprese, il decreto stabilisce che le disposizioni si applicheranno alle domande per gli incentivi che verranno presentate rispettivamente a partire dal 30 giugno, dal 2 ottobre e dal 1° gennaio 2026.
Il comma 3 dell’articolo 1 precisa che l’obbligo assicurativo deve sussistere anche in sede di erogazione degli incentivi elencati nel successivo comma 4.
Per fornire importanti chiarimenti relativi all’applicazione della disciplina prevista dal decreto il MIMIT interviene con un avviso del 5 agosto 2025.
In esso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che il decreto si riferisce solo alle agevolazioni che sono di competenza della Direzione Generale regolamentati dai decreti del solo Ministero. L’elenco dei vari incentivi previsti dal decreto quindi non è tassativo, presto infatti la disciplina sarà adeguata agli altri incentivi sempre di competenza della Direzione, ma definiti insieme ad altri Ministeri.