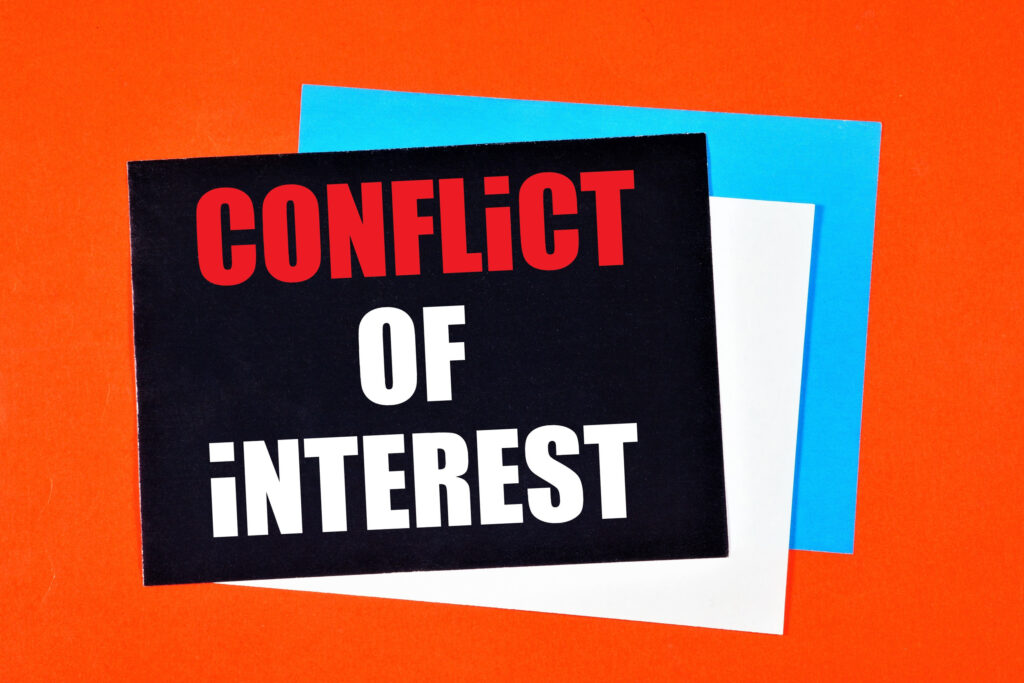Interessi moratori avvocati: da quando decorrono La Cassazione chiarisce che gli interessi moratori per i crediti professionali degli avvocati decorrono dalla messa in mora, anche stragiudiziale, e non dalla liquidazione del credito
Decorrenza interessi moratori nei crediti professionali
Con l’ordinanza n. 19421/2025, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di crediti professionali maturati dagli avvocati: gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1224 del codice civile, decorrono dalla messa in mora del debitore, che può coincidere sia con la proposizione della domanda giudiziale sia con una richiesta stragiudiziale di adempimento.
Tale principio si applica anche qualora la liquidazione del compenso professionale avvenga nell’ambito del procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte
Nel caso esaminato, due avvocati avevano prestato assistenza legale a favore di una società, successivamente condannata dal Tribunale di Bergamo – in contumacia – al pagamento della somma di € 10.248,99, oltre interessi legali dalla data della domanda e spese processuali.
I professionisti hanno impugnato la decisione, contestando l’erronea applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori, e la decorrenza di tali interessi dalla domanda giudiziale, anziché dalla messa in mora avvenuta mediante più atti stragiudiziali.
Applicabilità del d.lgs. 231/2002 ai compensi forensi
La Corte, accogliendo il ricorso dei legali sul punto, ha affermato che la disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2002 in tema di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale. Tuttavia, per il riconoscimento degli interessi moratori è necessario che il ritardo non sia giustificato da una causa non imputabile al debitore, come previsto dall’art. 3 dello stesso decreto.
Ne deriva che la liquidazione del credito da parte del giudice non incide sulla decorrenza della mora, né può escluderla in caso di liquidazione in misura inferiore a quanto richiesto. Pertanto, gli interessi moratori decorrono dalla domanda, anche se la somma riconosciuta è diversa da quella originariamente domandata, purché sussista una condotta dilatoria ingiustificata.
La necessità dell’atto di costituzione in mora
La Corte ha invece rigettato la doglianza relativa alla mancata rivalutazione del credito. Le ricorrenti sostenevano che, in assenza di contestazioni sulla parcella, gli interessi e la rivalutazione monetaria dovessero maturare automaticamente dalla scadenza del pagamento.
Secondo la Cassazione, la mora non sorge automaticamente, nemmeno in presenza di crediti illiquidi. È necessario un atto formale di costituzione in mora, i cui effetti si producono solo per la parte di credito riconosciuta o accertata. Il principio romanistico in illiquidis non fit mora è superato solo quando il debitore, pur in presenza di un credito non determinato nel quantum, sia in grado di compierne una stima.
Condotta colpevole e interessi moratori
La Corte richiama il proprio orientamento consolidato (Cass. n. 24973/2022), secondo cui la mora del debitore può configurarsi anche in presenza di un credito illiquido, qualora il debitore abbia la possibilità di stimarne l’entità sulla base di tariffe professionali e attività chiaramente documentate.
Pertanto, l’ingiustificata contestazione del credito o una condotta dilatoria possono integrare una colpa rilevante ai fini dell’applicazione degli interessi moratori. In questi casi, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, ma limitatamente alla parte del credito non contestata o accertata con sentenza.
Conclusioni operative per gli avvocati
L’ordinanza n. 19421/2024 conferma che, per ottenere gli interessi moratori nei crediti professionali, è indispensabile procedere alla costituzione in mora del debitore, anche a mezzo di diffida stragiudiziale. La liquidazione giudiziale non esclude la mora, che si radica nella condotta colpevole del debitore.
È pertanto opportuno, nella gestione dei crediti professionali, formalizzare tempestivamente la richiesta di pagamento tramite diffide scritte, in modo da far decorrere gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, anche prima dell’introduzione del giudizio.