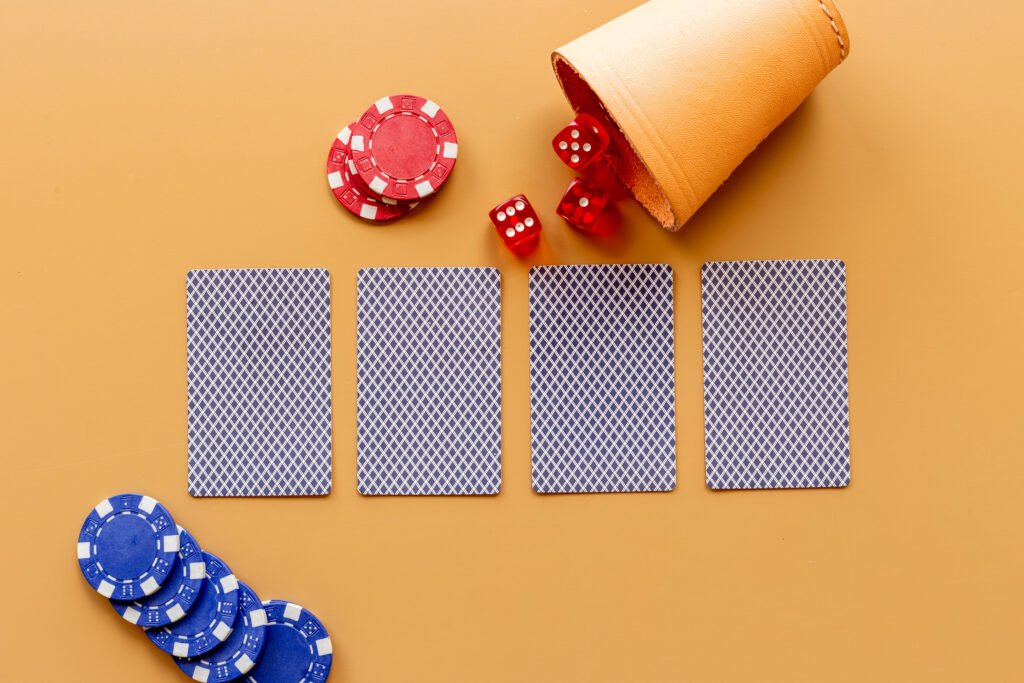Oltraggio a pubblico ufficiale Oltraggio a pubblico ufficiale: cos’è, cosa prevede l’art. 341-bis c.p., quando si configura, aspetti procedurali e giurisprudenza
Cos’è l’oltraggio a pubblico ufficiale
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato previsto e punito dall’articolo 341-bis del Codice penale, introdotto per rafforzare la tutela della dignità e dell’autorevolezza degli appartenenti alla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. La norma punisce chiunque, con offese o insulti, manifesti pubblicamente disprezzo nei confronti di un pubblico ufficiale, ledendo il prestigio delle istituzioni.
Normativa di riferimento: art. 341-bis c.p.
L’art. 341-bis c.p. dispone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa è commessa con violenza o minaccia.”
Il reato è stato reintrodotto nel 2009 con la legge n. 94/2009 “pacchetto sicurezza”, dopo essere stato abrogato nel 1999. La sua finalità consiste nel tutelare il rispetto delle istituzioni attraverso la protezione dell’onore e del prestigio dei pubblici ufficiali.
Quando si configura il reato
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si configura quando sussistono contemporaneamente i determinati elementi, analizziamoli uno per uno.
Offesa all’onore o al prestigio: l’offesa può avvenire con parole, gesti, espressioni o atteggiamenti che umiliano il pubblico ufficiale.
Il reato deve essere commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico: l’atto deve avvenire in uno spazio accessibile a più persone (strade, piazze, uffici pubblici).
La condotta criminosa deve realizzarsi alla presenza di più persone: l’offesa cioè deve essere pubblica, ossia compresa da almeno due persone oltre il pubblico ufficiale.
L’illecito penale deve verificarsi durante o a causa delle funzioni pubbliche: il pubblico ufficiale deve essere nell’esercizio delle sue funzioni o l’offesa deve derivare proprio dal suo ruolo.
Qualche esempio concreto di condotte che integrano il reato:
- insultare un agente di polizia durante un controllo stradale;
- offendere un medico del pronto soccorso mentre presta assistenza pubblica;
- minacciare un vigile urbano nel momento in cui sta elevando una multa.
Elemento oggettivo e soggettivo del reato
L’elemento oggettivo, ossia la condotta materiale del reato deve consistere in espressioni offensive, ingiuriose o minacciose rivolte direttamente al pubblico ufficiale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone oltre all’offeso.
L’elemento soggettivo, ossia l’intenzione del colpevole deve tradursi in un dolo generico, il soggetto deve avere cioè la consapevolezza e la volontà di offendere il prestigio del pubblico ufficiale. Non è necessario che vi sia un intento specifico di umiliare la persona, basta che l’atto sia volontario e cosciente.
Chi è il pubblico ufficiale secondo il Codice Penale
Per comprendere la qualifica della persona offesa di questo reato occorre comprendere chi è il pubblico ufficiale. A questo proposito è di aiuto la definizione fornita dall’articolo art. 357 c.p.. Questa norma definisce il pubblico ufficiale come il soggetto che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa o di certificazione o attestazione pubblica.
Sono pubblici ufficiali gli agenti di polizia, i carabinieri, i vigili urbani, gli insegnanti pubblici, i medici ospedalieri, i magistrati e i vigili del fuoco.
Procedibilità reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è procedibile d’ufficio, esso non necessita di querela per essere perseguito ed è di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Pene previste per l’oltraggio a pubblico ufficiale
L’art. 341-bis c.p. prevede:
La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. L’aumento di pena è previsto nei seguenti casi:
- se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola;
- se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Il reato è estinto se prima della giudizio l’imputato ripara il danno per intero risarcendo il soggetto o l’ente a cui lo stesso appartiene.
Giurisprudenza su oltraggio a pubblico ufficiale
Riportiamo alcuni stralci di sentenze che si sono occupate del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui hanno precisato alcuni e importanti aspetti:
Cassazione n. 3079/2025: La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, modificandone la condotta tipica. Pur mantenendo il legame tra l’offesa e le funzioni del pubblico ufficiale, ha richiesto che l’ingiuria offenda sia l’onore che il prestigio del soggetto e che avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, alla presenza di più persone. Questo requisito, prima considerato un’aggravante, è ora un elemento essenziale del reato (art. 341-bis c.p.). L’offesa deve ledere sia la dignità personale del pubblico ufficiale che la sua considerazione sociale, giustificando così una tutela rafforzata rispetto ai cittadini comuni, poiché danneggia anche la reputazione della Pubblica Amministrazione. Inoltre, affinché il reato sussista, è sufficiente che l’ingiuria possa essere udita dai presenti, in quanto ciò genera un disagio psicologico che può compromettere l’operato del funzionario.
Cassazione n. 33020/2024: Nel reato di oltraggio, l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire davanti ad almeno due persone, escluse quelle che assistono nell’ambito delle loro funzioni. Il requisito della pluralità di persone è soddisfatto solo dalla presenza di civili o di pubblici ufficiali che si trovino nel contesto per ragioni diverse da quelle legate all’atto d’ufficio in cui si verifica l’offesa.
Cassazione n. 211/2023: La legge tutela l’onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione non solo quando l’offesa è diretta al singolo pubblico ufficiale, ma anche quando l’offesa può essere percepita da altri pubblici ufficiali presenti che in quel momento svolgono funzioni diverse da quelle della persona offesa. La condotta dell’agente, in questi casi, compromette la prestazione del PU perché disturbato da una situazione sfavorevole.
Differenza tra oltraggio, ingiuria e diffamazione
| Reato | Articolo c.p. | Dove avviene | Chi è l’offeso | Procedibilità |
| Oltraggio a pubblico ufficiale | 341-bis c.p. | Luogo pubblico, davanti a più persone | Pubblico ufficiale | D’ufficio |
| Ingiuria (depenalizzata) | Art. 594 c.p. (depenalizzato) | In presenza della persona offesa | Privato | Sanzione civile |
| Diffamazione | 595 c.p. | Assente la persona offesa | Chiunque | Su querela |
Leggi anche: Avvocati: oltraggio alla corte e libertà di espressione