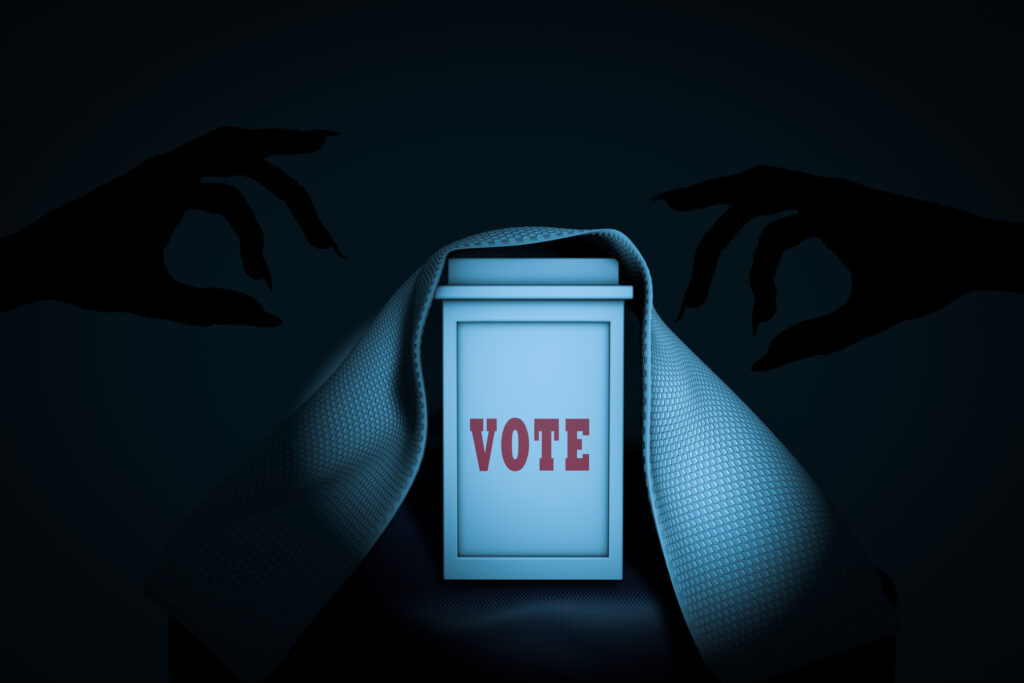Continuazione tra reati: la Cassazione chiarisce il concetto di disegno criminoso La Cassazione ha stabilito che la continuazione tra reati richiede un programma criminoso unitario previamente ideato, e non si identifica con uno stile di vita incline al reato
Continuazione tra reati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29855/2025, è intervenuta sul tema della continuazione tra reati e, in particolare, sull’interpretazione del requisito dell’identità del disegno criminoso previsto dall’articolo 81, comma 2, del Codice penale.
Il Supremo Collegio ha precisato che non è sufficiente la mera reiterazione di condotte illecite per riconoscere la continuazione, ma occorre la prova di un programma criminoso unitario, previamente concepito e voluto dall’autore.
I fatti
Il procedimento riguardava un imputato condannato per una serie di reati commessi in un arco temporale relativamente breve. La difesa aveva invocato l’applicazione del vincolo della continuazione, sostenendo che le condotte fossero espressione di un medesimo disegno criminoso.
I giudici di merito avevano negato la sussistenza della continuazione, rilevando che i reati erano stati commessi in circostanze eterogenee e non riconducibili a un piano unitario. La questione è stata quindi sottoposta al vaglio della Cassazione.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che:
-
l’identità del disegno criminoso implica un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, volto alla realizzazione di più reati;
-
non è sufficiente dimostrare che l’autore abbia una personalità o uno stile di vita incline a delinquere;
-
la continuazione non può essere riconosciuta quando le singole condotte siano frutto di decisioni autonome e indipendenti, assunte di volta in volta senza un progetto unitario.
In tal senso, la Cassazione ha confermato l’orientamento restrittivo volto a circoscrivere l’applicazione dell’istituto.
Il quadro normativo
L’articolo 81, comma 2, cp disciplina la continuazione, stabilendo che chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette più violazioni della legge penale soggiace alla pena prevista per la violazione più grave, aumentata.
La ratio dell’istituto è di natura sia sanzionatoria (attenuare il cumulo delle pene per più reati) sia ricostruttiva (valutare l’unitarietà del disegno criminoso come elemento soggettivo che lega le diverse condotte). Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria richiede una rigorosa verifica dell’esistenza del programma criminoso unitario.