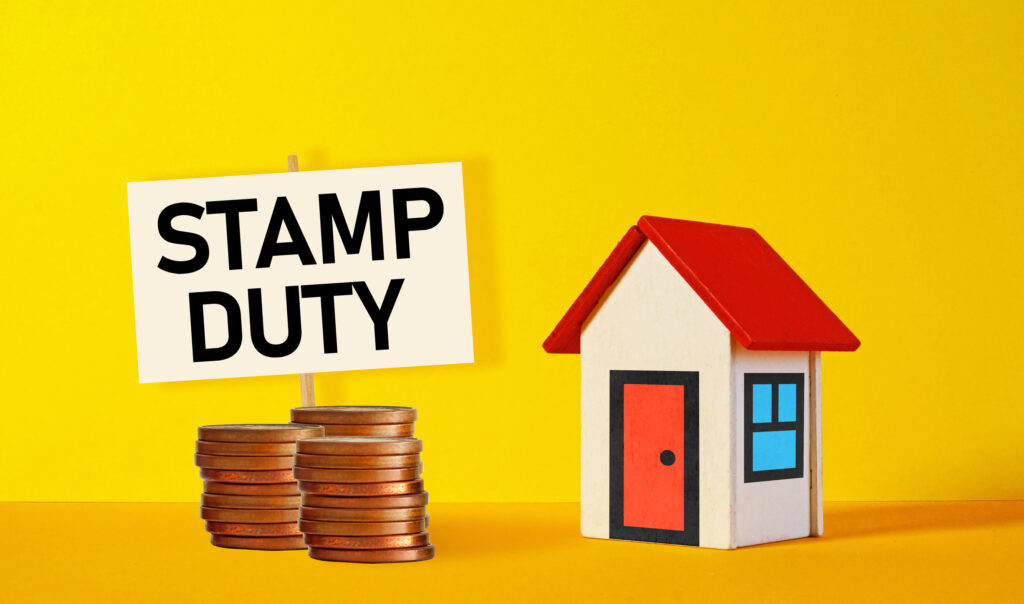PNRR Scuola: legge in vigore PNRR scuola: in vigore dal 7 giugno la legge che prevede, tra le varie misure, un bonus per favorire l’assunzione dei ricercatori
PNRR Scuola: in vigore la legge
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025 la legge n. 79/2025 PNRR Scuola di conversione del decreto n. 45/2025.
La legge in vigore dal 7 giugno 2025 si occupa di argomenti piuttosto eterogenei.
Le misure per la scuola
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica il provvedimento stanzia nuovi fondi per la costruzioni di nuovi edifici, e la messa in sicurezza di quelli esistenti. Si assisterà a una vera e propria riforma degli istituti tecnici. La legge introduce nuovi indirizzi e orari. Aumentano gli stanziamenti per i libri di testo. La carta del docente dal prossimo anno scolastico 2025-2026 avrà un importo massimo annuale di 500 euro. Gli esercenti avranno 90 giorni di tempo dalla validazione del buono per inviare le fatture. Scaduto il termine perderanno il diritto al rimborso.
Da menzionare anche le novità che riguardano la professione di guida turistica, il sistema di reclutamento del personale scolastico, la riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, la rimodulazione delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione e la mobilitazione straordinaria dei dirigenti scolastici
Bonus assunzione ricercatori 2025
Una delle misure più interessanti da segnalare però, è senza dubbio la misura finalizzata a favorire l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese italiane.
L’articolo 3 septies, contenente disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese, prevede un credito di imposta di 10.000 euro per ogni ricercatore assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.
Questa norma va a modificare l’articolo 26 del DL n. 13/2023, che contiene disposizioni urgenti per attuare il PNRR e il PNC, al fine di perseguire gli obiettivi dell’investimento 3.3, Missione 4, componente 2 PNRR.
La disposizione va a modificare in particolare i commi 1, 2, 3 prevedendo alcune e importanti novità. La prima novità è rappresentata appunto dal bonus di 10.000 euro. Novità questa contenuta nel comma 1, che comporta l’abrogazione del comma 2 che prevedeva invece l’esonero dal versamento dei contributi.
La modifiche del comma 3 invece comportano la soppressione del concerto tra il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il decreto attuativo delle predette disposizioni e il periodo di riferimento del limite di spesa di 150 milioni di euro, che ora va dal 1° luglio 2025 fino al 31 dicembre 2026.
Leggi tutti gli articoli dedicati ai bonus