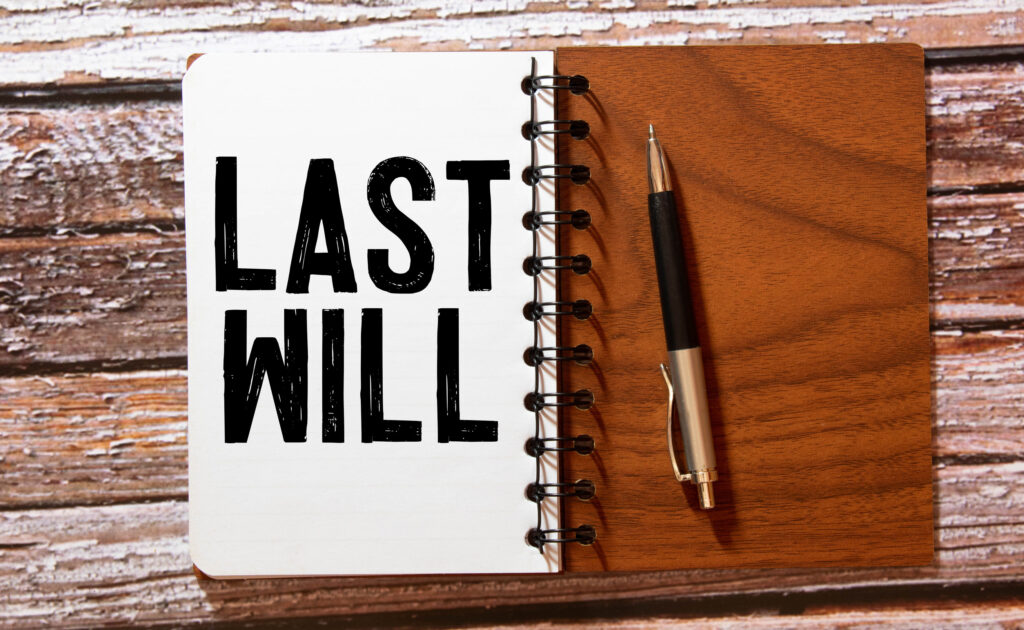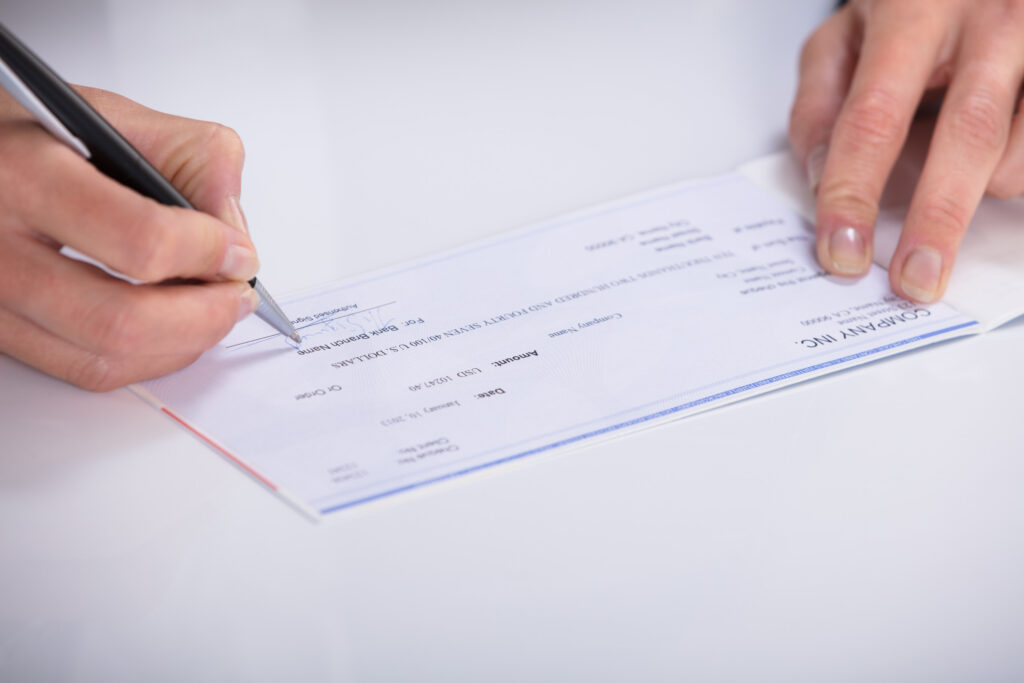Ok a 5 referendum
Via libera della Corte costituzionale a 5 referendum in materia di cittadinanza, Jobs Act, indennità licenziamenti illegittimi, contratti di lavoro a termine e responsabilità dell’imprenditore committente. Unico no al referendum sull’autonomia differenziata che, con la sentenza n. 10/2025 è stato dichiarato inammissibile.
Referendum cittadinanza
La richiesta referendaria in materia di cittadinanza ritenuta ammissibile è diretta ad abrogare, congiuntamente, l’intero articolo 9, comma 1, lettera f), della legge numero 91 del 1992 e, limitatamente ad alcune parole, l’articolo 9, comma 1, lettera b).
La combinazione delle due diverse abrogazioni avrebbe quale esito che tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea potrebbero presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza legale in Italia.
La Corte Costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 11/2025, che il quesito è omogeneo, chiaro e univoco. “All’elettore, infatti, è proposta una scelta facilmente intellegibile in ordine agli anni di residenza nel territorio della Repubblica necessari, per il maggiorenne cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, per poter presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana: dieci, come attualmente previsto, o cinque, come eventualmente disporrebbe la legge in caso di approvazione del referendum abrogativo”.
La richiesta referendaria non contraddice neppure la natura abrogativa del referendum, che la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto non può essere utilizzato per costruire, attraverso il quesito, nuove norme non ricavabili dall’ordinamento. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la nuova regola non sarebbe del tutto estranea al contesto normativo di riferimento. In caso di approvazione del referendum abrogativo, infatti, verrebbe a essere modificato esclusivamente il tempo di residenza legale necessario per poter presentare la domanda di cittadinanza – pari a cinque anni – restando invece fermi i soggetti che potranno fare la richiesta, i restanti requisiti per presentarla (la residenza nel territorio della Repubblica e l’adeguata conoscenza della lingua italiana), nonché la natura di atto discrezionale di “alta amministrazione” del provvedimento di concessione della cittadinanza.
Referendum Jobs Act
È ammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione del decreto delegato attuativo del Jobs Act n. 23/2015 in tema di licenziamenti illegittimi. La Corte costituzionale con la sentenza numero 12 del 2025 ha precisato: la «circostanza che all’esito dell’approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe in realtà in tutte le ipotesi di invalidità» del licenziamento, perché per alcune di queste (e in particolare nel caso del licenziamento intimato al lavoratore assente per malattia o infortunio, oppure intimato per disabilità fisica o psichica a un lavoratore che non versava in realtà in tale condizione) «si avrebbe, invece, un arretramento di tutela», non inficia la chiarezza, l’omogeneità e l’univocità della richiesta di referendum. Il quesito referendario chiama, infatti, il corpo elettorale «a una valutazione complessiva e generale, che può anche prescindere dalle specifiche e differenti disposizioni normative, senza perdere la propria matrice unitaria». Questa è ravvisabile, ha evidenziato la Consulta, «nel profilo teleologico sotteso al quesito referendario, mirante all’abrogazione di un corpus organico di norme e funzionale alla reductio ad unum, senza più la divisione tra prima e dopo la data del 7 marzo 2015, della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, con la riespansione della disciplina pregressa, valevole per tutti i dipendenti», a prescindere dalla data della loro assunzione. Rimane, pertanto, salvaguardato, ha concluso la Corte, «un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario», ciò che esclude che si sia in presenza di «un uso artificioso del referendum abrogativo».
Referendum indennità da licenziamento illegittimo
Ammissibile, inoltre, il referendum sulla misura massima dell’indennità da licenziamento illegittimo.
Con la sentenza n. 13/2025, la Consulta ha dichiarato l’ammissibilità del referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 8 della legge numero 604 del 1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo.
In motivazione, la Corte ha precisato che la norma oggetto del quesito referendario trova oggi applicazione, a seguito delle modifiche intervenute nella legislazione in materia, nei confronti dei soli lavoratori assunti alle dipendenze delle cosiddette “piccole imprese” (ossia, presso datori di lavoro che non raggiungono la soglia dimensionale indicata dall’articolo 18, ottavo comma, dello Statuto dei lavoratori) prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 23 del 2015, attuativo della legge sul Jobs act.
A parere della Corte, il quesito in esame non incontra i limiti di cui all’articolo 75 della Costituzione e risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, in quanto pone una chiara alternativa all’elettore: mantenere l’attuale misura massima dell’indennità, ovvero rimuoverla per consentire al giudice di quantificare, senza più tale ostacolo, un ristoro equo con congruo effetto deterrente.
Referendum contratti di lavoro a termine
Con la sentenza n. 14/2025, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato ammissibile la richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi».
Il quesito referendario riguarda l’abrogazione di alcune previsioni (articoli 19, commi 1, 1-bis e 4, e 21, comma 01, del decreto legislativo numero 81 del 2015) che attualmente consentono la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (e anche la loro proroga e/o il rinnovo) fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione, e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti, anche se non prevista né dalla legge, né dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale. Le norme oggetto del quesito non rientrano fra le leggi per cui la Costituzione, all’articolo 75, esclude che si possa richiedere referendum abrogativo. Il quesito, inoltre, soddisfa tutti i requisiti (di chiarezza, omogeneità, univocità) richiesti per consentire all’elettore di esercitare una scelta libera e consapevole. Esso, infatti, è formulato nei termini di un’alternativa secca: da un lato, abrogare le disposizioni vigenti, con conseguente estensione ai rapporti di lavoro di durata infrannuale dell’obbligo di giustificazione dell’apposizione del termine oggi sussistente per la stipulazione di contratti di lavoro di durata superiore all’anno e il necessario riferimento, per tutti i contratti a termine, alle sole cause giustificative previste dalla legge o dai contratti collettivi; dall’altro, conservare la normativa vigente, che, all’opposto, ne liberalizza l’impiego.
Referendum responsabilità imprenditore committente
Infine, con la sentenza numero 15/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», dichiarata conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024.
La Corte ha osservato che la norma oggetto del quesito non interferisce con le materie per le quali l’articolo 75, secondo comma, della Costituzione preclude il ricorso all’istituto del referendum abrogativo.
Il quesito rispetta i requisiti di chiarezza e semplicità, essenziali per garantire il popolo nell’esercizio del suo potere sovrano.
Dalla formulazione del quesito si evince in modo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità dell’imprenditore committente. “Il quesito tende a un esito lineare e pone al corpo elettorale un’alternativa netta: «il mantenimento dell’attuale assetto della responsabilità solidale, contraddistinto da deroghe significative, o l’integrale riespansione di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici»”. È dunque garantita, conclude la Consulta, “quella scelta chiara e consapevole, che il giudizio di ammissibilità demandato alla Corte costituzionale è chiamato a salvaguardare”.