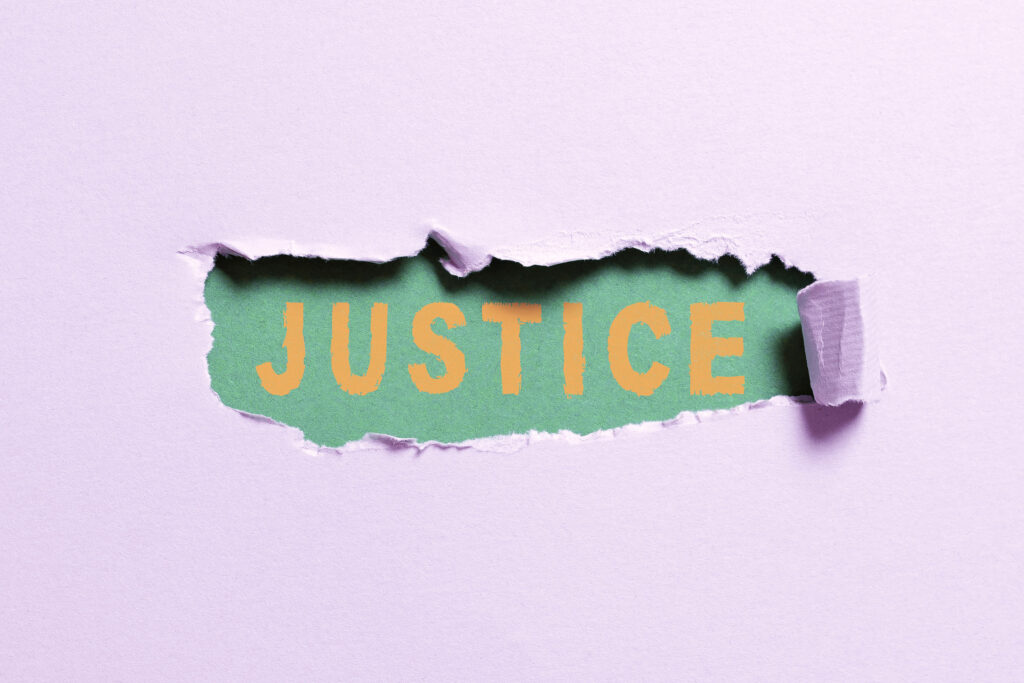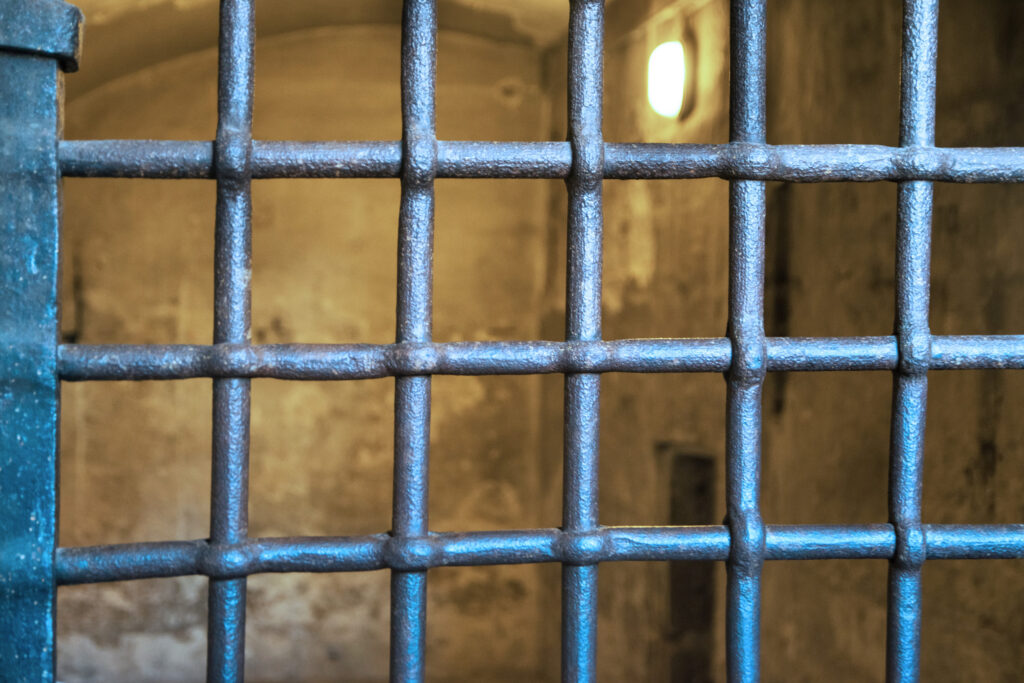Sequestro di persona: cos’è
L’articolo 605 del Codice Penale regola il sequestro di persona, un crimine che difende la libertà personale. La Costituzione, all’articolo 13, garantisce la libertà di movimento e spostamento come un diritto inviolabile. Solo lo Stato, attraverso i suoi organi giurisdizionali, può legittimamente limitare questa libertà fondamentale.
Condotta del sequestro di persona
Il reato di sequestro di persona si concretizza quando qualcuno priva o restringe illegittimamente la libertà fisica di un individuo. La condotta tipica comprende azioni che tolgono a una persona la sua libertà personale, sia in modo commissivo (per esempio, chiudendo qualcuno in una stanza) sia in modo omissivo (per esempio, non rilasciando un soggetto e prolungandone la detenzione).
È cruciale che la condotta sia illegittima, ovvero non autorizzata dalla legge o da una causa di giustificazione (come un arresto legale o l’esercizio di un dovere professionale). L’errore sulla legittimità dell’azione può scusare, come previsto dall’articolo 47 del codice penale, purché l’azione non costituisca un altro reato. Il consenso della persona offesa (articolo 50 del codice penale) può escludere l’illiceità della condotta.
Natura del reato
Il sequestro di persona è un reato permanente: la condotta deve protrarsi per un periodo di tempo apprezzabile per configurare il crimine. Il reato si consuma nel momento in cui la libertà personale viene privata per un tempo sufficiente a superare la soglia di offensività. Per la sua configurazione, la vittima non deve poter riacquistare autonomamente la libertà in modo immediato, facile e senza rischi, anche se non tenta attivamente di farlo. È sempre ammesso il tentativo di sequestro.
Elemento soggettivo del sequestro di persona
Il reato richiede l’elemento soggettivo del dolo generico. Il soggetto agente deve avere cioè la coscienza e la volontà di privare o restringere la libertà personale del soggetto passivo. La Cassazione, con la sentenza n. 10357/2025, lo ha confermato stabilendo che l’autore del reato deve essere consapevole di privare illegittimamente la vittima della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento.
Attenzione però, perchè il fine specifico del soggetto agente può cambiare la qualificazione del reato. Se il sequestro infatti è finalizzato all’ottenimento di un riscatto, si configura il sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), un reato autonomo.
Pena base e circostanze aggravanti
La pena per il sequestro di persona prevede la reclusione da sei mesi a otto anni. Tuttavia, la sussistenza di diverse circostanze aggravanti specifiche aumentano la pena.
- La pena sale infatti da uno a dieci anni di reclusione se il fatto viene commesso a danno di un ascendente, un discendente o il coniuge.
- La stessa pena si applica se un pubblico ufficiale commette il sequestro abusando dei suoi poteri.
- Se il fatto è commesso a danno di un minore, la pena va da tre a dodici anni di reclusione.
- La pena è la detenzione da tre a quindici anni se il fatto è commesso in presenza delle circostanze precedenti (parenti stretti o pubblico ufficiale) o in danno di un minore di anni quattordici, oppure se il minore sequestrato viene portato o trattenuto in un paese estero.
- Se il colpevole provoca la morte del minore sequestrato, la pena da applicare è l’ergastolo.
Circostanze attenuanti
L’articolo 605 prevede anche una circostanza attenuante specifica basata sul “ravvedimento operoso” da parte dell’autore del delitto. Le pene previste per il sequestro di minore (terzo comma) possono diminuire fino alla metà se l’imputato si adopera concretamente per:
- far riacquistare la libertà al minore;
- evitare ulteriori conseguenze del reato, fornendo un aiuto concreto all’autorità di polizia o giudiziaria per raccogliere prove decisive, ricostruire i fatti e individuare o catturare uno o più autori di reati;
- evitare che vengano commessi ulteriori sequestri di minore.
Procedibilità
Nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 605 c.p, il reato è punibile a querela della persona offesa. La querela però non è necessaria se il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o per infermità. In questo caso, il reato è perseguibile d’ufficio.
Differenza tra sequestro di persona e a scopo di estorsione
Di recente la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21241 ha chiarito la differenza tra il sequestro di persona semplice rispetto a quello commesso a scopo di estorsione.
La differenza fondamentale tra il sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 del Codice Penale) e il sequestro di persona semplice risiede nel dolo specifico dell’agente, piuttosto che nell’intensità della violenza o delle minacce utilizzate. Il sequestro di persona a scopo di estorsione è caratterizzato dalla finalità specifica di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione della vittima. Questo “scopo estorsivo” è l’elemento centrale che lo differenzia dal sequestro di persona semplice.
Pertanto:
- Se il fine perseguito dall’autore è quello di far valere una pretesa illegittima, il reato configurabile sarà il sequestro di persona con finalità estorsiva.
- Se l’agente priva la persona offesa della libertà di locomozione con l’intento di conseguire, attraverso tale forma di costrizione violenta, una pretesa legittima, si dovrà ritenere integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso formale con il reato di sequestro di persona semplice.
Leggi anche: Sequestro del coniuge: ok alla procedibilità d’ufficio