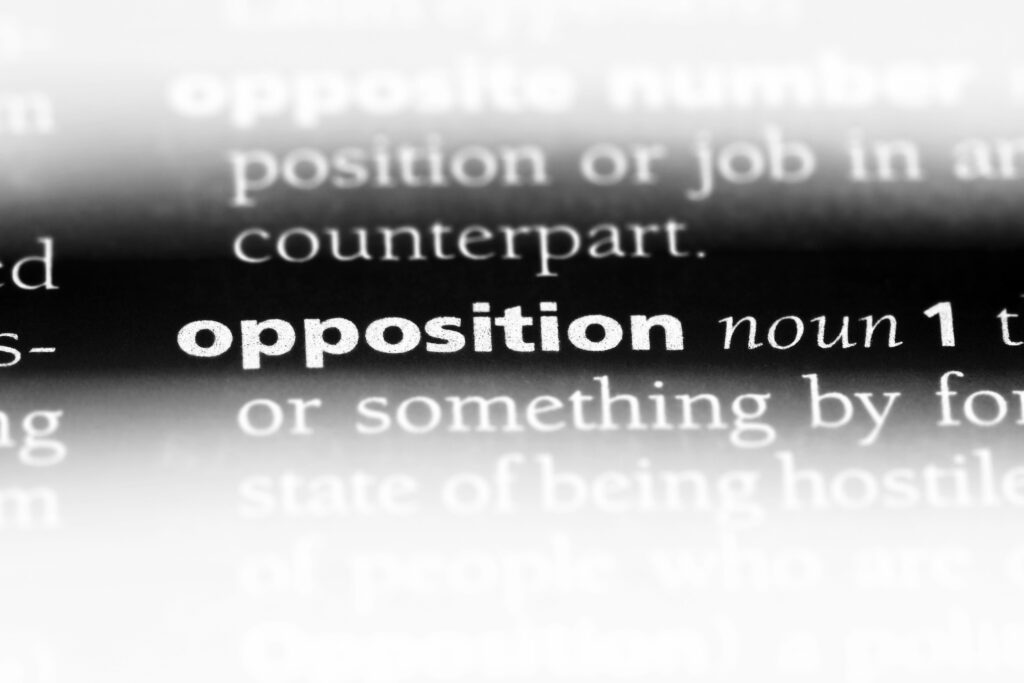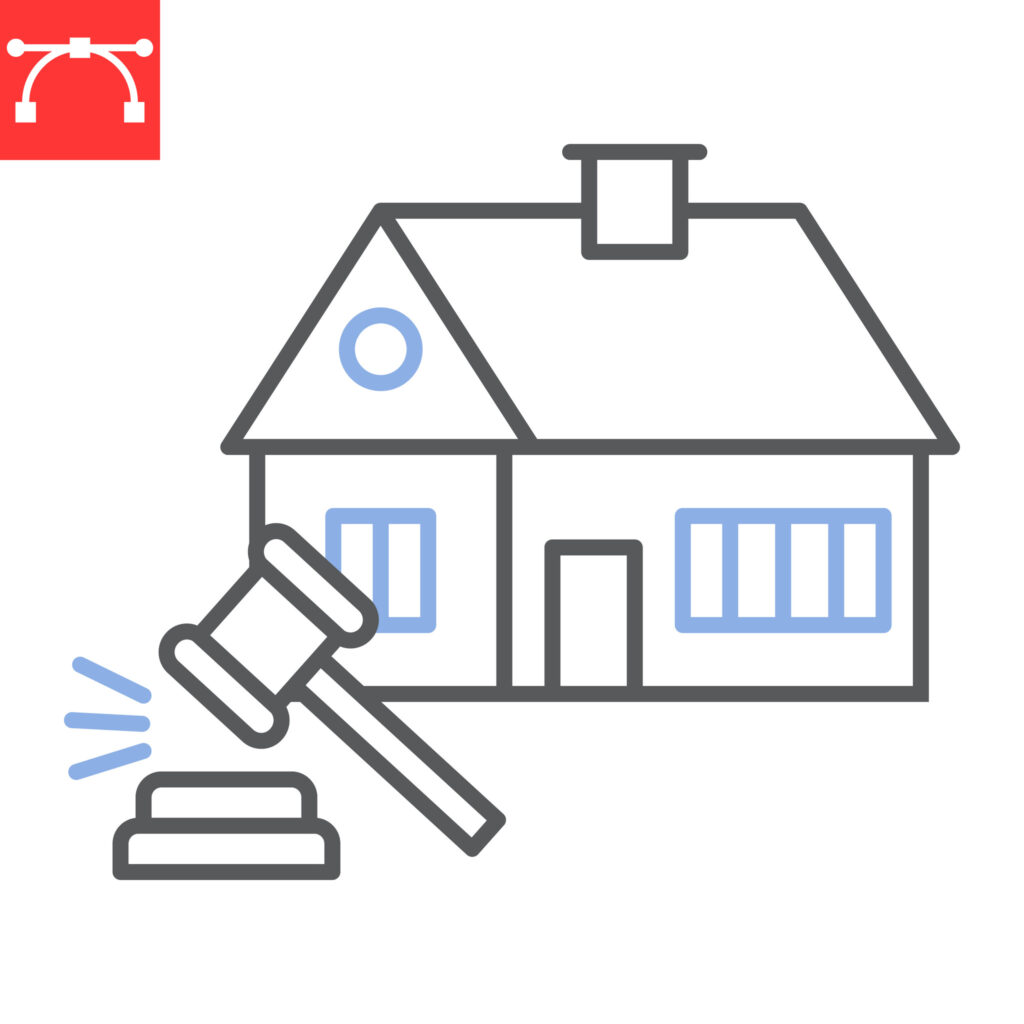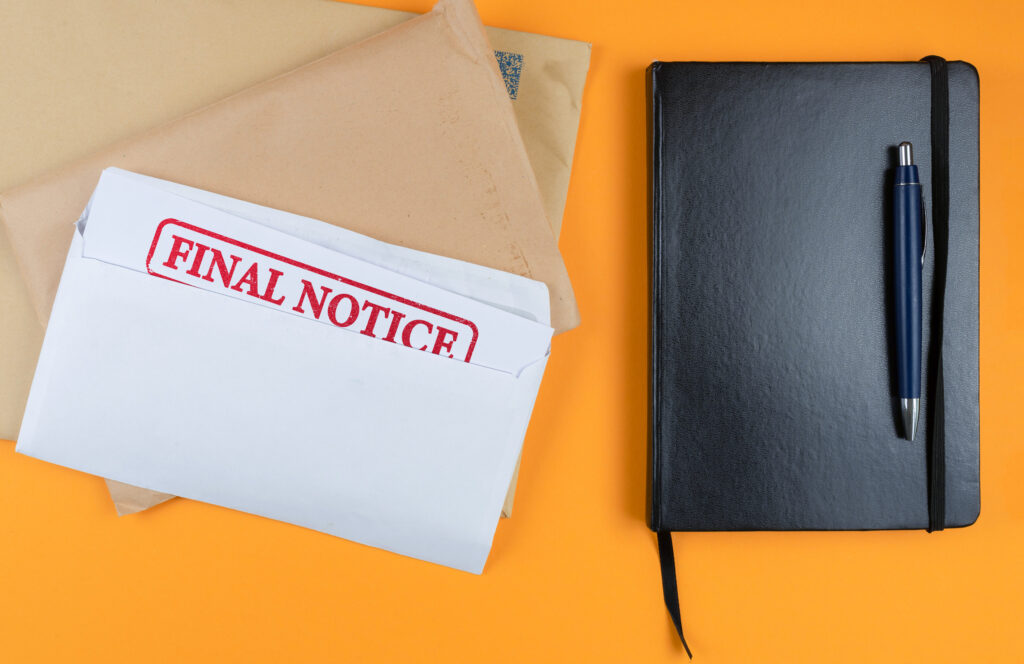Avviso di giacenza Cos’è l’avviso di giacenza, come funziona la compiuta giacenza degli atti giudiziari: guida con giurisprudenza
Cos’è l’avviso di giacenza
L’avviso di giacenza è un documento che il servizio postale lascia nella cassetta delle lettere quando non è possibile consegnare un atto o una raccomandata direttamente al destinatario. Questo avviso informa che il plico è disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale entro un determinato periodo.
Disciplina della compiuta giacenza degli atti giudiziari
Nel contesto degli atti giudiziari, la “compiuta giacenza” si riferisce al periodo dopo il quale un atto non ritirato si considera comunque notificato al destinatario.
Secondo l’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, se la consegna di un atto non può essere effettuata per irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto presso la casa comunale e ne dà comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica si considera completata quando sono trascorsi dieci giorni da quando il destinatario, non trovato al suo domicilio, ha ricevuto l’avviso di deposito dell’atto presso il comune tramite raccomandata. Trascorsi infatti dieci giorni dalla data di deposito senza che il destinatario ritiri l’atto, la notifica si considera perfezionata per “compiuta giacenza”.
È importante notare che, anche se l’atto rimane in giacenza per un periodo più lungo (fino a 180 giorni per gli atti giudiziari), gli effetti legali della notifica si producono al decimo giorno dalla data di deposito.
Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 8895/2022 sancendo il seguente principio: In materia di notifiche di atti tributari tramite servizio postale, la validità della notifica è garantita anche in caso di assenza del destinatario. Se il postino non trova il destinatario a casa infatti lascia un avviso di giacenza nella cassetta postale, se poi il destinatario non ritira l’atto entro 10 giorni, la notifica si considera perfezionata. Questo vale anche se il destinatario ha ricevuto l’avviso di deposito (CAD) ma non è andato a ritirare l’atto. In questi casi, si presume che il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto, in base all’articolo 1335 del codice civile. Questo perché l’avviso di giacenza è stato consegnato all’indirizzo del destinatario, dandogli la possibilità di ritirare l’atto. La notifica quindi raggiunge il suo scopo quando l’avviso di giacenza entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. Se il destinatario sceglie di non ritirare l’atto, la notifica è comunque valida.
Come riconoscere il contenuto dell’avviso di giacenza
L’avviso di giacenza contiene informazioni utili per identificare il tipo di atto o comunicazione non consegnata. Ad esempio, il colore dell’avviso può fornire indicazioni preliminari: un avviso di colore verde è spesso associato a comunicazioni ufficiali o atti giudiziari. Inoltre, sull’avviso sono presenti codici numerici che identificano la natura del documento. Codici come 75, 76, 77, 78 e 79 indicano generalmente atti giudiziari o comunicazioni da parte di enti pubblici.
Queste informazioni permettono al destinatario di avere un’idea del contenuto della comunicazione e dell’ente mittente.
Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza ha più volte affrontato il tema della “compiuta giacenza” e degli effetti della notifica:
Cassazione n. 31724/2019: Se uno degli adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c. viene omesso, la notificazione è nulla, ma può essere sanata se raggiunge comunque il suo scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Ciò vale anche quando il destinatario riceve l’avviso di raccomandata riguardante il deposito del plico presso l’ufficio postale, ma decide di non ritirarlo, facendo scattare la compiuta giacenza. Tuttavia, la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c può essere superata solo se il destinatario dimostra di essere stato, senza sua colpa, impossibilitato a prendere visione dell’atto.
Cassazione n. 32201/2018: Nella notificazione a destinatario irreperibile ex art. 140 c.p.c., l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa non deve necessariamente attestare la consegna o la scadenza del termine di giacenza, né contenere tutte le annotazioni previste per le notifiche postali. Tuttavia, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, deve emergere l’eventuale trasferimento, decesso o altro impedimento che renda l’avviso non conoscibile dal destinatario.
Leggi anche gli altri articoli di diritto civile