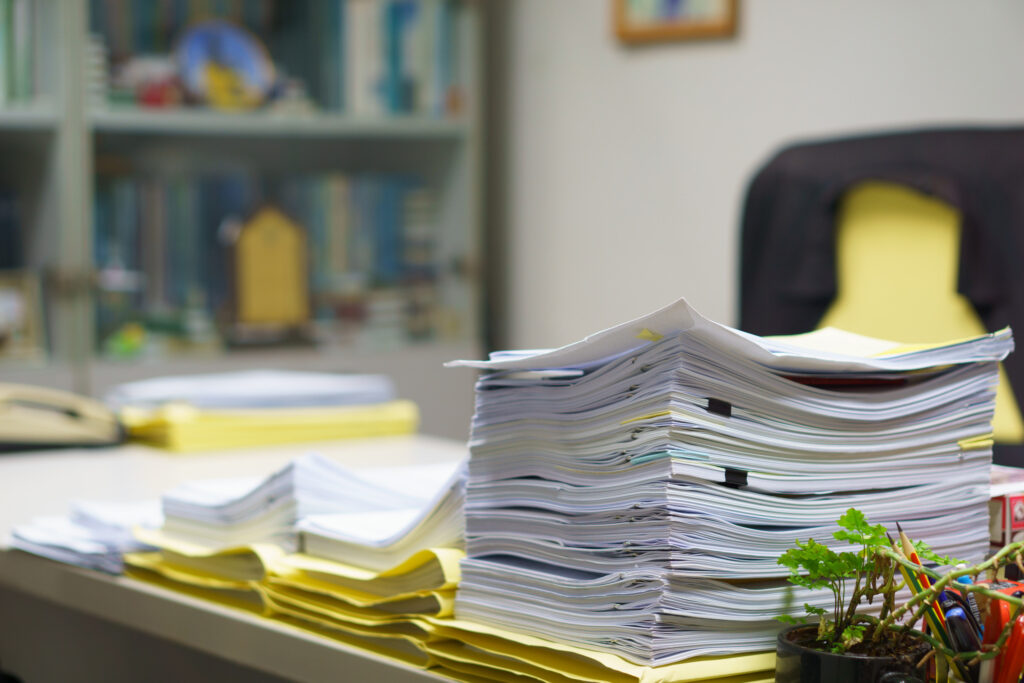La conferenza di servizi La conferenza di servizi: istituto di semplificazione dell’attività amministrativa, tipologie e modalità decisorie
Cos’è la conferenza di servizi
La conferenza di servizi è un istituto giuridico di diritto amministrativo finalizzato a semplificare l’attività della pubblica amministrazione.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento base della conferenza di servizi è la legge n. 241/1990, riformata nel corso degli anni da numerosi interventi legislativi, tra i quali occorre segnalare:
- la legge n. 15/2015, che ha previsto l’opzione di svolgere le conferenze di servizi in modalità telematica;
- la legge Madia n. 124/2015, attuata dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2016, che ne ha riformato la disciplina.
Conferenza di servizi: tipologie
L’art. 14 della legge n. 241/1990 contiene la disciplina di diverse conferenze di servizi:
- la conferenza di servizi istruttoria;
- la conferenza di servizi decisoria;
- la conferenza preliminare.
Analizziamo in breve le diverse tipologie di conferenze di servizi
Conferenza di servizi istruttoria
La conferenza di servizi istruttoria può essere convocata dall’amministrazione che gestisce il procedimento, o su richiesta di un’altra amministrazione o di un privato, quando lo ritenga necessario. L’obiettivo principale è quello di esaminare contemporaneamente gli interessi pubblici che rientrano in uno o più procedimenti amministrativi collegati tra loro, che riguardano le stesse attività o risultati. La conferenza può seguire le procedure stabilite dall’articolo 14-bis (conferenza semplificata). L’amministrazione che la indice può però anche definire modalità diverse per il suo svolgimento.
La conferenza di servizi decisoria
La conferenza di servizi decisoria viene sempre indetta dall’amministrazione che gestisce il procedimento quando, per concluderlo positivamente, è necessario ottenere l’approvazione (come pareri, intese, nulla osta) da parte di diverse amministrazioni o gestori di servizi pubblici. Se un’attività privata richiede più autorizzazioni che devono essere rilasciate al termine di diversi procedimenti, gestiti da varie amministrazioni, la conferenza di servizi può essere convocata da una qualsiasi delle amministrazioni coinvolte, anche su richiesta dell’interessato.
La conferenza do servizi preliminare
Per progetti complessi o insediamenti produttivi, l’amministrazione può convocare una conferenza preliminare, su richiesta motivata dell’interessato e con uno studio di fattibilità. Questa conferenza serve a indicare al richiedente le condizioni per ottenere tutti gli atti di assenso necessari prima di presentare la domanda o il progetto definitivo. L’amministrazione, se accetta la richiesta, indice la conferenza entro cinque giorni lavorativi. Questa conferenza si svolge secondo l’articolo 14-bis (semplificata), ma con termini dimezzati. Le amministrazioni coinvolte si esprimono sulla base della documentazione fornita. Le determinazioni vengono trasmesse al richiedente entro cinque giorni dalla scadenza del termine.Dopo la preliminare, l’amministrazione indice la conferenza simultanea sul progetto definitivo. Le decisioni prese nella preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di nuovi elementi significativi emersi successivamente. Per opere pubbliche, la conferenza preliminare si esprime sul progetto di fattibilità per definire le condizioni per gli assensi sul progetto definitivo.
Conferenze di servizi decisorie: modalità di svolgimento
Le conferenze di servizi decisorie si possono svolgere principalmente in due modalità.
Conferenza semplificata
La conferenza decisoria si svolge generalmente in forma semplificata e asincrona (art. 14 bis legge n. 241/1990). L’amministrazione la indice entro cinque giorni dall’avvio del procedimento o dal ricevimento della domanda, comunicando alle altre amministrazioni l’oggetto, la documentazione e i termini. Le amministrazioni coinvolte hanno un termine perentorio, massimo 45 giorni (o 90 per enti di tutela ambientale, paesaggistica, culturale o sanitaria), per esprimere il proprio parere motivato, in termini di assenso o dissenso, indicando eventuali modifiche necessarie. La mancata risposta o una risposta incompleta equivale ad assenso incondizionato. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini, l’amministrazione procede con la determinazione finale. Se ha ricevuto solo assensi (anche impliciti) o se le condizioni possono essere accolte senza modifiche sostanziali, la conferenza si conclude positivamente. In caso di dissensi insuperabili, la conferenza si chiude negativamente, respingendo la domanda. In casi complessi o su richiesta, si può optare per una riunione sincrona.
Conferenza simultanea
La prima riunione della conferenza di servizi simultanea e sincrona (art. 14 ter legge 241/1990) si tiene nella data prestabilita, anche in teleconferenza, con i rappresentanti delle amministrazioni competenti. I lavori si concludono entro 45 giorni (90 per questioni ambientali, paesaggistiche, culturali o sanitarie), rispettando il termine finale del procedimento. Ogni ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto con potere decisionale vincolante. Per le amministrazioni statali, un singolo rappresentante, nominato dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto, esprime la posizione di tutte le amministrazioni statali, potendo essere supportato da personale delle singole amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali definiscono in modo del tutto autonomo le modalità per indicare il rappresentante unico. Gli interessati possono essere invitati alle riunioni. Al termine dell’ultima riunione, entro i termini stabiliti, l’amministrazione procedente adotta la determinazione finale basandosi sulle posizioni prevalenti. L’assenso è considerato acquisito anche se un rappresentante non partecipa, non esprime una posizione o esprime un dissenso immotivato o non pertinente. Quando un progetto richiede la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, tutte le autorizzazioni e gli assensi necessari per realizzarlo ed esercitarlo vengono ottenuti tramite un’apposita conferenza di servizi sincrona, come stabilito dall’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
Leggi anche gli altri articoli di diritto amministrativo