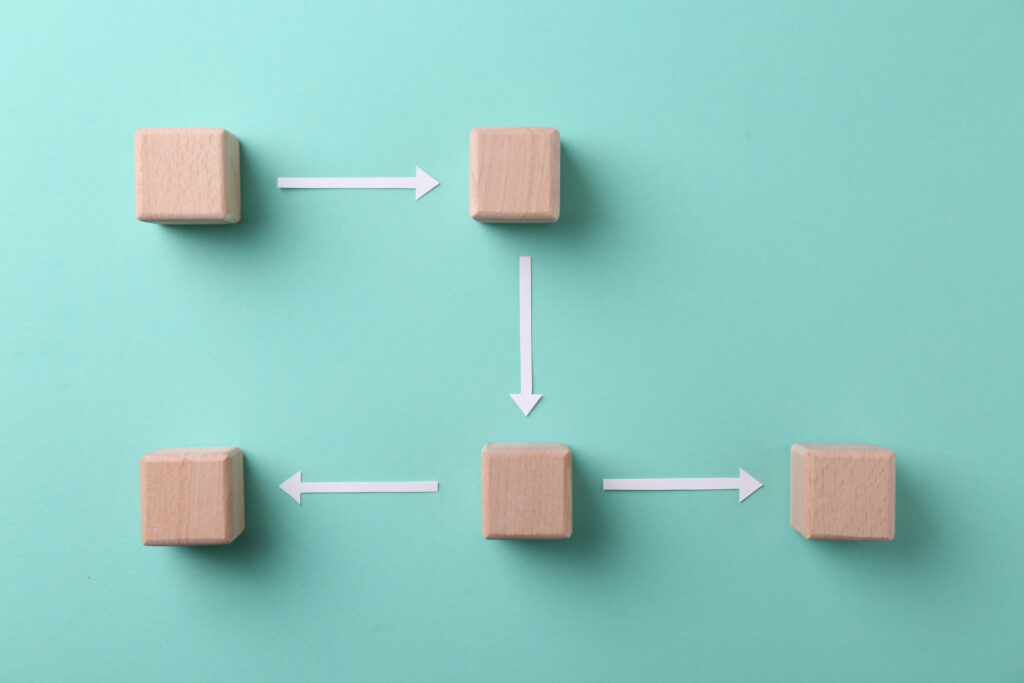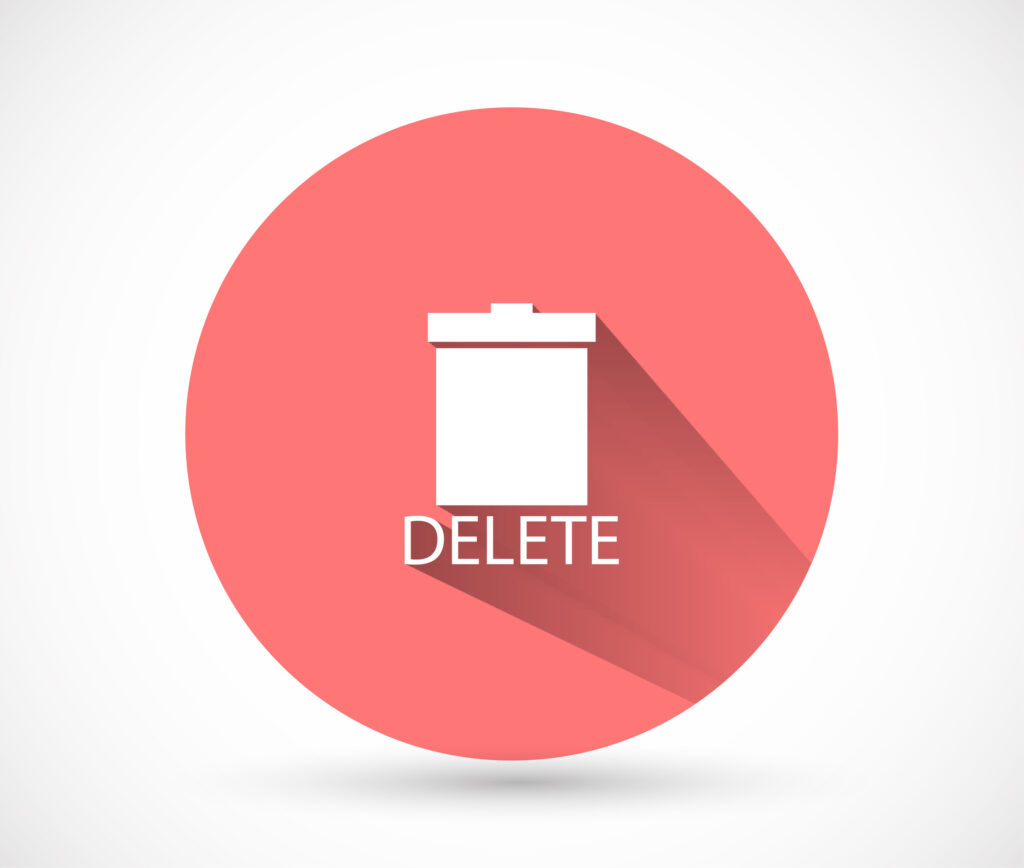Vaccino anti-HPV: la Consulta legittima la legge della Puglia Per la Corte, la legge della Puglia sul vaccino anti-papilloma virus non viola la Costituzione
Vaccino anti-HPV e percorsi scolastici
Vaccino anti-HPV: con la sentenza n. 48 del 2025, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’articolo 1 della legge della Regione Puglia n. 22/2024, che ha introdotto l’articolo 4-bis nella legge regionale n. 1/2024. Tale disposizione stabilisce che, per accedere ai percorsi formativi nella fascia 11-25 anni, inclusi quelli universitari, è necessario presentare una delle seguenti documentazioni alternative:
-
Attestazione della somministrazione del vaccino contro il Papilloma Virus Umano (HPV);
-
Certificazione dell’avvio del programma vaccinale;
-
Dichiarazione di rifiuto della vaccinazione;
-
Partecipazione a un colloquio informativo sui benefici del vaccino;
-
In alternativa, è possibile esprimere un “formale rifiuto” di produrre qualsiasi documento.
La Consulta conferma la legittimità della norma
Il ricorso era stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che contestava la norma regionale per presunta violazione della competenza statale esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” e di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi ai diritti civili e sociali, in base all’articolo 117, secondo comma, lettere n) ed m) della Costituzione.
Venivano inoltre richiamati presunti contrasti con:
-
Gli articoli 3 e 34 della Costituzione (principio di uguaglianza e diritto all’istruzione);
-
L’articolo 117, primo comma, in relazione all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per il trattamento dei dati personali sanitari.
La Corte ha però dichiarato inammissibile la questione relativa ai LEP per insufficienza della motivazione, e ha ritenuto non fondate le altre censure.
Promuovere la consapevolezza vaccinale
La Consulta ha riconosciuto la legittimità della legge regionale pugliese in quanto esercizio coerente delle competenze concorrenti in materia di tutela della salute e istruzione, previste dalla Costituzione. Il provvedimento non introduce un obbligo vaccinale vero e proprio, ma mira a promuovere la vaccinazione anti-HPV o, almeno, a favorire una scelta informata da parte degli studenti e delle famiglie.
L’obiettivo è quello di stimolare la riflessione consapevole, senza imporre in modo coercitivo la presentazione di attestati sanitari. Viene, infatti, espressamente prevista la possibilità di rifiutare formalmente la produzione di qualsiasi documentazione, salvaguardando così il diritto all’istruzione e il rispetto della libertà individuale.
La decisione
La Corte costituzionale ha confermato, dunque, che la normativa regionale che prevede, ai fini dell’iscrizione ai percorsi di istruzione per i giovani tra 11 e 25 anni, l’obbligo di documentare la propria posizione vaccinale rispetto al virus HPV – anche mediante un semplice rifiuto formale – è costituzionalmente legittima. La misura rispetta il principio di proporzionalità, non vìola il diritto allo studio e rappresenta uno strumento efficace per promuovere la prevenzione sanitaria in ambito educativo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.